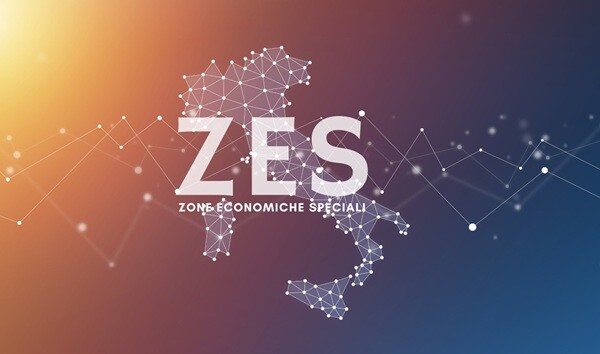Visione, governance e politiche industriali: l’Emilia-Romagna a un bivio
L’Emilia-Romagna (ER) rappresenta un caso emblematico nello sviluppo industriale italiano, in particolare per la sua capacità di valorizzare il tessuto produttivo basato su piccole e medie imprese (PMI). A differenza di altre regioni a forte vocazione manifatturiera, come il Veneto, l’Emilia-Romagna ha visto fin dagli anni Cinquanta un coinvolgimento attivo delle istituzioni locali nel sostegno allo sviluppo industriale. Questo intervento pubblico, unito a una continuità politica marcata dalla leadership della sinistra (dal PCI fino al PD), ha dato forma a un modello economico e sociale unico nel panorama italiano. Nel secondo dopoguerra, la posizione del PCI sulle PMI fu definita da Palmiro Togliatti, il quale rinnovò profondamente l’approccio della sinistra verso l’impresa privata. Togliatti riteneva che, sebbene le grandi imprese fossero più efficienti, in Italia esse spesso sfociassero in monopoli che bloccavano lo sviluppo. In questa visione, le PMI avevano un ruolo dinamico: contrastavano il potere monopolistico della grande impresa e contribuivano alla crescita economica, all’occupazione e al benessere dei lavoratori. Gli imprenditori delle PMI erano visti come alleati strategici del proletariato, funzionali al rafforzamento della democrazia e all’allontanamento delle classi medie dalla destra.
Sulla base di queste premesse, negli anni ‘50 e ‘60 il PCI promosse la creazione di organizzazioni di categoria anche per piccoli imprenditori, artigiani, commercianti e contadini. La governance locale in ER rifletteva il sistema delle alleanze sociali del partito: venivano inclusi gli attori più vicini alla classe operaia, mentre altri venivano esclusi dal processo decisionale. Prima dell’istituzione della Regione nel 1970, le politiche industriali erano gestite dai comuni e dalle province. Queste miravano a sostenere le PMI con la creazione dei “villaggi artigiani”, il potenziamento della formazione tecnica e l’accesso al credito a condizioni di favore.
A partire dalla fine degli anni ‘70, grazie agli studi di Becattini, Brusco e altri economisti, emerse una nuova visione dello sviluppo locale basata sui distretti industriali. L’ER divenne un caso da manuale: il tessuto di PMI, aggregato per filiere e territori, era capace di ottenere efficienze grazie alla specializzazione produttiva orizzontale, alla collaborazione tra imprese e alla capacità di innovare dal basso. Questa nuova visione portò, in ER, alla nascita di una politica industriale specificamente mirata alle esigenze delle PMI dei distretti industriale: la creazione dei centri di servizi reali, strutture pubbliche pensate per fornire alle PMI conoscenze e competenze difficili da reperire sul mercato. L’obiettivo era favorire l’upgrade tecnologico e organizzativo non della singola impresa, ma dell’intero sistema di imprese insediato sul territorio.
L’adozione della politica dei servizi reali implicò una svolta importante: la governance regionale si aprì a tutto lo spettro degli interessi economici. Anche le associazioni imprenditoriali precedentemente escluse (come quelle cattoliche o rappresentative delle grandi imprese) entrarono nei consigli di amministrazione dei centri di servizi, insieme a ERVET, l’agenzia di sviluppo regionale. Si affermò così un modello di concertazione neo-corporativa, basato sulla cooperazione tra istituzioni pubbliche e stakeholder privati. Questo modello portò ad una visione condivisa degli scenari evolutivi dell’economia locale e, con essa, delle politiche industriali della Regione.
Negli anni Duemila, con l’avvento della globalizzazione e della rivoluzione digitale, la competitività dei distretti venne messa in discussione. Si fece strada una nuova visione, formalizzata nel Patto per il Lavoro del 2015: il sistema produttivo regionale doveva basarsi su cluster tecnologici e filiere guidate da imprese leader (nazionali e multinazionali), più che sui distretti di PMI. Le politiche industriali si sono adeguate a questa nuova visione, con una serie di interventi strutturali: la nascita dei Tecnopoli, centri di ricerca industriale e trasferimento tecnologico (20 distribuiti su 11 città della regione); la costituzione dei Clust-ER, comunità strategiche che riuniscono imprese, sindacati e istituzioni; lo sviluppo di infrastrutture digitali, tra cui il Tecnopolo Big Data di Bologna; l’attrazione di multinazionali (come Audi e AVL Italia) e il rafforzamento delle imprese locali ad alta tecnologia; investimenti in capitale umano tramite gli ITS, master universitari co-progettati con le imprese (es. MUNER), e corsi professionali per la digitalizzazione. Tutto ciò ha permesso alla Regione di mobilitare risorse a livello europeo, nazionale e privato per sostenere il cambiamento strutturale.
I dati mostrano che l’ER è tra le regioni più resilienti d’Italia. Dopo la crisi del 2008 e le successive turbolenze (pandemia, crisi energetica), la regione ha mantenuto alte performance in termini di andamento del PIL reale, export, disoccupazione e disuguaglianze. Dal 2002, l’ER ha superato tutte le principali regioni industriali italiane per investimenti in R&S rispetto al PIL, incluso il Piemonte, storica sede della Fiat. Questo successo è in parte riconducibile alla continuità e coerenza delle politiche industriali regionali.
Nonostante i successi, emergono però anche segnali di fragilità: il calo delle numero di imprese (-7% tra 2008 e 2020), che ha colpito in particolare le piccole imprese manifatturiere di subfornitura; il ricorso diffuso a contratti precari e sottopagati, anche tra le imprese leader; lo scarso investimento nella formazione professionale da parte delle imprese; una formazione spesso standardizzata e poco legata alla riproduzione dei saperi locali; una digitalizzazione incompleta e scarsamente accompagnata da formazione adeguata; l’aumento delle disuguaglianze di reddito e ricchezza; le difficoltà nella gestione dei flussi migratori; la presenza crescente di infiltrazioni mafiose, che rappresentano un potenziale cambio nelle “regole del gioco” regionali. A questo si sono aggiunti il calo della produzione industriale che si protrae da oltre due anni e la crisi di alcuni dei comparti produttivi più importanti della regione, come l’automotive e il biomedicale.
L’ER si trova, così, a un bivio. La tenuta del sistema negli ultimi 40 anni è stata garantita da una governance neo-corporativa che, però, rischia di sfociare in un “equilibrio dinamico conservativo”. In altre parole, il cambiamento viene gestito in modo tale da non disturbare troppo gli interessi più consolidati già presenti nel processo decisionale. Per affrontare le nuove sfide (ambientali, sociali, digitali), la regione potrebbe aver bisogno di una transizione verso un “equilibrio dinamico trasformativo”: una governance realmente pluralista, aperta a nuovi attori e capace di cogliere le istanze emergenti della società. Solo così l’ER potrà continuare a essere un laboratorio avanzato di politica industriale e innovazione sociale in Europa.