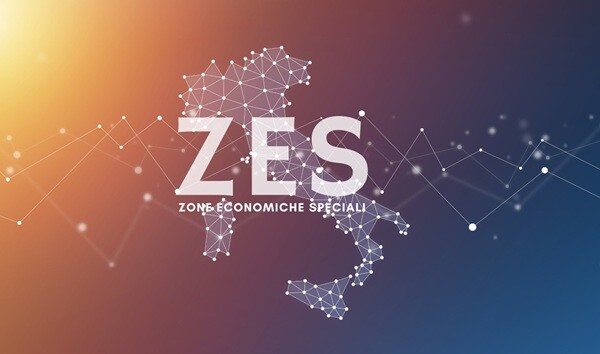Papa Francesco e i preti delle periferia (curas villeros): una pastorale dei margini
La morte di Papa Francesco ha suscitato una marea di riflessioni in tutto il mondo, ma poche sono state intense quanto quelle emerse nel suo paese natale, l’Argentina. La figura di Jorge Mario Bergoglio, primo pontefice gesuita e latinoamericano, ha suscitato passioni contrastanti, soprattutto in patria, dove la sua storia si intreccia profondamente con le “villas miseria”, le periferie urbane e i cosiddetti curas villeros. Questo articolo si propone di illuminare il legame singolare tra il vescovo di Roma eil movimento dei preti ispirati dalla teologia della liberazione. Nata negli anni ’60 in America Latina, questa prospettiva teologica si distingue per la sua praxis e lotta a favore degli oppressi, specialmente poveri e marginali.Sosteniamo che il rapporto tra Francesco e i curas villeros non abbia solo delineato una linea pastorale concreta, ma abbia incarnato un’etica cristiana profondamente trasformativa, con un impatto globale.
Per comprendere l’impronta di Francesco e il suo sostegno ai curas villeros, è necessario tornare alla fine degli anni Sessanta, quando il Movimento dei Sacerdoti per il Terzo Mondo (MSTM) fece irruzione sulla scena ecclesiale argentina. Ispirati dal Concilio Vaticano II, dalla Conferenza di Medellín e dalla nascente teologia della liberazione, circa 400 sacerdoti si impegnarono a vivere e evangelizzare tra i poveri, denunciando le ingiustizie strutturali del sistema capitalista. L’assassinio di padre Carlos Mugica nel 1974 segnò un punto di svolta nella repressione del movimento. Durante la successiva dittatura militare, il MSTM fu silenziato, ma il seme continuò a germogliare nelle nuove generazioni di pastori impegnati con gli ultimi.
Con il ritorno della democrazia nel 1983, molti sopravvissuti del MSTM ripresero il lavoro pastorale nei quartieri popolari. Già negli anni Novanta emerse una nuova generazione di sacerdoti che, pur senza costituire un movimento formale, rinnovarono la lotta a favore dei poveri e dei marginali in chiave contemporanea: icuras villeros. Questi religiosi si insediarono nelle villas, affrontando problemi come le dipendenze, la violenza strutturale, la precarietà abitativa e l’esclusione educativa, mentre sviluppavano una rete di centri di quartiere e case comunitarie. Il loro lavoro, profondamente radicato nel tessuto sociale più ferito, trovò un sostegno decisivo in Jorge Bergoglio, allora arcivescovo di Buenos Aires.
La novità dei curas villeros risiedeva anche nella capacità di tradurre il Vangelo nei linguaggi culturali vicini ai giovani emarginati. Utilizzarono la musica urbana, i murales e l’arte comunitaria come strumenti di evangelizzazione e sostegno. Non erano solo agenti pastorali: divennero punti di riferimento nei quartieri, mediatori con lo Stato, promotori di salute, educazione e cultura popolare.
Il legame di Bergoglio con i curas villeros assunse un significato di pastorale dei poveri. Partecipava personalmente a celebrazioni in parrocchie delle villas come la 21-24 di Barracas, incoraggiava la creazione di spazi di accoglienza come la “Casa de Cristo” — una rete di centri di recupero per giovani con dipendenze — e promuoveva una visione di Chiesa che abbandona il proprio confort per immergersi nelle realtà marginaldii, profondamente connessa con l’esperienza dell’esclusione urbana.
Questo impegno non fu privo di tensioni. Mentre gran parte del clero argentino manteneva un atteggiamento prudente di fronte all’avanzare della povertà strutturale, Bergoglio rafforzava una struttura pastorale alternativa, articolata a partire dai margini. Questa posizione fu vista con sospetto dai settori conservatori, che lo accusavano di populismo, ambiguità o addirittura di complicità con il kirchnerismo, a causa della sua vicinanza a esponenti dei diritti umani e del suo dialogo con le organizzazioni sociali. Tuttavia, il suo sostegno ai curas villeros non era dettato da affiliazioni partitiche, bensì da una convinzione teologica: il volto di Cristo si manifesta nei rifiutati della storia.
Allo stesso tempo, l’allora cardinale di Buenos Aires era ben consapevole delle tensioni tra la gerarchia e le basi. Seppe navigare le acque di una Chiesa divisa, scommettendo su una pastorale d’inclusione senza scontrarsi apertamente con i settori più istituzionali. Questa abilità gli permise di sostenere i curas villeros senza isolarsi dal resto della Conferenza Episcopale Argentina, consolidando un modello ecclesiale più aperto.
Il pontificato di Francesco e l’universalizzazione dell’etica delle periferia. Con la sua elezione a Papa nel 2013, Bergoglio proiettò su scala mondiale quell’etica delle periferie che aveva coltivato a Buenos Aires. L’espressione “una Chiesa povera per i poveri” divenne il faro del suo pontificato. Encicliche come Evangelii Gaudium (2013) e Laudato Si’ (2015) ampliarono lo sguardo: la prima denunciava “l’economia che uccide” e la “globalizzazione dell’indifferenza”; la seconda integrava ecologia e giustizia sociale in una nozione di “ecologia integrale” con una forte impronta latinoamericana.
Durante i suoi viaggi pastorali, Francesco diede priorità ai paesi del Sud globale: visitò quartieri marginali nelle Filippine, favelas in Brasile, campi profughi a Lampedusa e comunità indigene in Canada e Bolivia. In tutti i casi, ribadì che “la periferia non è solo un luogo geografico, ma una categoria teologica”.
A differenza dei suoi predecessori, Francesco non centrò la sua azione sulla Curia romana né sulle élite religiose. Scelse invece una pedagogia fatta di gesti semplici — viaggi nei campi profughi, udienze con vittime di tratta, visite nelle carceri — che trasmettessero il messaggio di una Chiesa in contatto con la realtà degli esclusi. La sua insistenza sull’“andare incontro”, “ascoltare le periferie” e “creare una cultura della cura” rispondeva a una logica pastorale radicata nell’azione quotidiana dei curas villeros.
Sostenendoli dalla sede di Pietro, il Papa elevò la loro prassi a modello ecclesiale. Invece di relegarli alla marginalità, li rese protagonisti di una proposta di Chiesa. Così, i curas villeros passarono dall’essere figure scomode nella struttura ecclesiastica argentina a simboli di una pastorale che il Vaticano cominciò a legittimare e perfino promuovere in altre regioni del mondo. Oggi, esperienze simili fioriscono nei quartieri popolari di Roma, Nairobi o Manila, ispirate direttamente dall’esempio argentino.
La morte di Francesco ha riacceso le tensioni all’interno della Chiesa. Settori conservatori — incluse figure dell’Opus Dei o sostenitori di un modello ecclesiale più clericale e normativo — hanno espresso, in modo esplicito o velato, la speranza di un “cambio di rotta” nel prossimo pontificato. In questo contesto, l’eredità di Francesco, e con essa la vitalità del paradigma villero, è oggi in discussione.
In Argentina, i curas villeros continuano la loro missione nonostante le avversità politiche ed economiche. Attualmente, due strutture principali sostengono questo impegno: il “Gruppo Nazionale di Preti per l’Opzione per i Poveri” e l’“Équipe di Sacerdoti delle Villas e dei Quartieri Popolari”. Il loro operato, pur non privo di tensioni con i governi locali o nazionali, ha dato vita a forme inedite di collaborazione con lo Stato e la società civile, dalla prevenzione delle dipendenze ai programmi educativi e sanitari. Allo stesso tempo, mantengono una postura etica ferma e coerente: denunciano le ingiustizie strutturali, difendono i migranti e rifiutano le politiche di austerità che aggravano la povertà.
Negli ultimi anni, la loro azione ha acquisito una dimensione ecumenica e interreligiosa, collaborando con comunità evangeliche, musulmane e ebraiche in progetti di integrazione sociale. Hanno inoltre sviluppato una propria pedagogia popolare, fondando scuole, centri di formazione professionale e spazi culturali che trasformano il tessuto del quartiere dall’interno.
È prevedibile che il loro protagonismo cresca in caso di un eventuale arretramento istituzionale in Vaticano. L’esperienza argentina dimostra che le periferie, quando si organizzano e conquistano una legittimità sociale, possono imprimere un ritmo etico all’intera comunità. La rete dei centri di quartiere del Hogar de Cristo — oltre 300 in tutto il paese — è un esempio concreto di questa ecclesiologia popolare che non attende soluzioni dall’alto, ma crea alternative dal basso.
Il legame tra Papa Francesco e i curas villeros va oltre la testimonianza: rappresenta una sintesi storica di un’etica incarnata nei margini. In un mondo attraversato da indifferenza, esclusione e fondamentalismo, questa esperienza argentina offre un’alternativa fondata sull’ascolto, la prossimità e l’azione trasformativa. Che questa pastorale delle periferie sia giunta al cuore stesso del cristianesimo è uno dei maggiori lasciti di Francesco. La domanda che oggi si apre è se la Chiesa, e il mondo, sapranno custodire e rinnovare quella fiamma accesa nei quartieri dimenticati di Buenos Aires.
Papa Francesco, il vescovo di Roma, il cardinale di Buenos Aires, il provinciale gesuita, lo stratega politico, il teologo, il predicatore della parrocchia della Virgen de los Milagros de Caacupé nella villa 21-24 di Barracas, la voce al telefono della parrocchia della Sagrada Familia nella Gaza bombardata, il peronista dei gesti, il passeggero della metropolitana di Buenos Aires, il tecnico chimico, il vicino di Flores Sur, il tifoso del San Lorenzo, il portavoce di un credo umanista in tempi in cui la crudeltà si è fatta bandiera, o Jorge Bergoglio, come fu chiamato nel 1936, non è più in questo mondo. Rimane la sua parola, che è ciò che sta all’inizio e alla fine.
P.S. La scelta di Papa Leone XIV è stata accolta dalla Conferenza Episcopale Argentina come un’affermazione e una continuità della pastorale di Francesco, celebrando l’approfondimento del cammino sinodale e l’opzione preferenziale per i poveri. La stampa argentina ha evidenziato la sua nomina come un evento storico e un segnale di continuità con l’eredità di Francesco, sottolineandone la vicinanza all’America Latina.