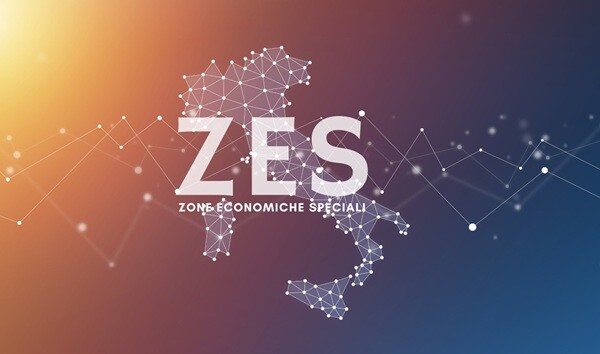Orientarsi tra interessi, idee e potere: i suggerimenti di Rodrik e Krugman
La nostra prima ‘Lettura trasversale’ è dedicata ai contributi di due importanti economisti comparsi recentemente su Project Syndicate e Substack e che abbiamo provato a leggere avendo in mente 3 parole chiave: idee, interessi e potere. I due economisti sono Dani Rodrik e Paul Krugman che abbiamo scelto perché gettano luce sui meccanismi che possono portare le idee di alcuni– spesso sostenute dalle narrative e attraverso meccanismi più o meno ‘sottili’- a imporsi, e a convincere , anche chi potrebbe veder danneggiati i propri interessi dall’applicazione di quelle idee.
Rodrik scrive: «La capacità di plasmare la visione del mondo e le ideologie – sia delle élite che dei semplici elettori – è un’arma potente. Chi la possiede può persuadere le persone a compiere scelte che sembrano in contrasto con i loro interessi economici».
La ragione principale per cui ciò può accadere è che «gli interessi stessi, economici o di altro tipo, sono plasmati dalle idee. Per capire se una determinata politica ci porta vantaggi o svantaggi, dobbiamo sapere come si concretizzerà nella realtà e anche cosa succederebbe in assenza di tale politica. Pochi di noi hanno la capacità o la propensione a capirlo. Le ideologie offrono scorciatoie a processi decisionali così complessi».
E fornisce utili esempi al riguardo: «Alcune di queste ideologie assumono la forma di storie e narrazioni su come funziona il mondo. Un politico di destra, ad esempio, potrebbe affermare che “l’intervento del governo si ritorce sempre contro” o che “le università d’élite producono conoscenze egoistiche e inaffidabili”».
Rispetto a queste considerazioni possiamo introdurre Krugman, il quale ci dice qualcosa di rilevante per comprendere più in generale che ideologie di questo tipo possono, grazie al loro successo, permettere anche di occultare i reali scopi di talune politiche. Più esplicitamente si può presentare una politica come diretta a conseguire uno scopo coerente con una ideologia di successo mentre in realtà lo scopo perseguito è tutt’altro. Dunque, si accettano inconsapevolmente, in questo caso, politiche contrarie ai propri interessi perché si è indotti a ritenere che essi non verranno toccati o danneggiati. Krugman è interessato a un caso specifico, mentre Rodrik ci consente di generalizzare quanto egli afferma.
Il caso è quello dei tagli alla ricerca effettuati recentemente dall’amministrazione Trump ed in particolare quelli alla NOAA, l’agenzia che si occupa di previsioni metereologiche e condizioni oceaniche ed atmosferiche. Questi tagli sono stati presentati – anche con il contributo dei mezzi di comunicazione – come motivati dall’obiettivo di ridurre le spese federali e quindi possono apparire ‘normali’ e giustificati alla luce della diffusa convinzione (o ideologia) che quei tagli siano necessari per contenere il debito pubblico che servirebbe al bene di tutti. Tuttavia Krugman, basandosi anche su un’analisi di Cutler e Glaeser, sostiene che quei tagli avranno in realtà effetti tali da provocare aumenti in altri costi di entità tale che l’effetto netto sul bilancio pubblico sarà negativo. Il vero scopo sarebbe dunque un altro; quello di ostacolare l’attività di ricerca e di farlo in un ambito al quale il governo americano è molto sensibile. Infatti, la ricerca potrebbe fornire prove ed evidenze della inconsistenza delle tesi ‘tranquillizzanti’ rispetto al cambiamento climatico, tesi che largamente rispondono a precisi interessi. Di certo sarebbe assai meno efficace una ipotetica narrativa alternativa, come potrebbe essere quella che punta a sostenere che le spese per la ricerca sono uno spreco perché già sappiamo tutto sul clima e dintorni.
Dunque, dai due contributi emergono chiaramente almeno due modalità con le quali la costruzione di narrative può favorire l’affermarsi di un potere di carattere persuasivo (del quale il Menabò si è occupato discutendo le tesi al riguardo di Acemoglu e Johnson). La prima è quella che abbiamo appena discusso dando conto del contributo di Krugman: consiste nell’occultare i reali obiettivi ed effetti di politiche che servono specifici interessi e che avrebbero molti ‘avversari’ se i loro effetti sui propri interessi fossero correttamente percepiti.
La seconda è implicita nella tesi di Rodrik e, con le sue stesse parole, può essere così espressa: «il concetto stesso di “interesse personale” si basa su un’idea implicita di chi sia il “sé”: chi siamo, in quanto distinti dagli altri, e qual è il nostro scopo. Queste idee non sono fisse per natura o innate alla nascita. Una tradizione alternativa nell’economia politica considera gli interessi come socialmente costruiti piuttosto che determinati da circostanze materiali. A seconda che ci identifichiamo come “maschio bianco”, “classe operaia” o ‘evangelico’, ad esempio, vedremo i nostri interessi in modo diverso. Come direbbero i costruttivisti, “l’interesse è un’idea”. E questo può essere sfruttato per condizionare comportamenti e decisioni, esercitando così, in una forma particolarmente insidiosa, il potere».
Tutto ciò porta a chiedersi quali siano gli interventi di carattere istituzionale che possono limitare questa sorta di attacco mortale (con metodi soft) alla democrazia. La risposta non è facile, ma certo aiuterebbe, per restare in tema, una narrativa persuasiva, come quelle di cui abbiamo detto, che portasse a pensare che “la democrazia, quella vera, è anche nel mio interesse”.
Gli oppositori di Trump (e delle destre che governano in giro per il mondo), ci dice Rodrik, «per avere successo, devono fare di più che produrre programmi politici ben disegnati per fornire benefici materiali a specifici gruppi» e, concludendo, afferma che «devono vincere la più ampia battaglia delle idee, in particolare le idee che danno forma al modo in cui gli elettori intendono chi sono e in cosa consistono i loro interessi». E devono preoccuparsi – aggiungeremmo noi – di smontare quelle idee, per lo più indimostrate e indimostrabili che, però, sembrano essere divenute senso comune e alimentano la capacità di persuasione di cui dispongono i ricchi che detengono (in prima persona) il potere politico o sono capaci di orientarlo. Idee che ingannano, anche nei particolari, con buona pace di quel che scrisse uno che di queste cose si intendeva: «Gli uomini, come che s’ingannino ne’ generali, ne’ particulari non s’ingannono». Firmato Nicolò Machiavelli (Discorsi, Libro I, cap. 47).