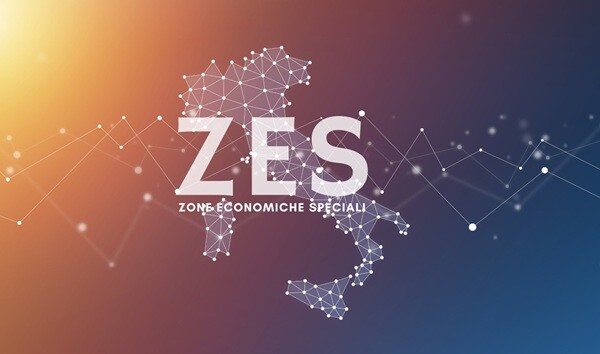L’Economia di Francesco
“Il Papa degli ultimi”. Così, Jorge Mario Bergoglio è stato celebrato in vita e, con maggior enfasi, dopo la sua morte. Dalla parte degli ultimi, Francesco è stato, sin dalla scelta, inedita nella pur millenaria storia della Chiesa, del nome per vivere il suo pontificato e testimoniarne il senso evangelico. Con gli occhi della periferia dell’Occidente il suo sguardo misericordioso ha riconosciuto gli “scarti” come fratelli: “Fratelli tutti”. Fraternità, amicizia sociale, carità, i sentimenti invocati per portare avanti una radicale trasformazione dell’ “economia che uccide”.
La portata etico-politica del suo messaggio non può essere ridotta, come è stato tentato, a innocua promozione di assistenza sociale, funzionale a sollecitare un minimo di auto-contenimento ai padroni del mondo, finito il conflitto sociale e sconfitto il lavoro come soggetto politico. Non può essere strumentalizzata per puntellare lo squilibrato e pericolante ordine economico e politico dato. La sua parola è andata controvento: radicale, instancabile, coraggiosa nella critica della Guerra, dell’Economia, della Tecnica. Si rivolgeva a tutti gli uomini di buona volontà, non soltanto ai cristiani. Metteva in connessione i pezzi. Denunciava la fase neo-liberista del capitalismo post ‘89-91. Nell’ “Evangelii gaudium” (Eg), esortazione pubblicata a pochi mesi dall’elezione a Vescovo di Roma, affermava: “Oggi tutto entra nel gioco della competitività … Si considera l’essere umano in se stesso come bene di consumo che si può usare e poi gettare” (Eg #53) … “In questo contesto, alcuni ancora difendono le teorie della ‘ricaduta favorevole’ … Si è sviluppata la globalizzazione dell’indifferenza” (Eg #54). “La crisi finanziaria che attraversiamo ci fa dimenticare che alla sua origine vi è una profonda crisi antropologica: la negazione del primato dell’essere umano” (Eg #55).
Qui sta la condanna inappellabile del mainstream: il primato dell’umano è irrinunciabile. L’antropologia liberista fondata sull’individualismo utilitaristico e la ‘libera’ concorrenza, ossia sulla massimizzazione dell’utilità individuale attraverso la relazione con l’altro affidata al mercato e alla tecnica a-morale, è insostenibile. Era antropologicamente infondato il racconto a sostegno dell’offensiva globale USA dopo la vittoria della Guerra fredda: l’ideologia de “La fine della Storia e l’ultimo uomo”, riassunta nel titolo del best seller di Francis Fukuyama, non ha piegato la realtà. “La realtà è superiore all’idea” (Eg #233). La persona si è dimostrata irriducibile a consumatore insaziabile. La prospettata pacificazione planetaria liberal-democratica è naufragata sull’antropologia, prima che sull’economia e la politica internazionale. Ha vinto la speranza.
La controffensiva di Francesco muoveva dal riconoscimento dell’insostenibilità del “nostro capitalismo”. Insostenibilità ambientale, sociale, relazionale e, in primis, spirituale: “L’essere umano, creato a immagine e somiglianza di Dio, prima di essere un cercatore di beni è un cercatore di senso. Noi tutti siamo cercatori di senso. Ecco perché il primo capitale di ogni società è quello spirituale, perché è quello che ci dà le ragioni per alzarci ogni giorno e andare al lavoro, e genera quella gioia di vivere necessaria anche all’economia. Il nostro mondo sta consumando velocemente questa forma essenziale di capitale accumulata nei secoli dalle religioni, dalle tradizioni sapienziali, dalla pietà popolare. E così soprattutto i giovani soffrono per questa mancanza di senso” (Assisi, 24/09/22).
Per guidare alla riconquista del senso dell’umano, Papa Francesco ha insistito sulla dimensione spirituale del lavoro ‘scoperta’ e praticata da San Benedetto: “il lavoro è una necessità, è parte del senso della vita su questa terra, via di maturazione, di sviluppo umano e di realizzazione personale. … aiutare i poveri con il denaro dev’essere sempre un rimedio provvisorio per far fronte alle emergenze. Il vero obiettivo dovrebbe sempre essere di consentire loro una vita degna mediante il lavoro” (Laudato si’, #128).
Nella lettura di Francesco, anche la guerra è conseguenza ultima di un’economia ingiusta. In particolare, l’agenda di warfare è scialuppa di salvataggio di classi dirigenti fallite sul welfare: “La disparità sociale genera prima o poi una violenza che la corsa agli armamenti non risolve e non risolverà mai. Essa serve soltanto a cercare di ingannare coloro che reclamano maggiore sicurezza, come se oggi non sapessimo che le armi e la repressione violenta, invece di apportare soluzioni, creano nuovi, peggiori conflitti” (Eg #60).
L’interpretazione ‘francescana’ del Vangelo è stata netta sulla subordinazione delle libertà economiche alle finalità sociali, in armonia con gli articoli 41 e seguenti della nostra Costituzione. Nell’enciclica “Fratelli tutti”, leggiamo (#109): “se la società si regge primariamente sui criteri della libertà di mercato e dell’efficienza … la fraternità sarà tutt’al più un’espressione romantica”. “Dilexit nos”, la sua ultima enciclica, si apre così: “quando siamo tentati di navigare in superficie, di vivere di corsa senza sapere alla fine perché, di diventare consumisti insaziabili e schiavi degli ingranaggi di un mercato a cui non interessa il senso della nostra esistenza, abbiamo i bisogno di recuperare l’importanza del cuore”. In sintesi, ha riproposto il nucleo economico della dottrina sociale della Chiesa: “La tradizione cristiana non ha mai riconosciuto il diritto alla proprietà privata come assoluto ed intoccabile” (#177). “L’insegnamento sociale della Chiesa esorta a riconoscere la funzione sociale di qualsiasi forma di possesso privato” (#178). Prima di lui, nella Populorum progressio, Paolo VI, sul “Capitalismo liberale”, affermava (#26): “su queste condizioni nuove della società si è malauguratamente instaurato un sistema che considerava il profitto come motore essenziale del progresso economico, la concorrenza come legge suprema dell’economia, la proprietà privata dei mezzi di produzione come un diritto assoluto, senza limiti né obblighi sociali corrispondenti”.
Insomma, Bergoglio non si è distinto per trasgressione, come argomenta chi punta a essiccare la sua semina, ma per efficacia pastorale: sulla scia dei suoi immediati predecessori fino a Leone XIII, è stato dentro l’ ‘Occidente esteso’ fonte preziosa, unica per autorevolezza personale e potenza dell’istituzione rappresentata, di pensiero critico animato da visione umanistica. In una fase di asfissiante conformismo per la neutralizzazione tecnica dei saperi, ha risvelato l’economia come scienza morale e disciplina politica.
La visione riproposta e originalmente espressa da Papa Francesco è, da sempre, avversata nel controverso e conteso territorio della cultura cattolica e degli orientamenti evangelici. Un modo, il più facile, per contrastarla è rimuoverla dalla teologia sociale: fuori gioco Bergoglio, nella discussione sul futuro della Chiesa se ne ignora il lascito, senza alcuna consapevolezza dell’urgenza storica del suo messaggio. Oppure, si punta a rinchiudere la ricerca epistemologica rianimata dall’Economia di Francesco nel recinto liberale per ‘proteggere’ l’assolutizzazione o il primato delle libertà economiche. Esemplare Luca Diotallevi (Avvenire, 30 Aprile 2025): “… la fede e la Chiesa sono per la libertà e le società aperte. … . Oggi, i regimi autoritari aggrediscono da fuori e da dentro le società libere. Tornare a cercare ‘terze vie’ [in sostanza, l’Economia di Francesco] rischia di rendere complici dei nemici delle società libere. Confermare la scelta radicale per la via della libertà consente invece di essere solerti nel riconoscere e nel correggere i limiti e gli errori con cui questa via è stata perseguita e inevitabilmente lo sarà ancora, fino all’Ultimo Giorno”.
Ma l’antropologia del Cristo è compatibile con l’antropologia liberale e liberista? L’economia politica può continuare ad essere dominata dal paradigma dis-umano della persona ridotta a individuo-consumatore senza perdere valore scientifico? L’insostenibilità empirica della regolazione neo-liberista rileva nella riflessione epistemologica? Oppure, si inverte il principio richiamato nell’Evangelii gaudium (#233) e l’idea supera la realtà?
Per cercare le risposte, Papa Francesco ha promosso ‘infrastrutture’ generative. In coerenza, con l’Esortazione del 2013, il 1 Maggio 2019, nella giornata dedicata alla dignità del lavoro, con una lettera aperta rivolta, in particolare, a giovani economisti, avviava gli incontri annuali di Assisi per l’ “Economia di Francesco”. Al primo ritrovo, così si rivolgeva ai presenti: “Voi siete chiamati a diventare artigiani e costruttori della casa comune, una casa comune che sta andando in rovina. Diciamolo: è così. Una nuova economia, ispirata a Francesco d’Assisi, oggi può e deve essere un’economia amica della terra, un’economia di pace. Si tratta di trasformare un’economia che uccide in un’economia della vita, in tutte le sue dimensioni”.
L’appello ha incominciato a dare frutti. Dal 2020, si sono svolti 4 appuntamenti internazionali. Sono coinvolti centinaia di studiosi e operatori economici e sociali di provenienze culturali e religiose diverse. Le tracce le ritroviamo, tra altre iniziative, nel “Manifesto per una nuova economia”, varato a Perugia a Giugno 2024, sottoscritto da 350 economisti, e nell’attenzione all’Economia civile.
L’elezione di Robert Francis Prevost alla successione di Pietro e la scelta del neo-pontefice di chiamarsi “Leone”, come il Papa della prima enciclica sociale (1891), sono interpretate come segnali di continuità con l’Economia di Francesco. La “Rerum novarum” portava la Chiesa di Roma “dentro e contro” la modernità del capitalismo imperante e la temuta alternativa socialista. In sostanza, apriva la prima versione di quella prospettiva “terza” invisa al cattolicesimo liberale. Ma, a differenza di allora, oggi, in Occidente, è rimasto soltanto il cuore di Cristo a ispirare la rianimazione dell’umanesimo.