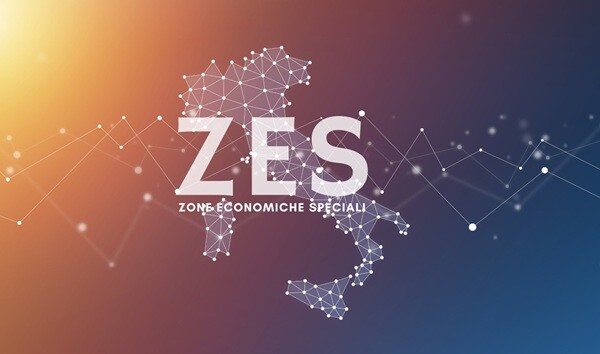L’ecologia integrale: i veri problemi di un grande progetto
Abbiamo un grande bisogno, e per svariate ragioni, di tutto ciò che ci aiuti a comprendere, o a meglio comprendere, l’importanza, e la straordinaria ricchezza, dell’idea stessa di un’ecologia integrale. Ma abbiamo anche bisogno di capire più a fondo le ragioni per le quali il mondo sembra andare, anzi sta andando, in tutt’altra direzione. Capirlo può essere utile anche per individuare meglio i moniti, i messaggi, le richieste e tutto ciò che può colmare le distanze tra il mondo come è e come dovrebbe e potrebbe essere. Il tema è sostanzialmente quello che Papa Francesco indicò nella Laudato sì, con queste parole:
Purtroppo, molti sforzi per cercare soluzioni concrete alla crisi ambientale sono spesso frustrati non solo dal rifiuto dei potenti, ma anche dal disinteresse degli altri. Gli atteggiamenti che ostacolano le vie di soluzione, anche fra i credenti, vanno dalla negazione del problema all’indifferenza, alla rassegnazione comoda, o alla fiducia cieca nelle soluzioni tecniche.
Su questo intendiamo ragionare, introducendo ulteriori elementi di riflessione, nella consapevolezza che siamo di fronte a un problema assai complesso. Per trattarlo ci si può concentrare su alcune cose che sappiamo dei comportamenti e degli atteggiamenti degli umani rispetto alla natura e alle questioni ambientali.
Al riguardo sono utili i sondaggi su tali atteggiamenti e comportamenti. Uno, relativamente recente, è quello che è stato condotto dalla Deloitte e ha interessato un campione di 24.000 persone in 24 paesi del Nord America, dell’Europa e dell’Asia orientale e meridionale.
Il primo risultato di interesse è che una quota molto rilevante degli intervistati – il 70% – si dichiara preoccupata per il cambiamento climatico e teme emergenze in tempi non lunghi. Questa percentuale è in leggero calo rispetto al 2021, e tra le possibili cause vi è il ‘dirottamento’ delle preoccupazioni conseguente alla pandemia e alle guerre (sul tema si veda l’articolo di E. D’Ecclesiis, E. Levi e F. Patriarca, sul Menabò)
Anche più interessante è quanto emerge da un’indagine che ha interessato 130.000 persone in 125 paesi e che è stata pubblicata sulla rivista a febbraio del 2024: l’86% è a favore di norme sociali in difesa dell’ambiente, l’89% chiede una azione politica più decisa e il 69% (dunque una percentuale inferiore, ma pur sempre altissima) si dice disponibile a contribuire con l’1% del proprio reddito personale ad azioni in difesa dell’ambiente.
Sul tema dei costi che si è disposti a sostenere per l’ambiente anche l’indagine della Deloitte offre indicazioni. Il 70% preoccupato per l’ambiente si riduce considerevolmente (a circa il 40%) quando si chiede se vi è disponibilità a sopportare i costi dell’adattamento climatico, ed in particolare ad acquistare i più costosi beni di consumo rispondenti a requisiti di sostenibilità. Quel divario è dovuto soprattutto alle dichiarazioni di coloro che percepiscono i redditi più bassi.
Da tutto ciò possiamo, con qualche forzatura, trarre una prima provvisoria conclusione: benché non siano pochissimi coloro che non si dicono preoccupati per le questioni ambientali (e per la natura) sono nettamente di più quelli che se ne preoccupano; ma molti di essi, quasi la metà, non attuano, per ragioni economiche, comportamenti coerenti con la loro preoccupazione. È evidente che rispetto a costoro il problema principale non è impegnarsi per convincerli dell’importanza dell’ambiente e della natura ma, piuttosto, metterli in condizione di superare l’ostacolo economico.
Possiamo aggiungere qualcosa su altre possibili cause di comportamenti non favorevoli alla natura da parte di chi pure è preoccupato per essa. Il riferimento è a quei casi in cui adottare individualmente comportamenti meno dannosi per la natura non ha effetti di rilievo perché questi si manifesterebbero solo se un gran numero di soggetti modificasse i propri comportamenti. In mancanza, il singolo sopporterebbe il costo del mutato comportamento e non avrebbe il beneficio del miglioramento nell’ambiente e nella natura; dunque, è razionale non sopportare il costo. Il tema è quello, ben noto agli economisti, dei limiti della razionalità individuale rispetto alla conservazione dei beni comuni.
Al riguardo è interessante un risultato riportato dal citato articolo su Nature Climate Change. Si riferisce alle opinioni degli intervistati sulla quota di popolazione che a loro parere è preoccupata per l’ambiente. Tali opinioni mostrano una netta sottovalutazione della reale entità di quella quota. Ad esempio, secondo uno studio condotto in USA nel 2022 l’opinione prevalente era che soltanto il 40% della popolazione nutrisse quella preoccupazione mentre in realtà era quasi il doppio. E vi sono diverse prove che la propria disponibilità a ‘pagare’ per l’ambiente dipende dalle aspettative sulla diffusione di comportamenti favorevoli all’ambiente. Ciò conferma quanto si è detto in precedenza sull’influenza di tali aspettative ed è in linea con quanto emerge da vari studi comportamentali: gli individui, molto di frequente, sono l ‘cooperatori condizionali’, cioè cooperare se gli altri cooperano.
Dunque, anche in questo caso il problema principale non è impegnarsi per convincere che la natura e l’ambiente sono importanti ma dare assicurazione che ‘tutti’ adotteranno i migliori comportamenti. E questo richiede un’azione collettiva che chiama principalmente – ma non esclusivamente – in causa l’intervento pubblico. D’altro canto, l’intervento pubblico appare necessario anche rispetto al precedente ostacolo, ed in quel caso si tratterebbe sostanzialmente di adottare provvedimenti che mitighino i costi di coloro che possiamo chiamare ‘preoccupati ma poveri’. A ben guardare il problema non è diverso da quello al quale si fa riferimento quando si afferma che la transizione ecologica deve essere equa, ma ben poco si fa perché lo sia, come prova la limitata entità e la scarsa efficacia dei fondi destinati dall’UE a questo scopo.
Veniamo ora a quel 30% che nel sondaggio della Deloitte non si dichiara preoccupato. Alla base di questa non preoccupazione possono esservi due cause, che sinteticamente denoto come ‘idee’ e ‘interessi’. Le idee – che rimandano ai valori individuali e alle informazioni in cui si crede – possono facilmente essere del tipo: si esagera, non vi è di che preoccuparsi, soprattutto per l’uomo. Gli interessi sono, ovviamente, in primo luogo quelli di coloro che si arricchiscono con il degrado della natura e dell’ambiente nelle varie forme possibili. Un ovvio esempio è quello delle gigantesche imprese del Big Oil con i loro interessi nel fossile che sono di entità stellare se solo si considerano i cosiddetti stranded assets(investimenti incagliati), cioè gli investimenti effettuati per raggiungere gas e petrolio che perderebbero totalmente valore se le fonti energetiche fossero altre. Insistere sull’importanza della natura, con costoro, non servirebbe a molto mentre potrebbe avere qualche effetto su chi nutre idee che non alimentano preoccupazione.
In conclusione, per procedere verso un mondo che si avvicini al modello dell’ecologia integrale appare indispensabile preoccuparsi non solo di rafforzare e diffondere l’idea che sottende quel modello ma anche di spingere ad attuare misure che riducano i costi individuali dei cambiamenti, favoriscano l’azione collettiva e contrastino gli interessi (potenti) di chi si arricchisce ai danni dell’ambiente e della natura. E sono tutte misure di pertinenza primaria dell’intervento pubblico (ognuna di esse poco o male applicata): redistributive, di indirizzo e coordinamento, di imposizione di leggi e sanzioni.
Seguendo questa logica si giunge alla conclusione che il comportamento che deve cambiare è soprattutto quello delle classi politiche e ciò porta a chiedersi perché, invece, non cambi. Anche qui sono possibili diverse ipotesi: i politici hanno in prevalenza idee sbagliate, i politici sono troppo ‘sensibili’ agli interessi dei potenti non preoccupati e questo anche perché la pressione dell’opinione pubblica è troppo debole, in un inquietante contesto di perdita di incisività dei processi di decisione democratica.
Si delinea, quindi, e non sorprendentemente, un quadro di grande complessità che non ammette soluzioni semplici e che di sicuro non può essere risolto positivamente limitandosi a perseguire l’obiettivo di ‘convincere’ il più gran numero di umani perché cambino i propri comportamenti individuali.
Per fare un solo esempio sarebbe molto importante che chi ha il potere di decidere spodestasse il PIL dal ruolo di indicatore supremo del benessere che occupa da tempo, e immeritatamente per i suoi numerosi e accertati limiti, peraltro già ben chiari a chi lo ha ‘inventato’ negli anni ’30, Simon Kuznets. Non mancano le proposte di indicatori alternativi al PIL. Nessuna, ovviamente, è perfetta –soprattutto restano opinabili le modalità di misurazione di variabili estremamente complesse – ma alcune appaiono meno imperfette di altre e certamente meno del PIL, che si avvale di una consuetudine di calcolo che nasconde l’opinabilità delle valutazioni richieste e per di più conduce a molti esiti dannosi.
Un’alternativa che ha ricevuto ampio consenso dalle istituzioni internazionali è la ‘ricchezza inclusiva’ che tiene conto non soltanto del capitale fisico, di quello umano (le competenze e conoscenze della popolazione) e di quello sociale (l’estensione di relazioni e reti sociali), ma anche del capitale naturale la cui conservazione dovrebbe essere un tratto caratterizzante dell’ecologia integrale. Adottare un indicatore di questo tipo avrebbe l’effetto di indirizzare diversamente le politiche sottraendole all’imperativo del PIL oggi dominante. Salvaguardare il capitale naturale inciderebbe direttamente sulla misura del benessere e non soltanto indirettamente per i suoi eventuali effetti sul PIL. E se sostituisse interamente il PIL, per fare un esempio un po’ paradossale, invece del rapporto debito/PIL che tanto ci condiziona avremmo quello tra debito e ricchezza inclusiva con la conseguenza che, se il capitale naturale migliora, il denominatore cresce e il rapporto si riduce. La natura ci aiuterebbe anche in questo.
In conclusione, si può affermare che l’ecologia integrale ha bisogno di istituzioni in grado di contrastare quel potere economico che non teme il degrado della natura e si tratta essenzialmente di istituzioni che caratterizzano una democrazia ben funzionante. Ma nelle condizioni oggi prevalenti schierarsi per l’ecologia integrale vuol dire coltivare la speranza, intesa – nelle felici parole di Vaclav Havel, il poeta presidente della repubblica ceca – “come capacità di lavorare non per qualcosa che ha necessariamente probabilità di successo ma per qualcosa che è buona in sé”. E però è difficile rassegnarsi all’idea che qualcosa buona in sé non abbia successo.