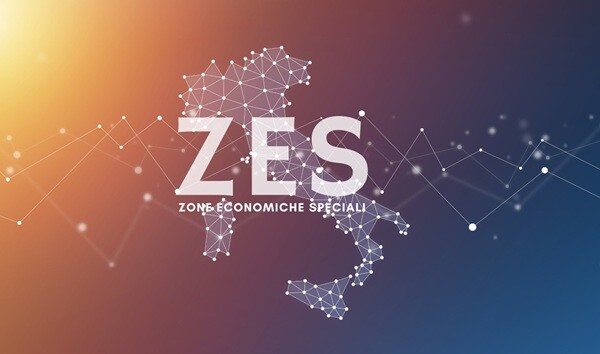Le performance universitarie delle ragazze nei corsi STEM: il ruolo dell’interazione di genere con i docenti
I divari di genere nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) emergono già a partire dalla scelta dei corsi di studio universitari, per poi estendersi alla performance accademica fino ad avere importanti ricadute in ambito di carriera e di gender pay gap.
I dati Eurostat relativi al quinquennio 2019-2023 non presentano segnali di miglioramento, e ciò vale per la gran parte dei paesi dell’UE: in Italia oltre il 36% degli uomini iscritti all’università o corsi post-laurea sceglie discipline STEM, mentre questa quota si assesta intorno al 16% per le donne. Il gap è ancora più ampio nell’aggregato UE-27, dove la quota maschile in STEM supera il 40%, a fronte di quota femminile pari a quella italiana. La maggiore partecipazione femminile all’istruzione terziaria compensa solo in parte queste differenze: in Italia le donne rappresentano solo il 37% degli iscritti a corsi di studio STEM (32% nell’EU-27).
Recenti analisi (Arellano-Bover et al., 2024; Bovini et al., 2024) hanno mostrato come la scelta del campo di studio possa spiegare porzioni rilevanti – anche sopra il 50% – del successivo gender pay gap. Alla luce della domanda crescente di competenze legate alle discipline STEM nel mercato del lavoro (CEDEFOP, 2025), tali differenze nelle scelte formative rischiano quindi di tradursi in un aggravamento delle disuguaglianze di genere.
Come sottolineato anche in un precedente contributo sul Menabò (Giovinazzo et al., 2023), diversi fattori influenzano le determinanti delle decisioni educative delle ragazze: il contesto familiare, i peers, le differenze biologiche e soprattutto gli insegnanti. Questi ultimi possono agire sia come role models, avvicinando le studentesse alle discipline STEM, sia come motore di disuguaglianze, scoraggiando le loro scelte sulla base di pregiudizi e stereotipi di genere.
Seguendo questa prospettiva, anche una volta compiuta la scelta formativa, rimane importante indagare le determinanti della performance universitaria delle ragazze nei corsi STEM, concentrandosi sul ruolo giocato dall’interazione di genere fra docente e studente.
Numerosi contributi nella letteratura scientifica hanno esplorato l’effetto di tale interazione. In un notevole lavoro di de Gendre et al. (2024) sono presenti una meta-analisi di 24 studi su studenti in istruzione primaria e secondaria ed elaborazioni proprie sui dati dei test standardizzati TIMSS e PIRLS per più di 90 paesi. Gli autori mostrano come i same-sex teacher effects siano efficaci nell’indirizzare le preferenze lavorative e nel generare fiducia e interesse verso le materie, mentre i loro effetti sulla performance rimangono contenuti. Inoltre, mentre per l’istruzione secondaria i risultati sono quasi universalmente positivi, a livello di istruzione primaria si osserva maggiore variabilità tra i paesi. Non mancano gli studi a livello di istruzione terziaria, dove i risultati indicano ancora una prevalenza di effetti positivi sulla performance e sulle scelte di disciplina e carriera (Carrel et al., 2010; Mansour et al., 2021).
La nostra analisi si basa sui dati amministrativi relativi alle carriere universitarie degli iscritti alla Sapienza nelle lauree triennali STEM tra il 2017 e il 2021. Questi dati incrociano l’informazione dello studente con quella del docente e consentono di delineare un disegno metodologico quasi-sperimentale: nei corsi del primo anno, spesso suddivisi in più “canali” per via dell’alto numero di iscritti, gli studenti sono assegnati ai diversi docenti in base all’iniziale del proprio cognome, cioè in modo esogeno rispetto alle loro caratteristiche (non si registra, quindi, una possibile autoselezione da parte degli studenti verso docenti con specifiche caratteristiche, cosa che inficerebbe l’interpretazione causale dei risultati).
La Sapienza, in quanto ateneo più grande d’Europa, è in grado di rappresentare con buona approssimazione il contesto italiano. Le ragazze costituiscono all’incirca il 40% dei 30,000 studenti triennali STEM del campione analizzato, e, data la loro maggiore propensione relativa a frequentare studi classici nel percorso scolastico, cominciano l’università con un background maggiormente umanistico rispetto a quello dei ragazzi, che provengono con maggiore frequenza dal liceo scientifico o da istituti tecnici. Come indicato in Figura 1, sebbene nel corso del primo anno la distribuzione dei voti sia simile tra studenti e studentesse, negli anni successivi si nota un marcato shift verso i voti più alti da parte delle ragazze, come ad indicare la presenza di una selezione più severa delle migliori studentesse già ad inizio carriera. L’abbandono precoce da parte delle studentesse più in difficoltà, e quindi la loro uscita dal campione, potrebbe spiegare il forte appiattimento della coda sinistra della distribuzione femminile, e la risultante concentrazione verso i voti più alti.
Figura 1 : Distribuzione delle medie aritmetiche dei voti per anno di carriera nei corsi triennali STEM – Sapienza Università di Roma
Di conseguenza, concentrarsi sul primo anno risulta particolarmente importante per almeno due ragioni. In primo luogo, i tassi di abbandono sono molto concentrati nei primi mesi di carriera: il dropout femminile nel primo anno raggiunge il 13%, a fronte del 9% dei ragazzi. In secondo luogo, in questa fase iniziale gli studenti sono maggiormente sensibili alle influenze esterne, sia di natura incoraggiante che discriminatoria, a cui sono esposti nell’ambiente universitario.
L’assetto istituzionale dei corsi canalizzati consente di ricreare un contesto prossimo a un esperimento, in cui studenti simili vengono assegnati a docenti di genere diverso in modo sostanzialmente casuale. Un semplice confronto tra corsi insegnati da donne e corsi insegnati da uomini rischierebbe di confondere l’effetto del genere del docente con quello di altre variabili, come l’autoselezione delle studentesse verso discipline insegnate più spesso da donne – dando luogo a correlazioni spurie.
Sfruttando modelli di regressione con effetti fissi a livello di insegnamento (Mengel et al., 2018; Feld et al., 2022[FD9] ) possiamo analizzare la variabilità della performance degli studenti within insegnamento – cioè between canali – dove l’unica differenza sistematica è riconducibile al docente assegnato, come confermano i test di bilanciamento delle variabili osservabili degli studenti. Di fatto, andando a confrontare gli studenti che frequentano lo stesso insegnamento in canali diversi, e che sono quindi simili – in media – in ogni caratteristica, è possibile attribuire al docente ogni variazione significativa nel rendimento in sede di esame.
Analizzando i voti degli studenti emergono differenze significative tra i canali insegnati da uomini e quelli insegnati da donne. Nei corsi insegnati da docenti uomini si osserva un gap negativo di performance delle studentesse rispetto agli studenti, pari a circa il 5% di una deviazione standard. Nei canali insegnati da donne questo gap si annulla completamente: le ragazze migliorano sensibilmente la loro performance, mentre i ragazzi non subiscono un peggioramento significativo. Risultati analoghi si osservano con riferimento alla probabilità di successo all’esame al primo tentativo, una misura che tiene conto sia del superamento dell’esame sia della posizione relativa dello studente nella distribuzione dei voti.
Oltre agli effetti immediati legati all’interazione di genere fra docente e studente, è stato possibile indagare le conseguenze di medio termine legate a una diversa composizione di genere dei docenti del primo anno tramite un approccio a variabili strumentali. Una quota maggiore di docenti donne assegnata casualmente agli studenti del primo anno, derivante dalla canalizzazione, si accompagna a una crescita significativa nella probabilità di ottenere almeno 20 CFU, un benchmark importante sia per la progressione accademica sia per l’accesso a benefici per il diritto allo studio come DiSCo Lazio (Figura 2). Tale effetto è osservabile per entrambi i generi, ma risulta più marcato per le studentesse, e persiste anche nel secondo e terzo anno di corso, pur attenuandosi nel tempo. Parallelamente, si registra una riduzione dei tassi di abbandono: i dropout rates delle ragazze cadono nei primi due anni, mentre per quello dei ragazzi si riduce solo nel primo anno (Figura 3).
Figura 2 : Effetto dell’aumento di una deviazione standard nella proporzione di docenti donne al primo anno sulla probabilità di ottenere almeno 20 CFU
Figura 3: Effetto dell’aumento di una deviazione standard nella proporzione di docenti donne al primo anno sulla probabilità di dropout
Restano ancora da indagare a fondo i meccanismi alla base di questi risultati. Nonostante diversi lavori abbiano concentrato l’attenzione sul role model effect esercitato dai docenti donna (Bettinger et al., 2005; Hoffmann et al., 2009), non bisogna escludere il ruolo potenzialmente discriminatorio giocato dai docenti di genere maschile (Carlana, 2019). L’analisi per sottocampioni evidenzia come i risultati siano più forti in presenza di docenti giovani e nei periodi di didattica in presenza, elementi che puntano nella direzione dei role model effects. Tuttavia, testimonianze qualitative raccolte da studenti e docenti dei corsi STEM sono maggiormente orientate al canale dei comportamenti discriminatori e degli stereotipi di genere. In mancanza dei dati relativi alle opinioni degli studenti, al momento non è possibile stabilire con certezza quale canale prevalga. Ma identificare il meccanismo che più incide sui risultati è fondamentale ai fini del disegno di policy efficaci nel contrastare queste disuguaglianze.
In conclusione, una maggiore presenza di docenti donne nei corsi STEM del primo anno si accompagna a migliori risultati per le studentesse nel breve termine, e nel medio periodo, oltre che a benefici di carriera accademica anche per gli studenti. Politiche che incentivino l’assegnazione di docenti donne nei primi anni di corso, unite a interventi di sensibilizzazione sul rischio di bias da parte dei docenti uomini, potrebbero rappresentare strumenti efficaci per ridurre i divari di genere e rafforzare le prospettive formative e professionali delle giovani donne in ambito STEM, riducendo al contempo la percezione stereotipata di queste discipline da parte dei giovani ragazzi.