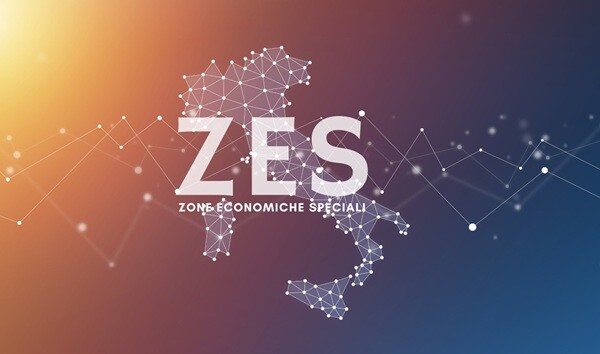La militarizzazione è la risposta errata per affrontarele attuali sfide dell’Unione Europea
Nel marzo 2025, la Commissione Europea ha presentato il ‘Libro bianco sulla difesa europea – Preparati per il 2030’, insieme a proposte per aumentare gli investimenti nella difesa. Il documento offre soluzioni per migliorare la capacità produttiva e costruire una base industriale solida in questo settore, delineando allo stesso tempo un nuovo approccio alla sicurezza europea. In questo articolo analizzerò due punti – la logica delle politiche di riarmo europeo e i fondamenti della nuova strategia europea di sicurezza e difesa – e concluderò con alcuni suggerimenti per la definizione di una futura ‘Agenda Europea’.
La logica del riarmo europeo
La lettura del Libro bianco solleva domande sulla necessità di un riarmo europeo su vasta scala. Il riferimento ad eserciti europei sottodimensionati e privi di armamenti sofisticati viene utilizzato come argomento principale per giustificare l’aumento della spesa militare. Tuttavia, un’analisi basata su fonti pubbliche (i.e., database di Global Firepower, International Institute for Strategic Studies (IISS) e ArmedForces.eu) indica che il deficit della difesa europea potrebbe non essere così significativo e in alcuni settori la forza militare dell’UE risulta comparabile con quella degli Stati Uniti, della Cina e della Russia. Anche le modalità di finanziamento proposte per il riarmo suscitano interrogativi. Da un lato, si introducono deroghe a principi di finanza pubblica europea, inserendo flessibilità nel finanziamento in deficit che in passato erano state osteggiate. Dall’altro, vengono sottovalutati i rischi derivanti dai limitati poteri di bilancio dell’autorità sovranazionale e dalle diverse concezioni di politica fiscale tra gli stati membri codificata nella contrapposizione tra i cosiddetti paesi frugali, noti per la loro rigida disciplina di bilancio ed i paesi che invece tendono a favorire una maggiore flessibilità fiscale.
Un’altra questione è come finanziare l’aumento della spesa per la difesa. Il Libro Bianco prevede di finanziare il riarmo europeo tramite debito, ma i paesi frugali si oppongono e il Trattato UE (art. 41.2 TUE) vieta l’uso del bilancio dell’UE per spese militari operative. C’è il timore che il finanziamento possa avvenire riallocando risorse destinate al settore sociale o alle politiche ambientali. Nei documenti programmatici della Commissione Europea dello scorso anno, “Difesa e Sicurezza” è solo uno degli obiettivi, insieme alla coesione sociale, alla transizione ambientale e digitale, alla sicurezza energetica e altri. Accordare priorità incondizionata alla difesa implica necessariamente stornare risorse da altri programmi, principalmente quelli volti a promuovere e consolidare la solidarietà a livello europeo.
Un ulteriore argomento che viene presentato a favore dell’aumento delle spese militari è il presunto impatto positivo sulla crescita economica europea, un’affermazione che non trova pieno consenso nella letteratura economica (si veda ad esempio la rassegna della letteratura economica sul tema in European Commission. Defence Spending in the European Union. LU: Publications Office, 2024). Inoltre, almeno nel medio termine, la dipendenza dell’Europa da fornitori non europei rappresenta un ulteriore fattore di limitazione dei benefici economici per i paesi europei. Infine, la nuova strategia presenta una lacuna significativa riguardo alla formulazione di una visione comune di politica estera europea, a cui la capacità militare dovrebbe essere subordinata.
La nuova strategia europea di sicurezza e difesa
Nel corso degli ultimi decenni, l’Unione Europea ha sperimentato un’evoluzione significativa della propria struttura istituzionale, mentre i progressi in termini di difesa comune sono stati relativamente limitati. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, la NATO ha rappresentato il principale pilastro della strategia di difesa europea, basata sull’Articolo 5 del Trattato che garantisce la difesa collettiva dei membri dell’alleanza sotto una struttura militare guidata dagli Stati Uniti. Nonostante il colpo inferto alla credibilità dell’Articolo 5 dalla corrente amministrazione statunitense, la definizione di una nuova strategia di difesa europea non può prescindere dalla valutazione del ruolo degli Stati Uniti. Molte delle strutture NATO, dalle linee di comando, all’intelligence e all’interoperabilità sono direttamente o indirettamente sotto il controllo degli Stati Uniti. In Europa c’è ancora una rilevante presenza militare statunitense, che include basi militari, truppe, comandi operativi e testate nucleari.
I policy makers europei si sono dichiarati sorpresi dalla volontà dell’amministrazione Trump di ridurre drasticamente gli impegni verso l’Europa. Tuttavia, una revisione approfondita della strategia statunitense, volta a spostare l’attenzione verso il Pacifico, l’Asia e in particolare la Cina, è in atto da diversi anni, e ha conosciuto un’intensificazione durante il primo mandato di Trump che è proseguita sotto la presidenza Biden. Gli eventi recenti hanno il merito di aver chiarito la natura a lungo termine di queste tendenze, rendendole di fatto irreversibili.
Tutto questo ha impresso una accelerazione notevole alla riflessione strategica dell’Unione Europea che era iniziata dopo la grande crisi finanziaria internazionale. La visione strategica europea si è modificata, passando da una priorità sulla ‘sicurezza economica’ a una maggiore attenzione su ‘sicurezza e difesa’. Le linee guida di questa nuova visione strategica sono allineate con quelle del G7, ben riassunte nel Comunicato della riunione di Hiroshima del maggio 2023 (G7 Leaders’ Statement on Economic Resilience and Economic Security) e con l’agenda di economia internazionale americana esposta nella stessa occasione da Jake Sullivan, il Consigliere per la Sicurezza del Presidente Biden. Queste linee guida definiscono un nuovo quadro strategico, descritto dal Financial Times come un rinnovato “Washington Consensus” (Edward Luce The new Washington consensus. Yesterday’s US economic orthodoxy is today’s heresy 19/4/2023), non più basato sull’espansione delle istituzioni di mercato ma sulla sicurezza economica, sempre più interconnessa con la sicurezza nazionale. Particolarmente significativo è il riferimento al concetto di “coercizione economica” che cerca di sfruttare le vulnerabilità e le dipendenze economiche per influenzare le politiche dei membri del G7 e dei partner globali.
La nuova strategia europea si basa sull’assunto che l’evoluzione del quadro geopolitico e il declino dell’ordine commerciale globale fondato su regole condivise a livello multilaterale abbiano indotto l’UE a rivedere le proprie politiche esterne. L’attenzione è ora rivolta alla gestione dei rischi globali con l’obiettivo di ridurre la vulnerabilità dell’UE alle politiche ostili di paesi terzi. Questo cambiamento di visione strategica è di portata fondamentale e si è realizzato in tempi relativamente brevi. Si pensi che il quadro strategico delineato nel “Report on the Implementation of the European Security Strategy” della Commissione Europea nel 2008 si basava sul rinnovo dell’ordine multilaterale, attraverso proposte di riforma delle Nazioni Unite, del G8 e delle istituzioni finanziarie internazionali. Il Rapporto faceva esplicito riferimento all’ampliamento delle relazioni con Cina e India, nonché a un nuovo partenariato con la Russia. Viceversa, sia lo “Strategic Compass for Security and Defence” dell’Unione Europea, adottato nel marzo 2022, sia la “Comunicazione sulla Strategia europea di sicurezza economica” del giugno 2023 pongono al centro della visione strategica le ‘minacce globali emergenti’, identificate in tensioni geopolitiche, guerre ibride, attacchi informatici e cambiamenti climatici, proponendo principalmente misure di controllo e restrizioni per affrontarle. In questa nuova visione strategica, l’interdipendenza economica, un tempo vista come deterrente naturale ai conflitti, si è venuta ‘militarizzando’. Risorse, infrastrutture, tecnologie e flussi commerciali possono essere utilizzati come strumenti di pressione politica ed economica per ottenere vantaggi negoziali o influenzare scelte politiche.
L’”Agenda Europea” per il prossimo futuro
La ‘militarizzazione’, sia quella legata all’imponente aumento delle spese militari, sia quella implicita in una visione strategica a ‘somma zero’, non può essere la panacea per i problemi politici, istituzionali, finanziari e strategici che caratterizzano l’Unione Europea oggi. La loro soluzione richiede un salto qualitativo nell’analisi e nella formulazione di politiche di riforma essenziali, senza le quali si corre il rischio di distruggere il contesto politico istituzionale europeo che seppure con alti e bassi ha garantito ottanta anni di pace e prosperità nel continente. Con tutti i suoi difetti, gli enormi errori politici, l’architettura istituzionale goffa e la presunta mancanza di legittimità politica, l’Unione Europea non ha alternative. Il tempo in cui piccoli stati sovrani potevano giocare un ruolo sulla scena mondiale è passato da tempo, come evidenziato dagli eventi recenti.
L’attuale architettura istituzionale e politica è antiquata e inadeguata per gestire le sfide che si prospettano e l’Unione Europea deve evolversi. La complessità di questa evoluzione sta nel riuscire a coniugare il profondo cambiamento richiesto con la necessità di preservare ciò che di positivo è stato costruito negli scorsi decenni. Ridefinire il ‘Progetto Europa’ è un compito quasi utopico ma fondamentale, ed alcuni principi sono chiari.
Prima di tutto, il nuovo progetto non può basarsi sulle promesse di ‘sudore e lacrime’ che il Presidente francese Macron ha chiamato avventatamente ‘economia di guerra’. Il keynesismo militare è un vicolo cieco, destinato a esacerbare le tensioni sociali e a far avanzare ulteriormente l’ondata fascista, neonazista e populista che abbiamo visto risorgere ed espandersi nel continente. L’Europa deve riaffermare il suo scopo originale, quello di essere un progetto di pace. Molti hanno finito per identificare l’Unione Europea con la miseria dell’austerità scaturita da regole economiche bizzarre, sostenute da ideologie immorali. Ma anche su questo si può e si deve cambiare.
Ci sono molte idee che ci possono aiutare a definire politiche economiche decenti, che possono invertire il corso di decadimento di questo continente e stimolare una crescita economica sostenibile ed equa. Ci sono modi migliori per spendere il denaro pubblico che acquistare armi. Una lista tutt’altro che esaustiva potrebbe includere investire seriamente in infrastrutture, R&S, economia circolare; ricostruire il sistema di welfare smantellato da decenni di austerità, investire nella riforma del sistema educativo, nella ricostruzione del sistema sanitario pubblico per renderlo di nuovo equo e accessibile, garantire una vita dignitosa agli anziani, riqualificare la periferia di molte città europee, e molto altro.
È importante riconoscere che la geopolitica ha fatto il suo ritorno nella riflessione strategica, ma sarebbe riduttivo vedere i nuovi equilibri come a somma zero. Il benessere di un paese o di un continente non può avvenire a discapito di un altro; una visione inclusiva è necessaria. L’Ucraina deve certamente essere aiutata a porre fine al conflitto in maniera dignitosa, a ricostruire e a vivere in pace. Ma farlo andando in guerra contro la Russia non sembra un’opzione intelligente; al contrario è tempo di riprendere a dialogare con la Federazione Russa, magari tenendo in maggior conto le lezioni del passato. Ma non occorre tirarsi indietro neanche davanti a compiti più ambiziosi quali stabilire un nuovo quadro di riferimento per i rapporti con la Cina o accreditare l’Europa come partner affidabile per molti paesi del cosiddetto ‘sud globale’.
Mi auguro che questi possano esseri i temi di un prossimo Libro Bianco della Commissione Europea.