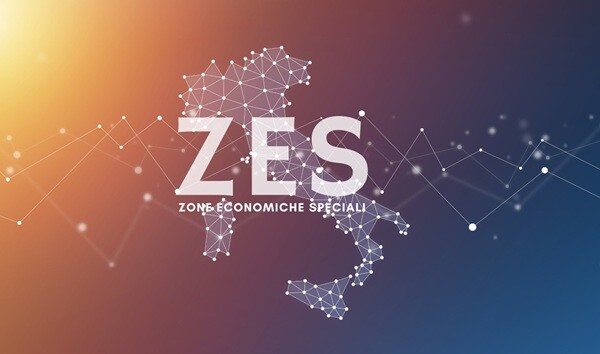La deprivazione che colpisce i bambini
Ogni bambino e ogni bambina dovrebbero avere la possibilità di crescere in un ambiente che li aiuti a esprimere al meglio le proprie capacità. Ma la realtà racconta altro: ancora oggi milioni di minori, in Italia e in Europa, vivono in condizioni di deprivazione materiale e sociale, che limita il loro benessere presente e ne riduce le chance per il futuro. Il recente aggiornamento Istat sulle condizioni di vita dei minori di 16 anni ci aiuta a fare il punto sulla situazione nel nostro Paese.
Il rischio di povertà o esclusione sociale. Nel 2024, circa 2 milioni di bambini e adolescenti – il 26,7% dei minori di 16 anni – vivono in famiglie a rischio di povertà o esclusione sociale, ovvero vivono in famiglie che si trovano in almeno una delle tre condizioni individuate dall’indicatore AROPE: il rischio di povertà, la severa deprivazione materiale e sociale, la bassa intensità lavorativa. Una quota più alta rispetto al 23,1% calcolato sull’intera popolazione, ma in calo di 3 punti percentuali rispetto al 2021. Dietro questa media, però, si nascondono forti eterogeneità: nel Nord i minori a rischio sono il 14,3% (in netto calo rispetto al 20,5% del 2021), mentre nel Mezzogiorno la percentuale è del 43,6% (era 45,7% nel 2021), quasi un bambino su due.
La situazione è peggiore per chi cresce in famiglie monogenitore: il 53,3% dei minori con un solo genitore e almeno un fratello o una sorella è a rischio povertà o esclusione sociale, in aumento di oltre 13 punti percentuali dal 2021. Nelle famiglie con due genitori e almeno un figlio, invece, il rischio scende al 26,2% (era oltre il 30% nel 2021).
I bambini e i ragazzi stranieri risultano molto più esposti: il 43,6% di loro è a rischio di povertà o esclusione sociale, contro il 23,5% dei coetanei italiani. Nel Mezzogiorno, la forbice si amplia: il rischio raggiunge il 78,2% per i minori stranieri, mentre si ferma al 40,9% per gli italiani.
L’istruzione si conferma un elemento fondamentale contro la povertà. Oltre la metà dei minori con genitori fermi alla licenza media (51,8%) è a rischio, contro appena il 10,3% di chi ha almeno un genitore laureato.
La deprivazione specifica. La deprivazione materiale e sociale specifica dei minori è definita dalle statistiche sociali come la condizione di un minore che manifesta almeno tre segnali di deprivazione tra i 17 indicati, nei quali rientrano ad esempio non potersi permettere libri extrascolastici adatti all’età o non potersi permettere giochi da usare all’aria aperta (la lista completa è disponibile qui). Considerando la deprivazioni così definita, l’Italia è in posizione migliore della media europea: l’11,7% contro il 13,6%. A fronte di una riduzione tra il 2021 e il 2024 della percentuale di minori in condizione di deprivazione, tuttavia, si osserva da noi un aggravamento dell’intensità. Nel 2021, oltre la metà dei minori deprivati registrava 3 o 4 segnali di deprivazione, mentre una bassa percentuale di minori presentava un alto numero di segnali (almeno 6), ovvero una condizione di maggiore vulnerabilità. Nel 2024 questo rapporto si inverte: la quota di minori con una bassa intensità di deprivazione cala molto (34,4%) mentre cresce significativamente la quota di coloro che soddisfano almeno 6 indicatori di deprivazione (52%). I segnali più diffusi di deprivazione sono non poter sostituire mobili danneggiati (17,9% dei minori), non potersi permettere una vacanza annuale (14,7%) o un’attività di svago a pagamento (9,3%).
La frequenza di nidi e scuole dell’infanzia resta un tema cruciale: tra i bambini di 0-2 anni, il 57,8% non vi accede, con picchi significativi al Sud (64,6%). L’esclusione pesa soprattutto sui più piccoli: chi non frequenta servizi educativi presenta un rischio di deprivazione di quasi 5 punti più alto della media dei coetanei.
La trasmissione intergenerazionale della povertà. La condizione economica in cui un bambino cresce lascia segni profondi sul suo futuro. In media, in Europa, il rischio di povertà in età adulta (25-59 anni) riguarda il 20% di chi a 14 anni viveva in famiglie in difficoltà contro il 12,4% di chi proveniva da famiglie agiate. In Italia la differenza è tra le più alte: 34% contro 14,4%, quasi 20 punti di distanza. Il livello di istruzione dei genitori incide su tale possibilità: in Italia il rischio di povertà da adulti è del 22% se i genitori non hanno continuato gli studi dopo la scuola media, del 9,3% se sono diplomati e del 7,4% se almeno un genitore è laureato.
Che cosa ci dicono i dati. Il quadro tracciato dall’Istat per l’Italia presenta dunque aspetti contraddittori. Da un lato alcuni indicatori, come la deprivazione materiale e sociale specifica, migliorano. Dall’altro restano nodi strutturali profondi: i divari territoriali, la fragilità delle famiglie monogenitore, la carenza di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e l’impatto del livello di istruzione dei genitori sulle prospettive future del minore. Inoltre, se da un lato meno bambini sono oggi colpiti da povertà e deprivazione rispetto al passato, il rovescio della medaglia è che le condizioni di vita chi resta indietro sono più gravi e più difficili da migliorare. Il rischio è che la povertà minorile, invece di ridursi davvero, cambi forma: non più diffusa in modo generalizzato, ma concentrata in nuclei familiari che accumulano un numero crescente di svantaggi.
Si tratta spesso di famiglie monogenitore, nuclei con tre o più figli, famiglie straniere o residenti nel Mezzogiorno, dove le opportunità sono ancora troppo limitate. In questo contesto, i servizi educativi diventano una leva fondamentale: l’accesso ai nidi e alle scuole dell’infanzia non è solo un aiuto per i genitori che lavorano, ma una vera e propria garanzia per i bambini, che grazie a queste esperienze possono sviluppare competenze sociali e cognitive decisive per il futuro. Eppure, in Italia, più di un bambino su due sotto i tre anni ne resta escluso. Un altro punto critico riguarda il livello di istruzione dei genitori: resta questo infatti il principale fattore di protezione per i figli. Se la famiglia d’origine ha bassi livelli educativi, la probabilità del minore di cadere in povertà da adulto aumenta sensibilmente. Ciò significa che investire sulla formazione non è solo un beneficio per il presente, ma un investimento intergenerazionale che può rompere il ciclo della povertà.
L’Istat ci consegna, quindi, una foto dell’Italia non priva di ambiguità: da un lato, nel nostro paese migliorano alcuni indicatori, ad iniziare dalla riduzione generale del rischio di povertà o esclusione sociale; dall’altro, persistono squilibri profondi, che penalizzano soprattutto i bambini più piccoli. Il Mezzogiorno resta la grande questione aperta, con valori che spesso sono doppi o tripli rispetto a quelli del Nord. Anche in assenza di dati disaggregati, è ragionevole ritenere, in base ad altri andamenti socio economici, che esistano differenze fra territori entro le macroaree. Il messaggio di fondo è chiaro: la povertà minorile non è solo un problema di reddito, ma di opportunità negate. E ogni opportunità persa nell’infanzia diventa un peso che si trascina nell’età adulta. Garantire pari opportunità a tutti i bambini rappresenta dunque una scelta strategica per il futuro del Paese. Significa investire in servizi educativi di qualità, rafforzare il sostegno alle famiglie più fragili, ridurre i divari territoriali, favorire la mobilità sociale. Perché la povertà, lo confermano i dati, non è solo una condizione del presente: rischia di diventare un destino che si eredita.