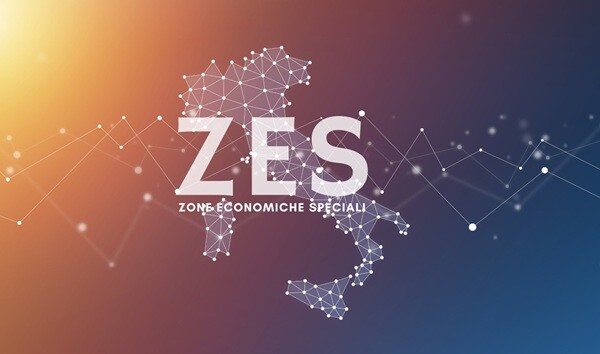Idee e domande per rivalutare il lavoro. Una riflessione a partire dall’ultimo libro di Laura Pennacchi
Nel nostro paese, il lavoro, per molti e molte, non riesce più a garantire una vita decente, con ripercussioni anche sull’uguaglianza intergenerazionale di opportunità. Difficile crescere in una famiglia dove vigono incertezza economica o, addirittura, insufficienza dei redditi. I salari reali sono, infatti, diminuiti (-8,1% dal 2000 al 2023). Sempre nel 2023, uno studio recente dell’Ufficio Economia della Cgil segnala che il 35,8% dei dipendenti (più di 6 milioni di persone) privati guadagnava meno di 15 mila euro all’anno (1000 euro netti mensili). Al contempo, quasi il 63% guadagnava meno di 25 mila euro lordi. Circa 1 persona su 10 è al di sotto della soglia di povertà pur lavorando. La situazione di molto lavoro autonomo non è migliore.
Quanto si guadagna è il prodotto di due fattori: quanto si è pagati e quanto si lavora. Le basse remunerazioni sono l’esito sia delle basse retribuzioni orarie e, soprattutto, dell’insufficienza delle ore lavorate.
Data questa situazione, dovrebbe essere ovvia la desiderabilità sia di un salario minimo sia di una stretta sul ricorso ai contratti a tempo determinato, al part-time involontario e a tirocini non pagati o abusivamente reiterati, in una parola alla flessibilizzazione del mercato del lavoro che è andata realizzandosi a partire dagli anni ‘90 fino alle recenti misure del governo Meloni. A ciò si aggiunge il contrasto ai “falsi” lavoratori indipendenti, quali sono molti lavoratori delle piattaforme, un altro gruppo in cui si annidano diversi elementi di svantaggio.
Laura Pennacchi, nel suo ultimo volume, Nonostante Hobbes (Castelvecchi, 2025), condivide interamente queste indicazioni. Ci sfida, tuttavia, a una difesa più forte del lavoro. Procacciare quanto serve a vivere, per quanto centrale, è solo una parte del valore del lavoro. Il lavoro ha anche una dimensione etica. Segnala la nostra partecipazione al progetto cooperativo che origina e caratterizza il nostro essere in società. Il lavoro ha altresì una dimensione antropologica/personalistica, costituendo un tratto essenziale della condizione umana, e della buona vita, con buona pace della teoria economica predominante che lo vede solo come disutilità.
Alcune citazioni possono aiutare a dare meglio il senso della posizione. Scrive Pennacchi (p. 153), “il riconoscimento e la solidarietà nel lavoro insegnano un rispetto per gli altri che si estende alla solidarietà tra pari al di fuori del lavoro e la natura morale delle interazioni lavorative si sprigiona verso la vita sociale più in generale. L’atto del lavoro è sempre indirizzato verso la società più larga, lavorare è sempre un’intersezione di differenti forme di interazione sociale ed è questo che rende il designare il lavoro come attività meramente strumentale chiaramente inadeguato”. E, ancora, a p. 155, “quando è benefico il lavoro accresce la soggettività con la genesi di nuovi registri della sensibilità, l’alimentazione dell’intelligenza, lo sviluppo della capacità di provare la vita in sé e l’amore di sé”. Senza lavoro si atrofizzano, invece, le nostre capacità soggettive e, con esse, anche la nostra capacità di partecipare alla vita democratica.”
Il neoliberismo ha avuto e ha un ruolo determinante nella svalutazione del lavoro sotto tutti i registri, denormativizzando il mercato del lavoro e rafforzandone l’elemento di merce, grazie anche alla finanziarizzazione e al deperimento della “proprietà comune” costituita dai servizi dello stato sociale. Un chiaro esempio è la costruzione del disposable worker, un individuo che si sposta da una produzione frammentata ad un’altra, in modo sostanzialmente orizzontale se non addirittura peggiorativo, privato delle possibilità sia di carriera (verticale) sia di controllo sul proprio lavoro.
Al contempo, Pennacchi è, però, molto critica anche di posizioni sostenute nella sinistra, che implicherebbero ugualmente una svalutazione del lavoro. È critica del reddito di base, che vede come una violazione della cooperazione e dell’espansione delle opportunità che solo il lavoro può dare. È critica delle visioni della fine del lavoro nonché del pensiero debole, con la sua enfasi sulla fragilità individuale. Il suo riferimento è semmai William Morris, la persona attiva e sociale che, insieme agli altri e le altre, si realizza e contribuisce alla società grazie al lavoro.
La svalutazione, inoltre, viene da lontano. Pennacchi ne riconduce l’origine a Hobbes e Macchiavelli che avrebbero trascurato la dimensione sociale e cooperativa dell’individuo.
Alla parte normativa, Pennacchi affianca numerose indicazioni concrete su cosa fare. La via è quella della “piena e buona occupazione”, dentro il quadro di un nuovo modello di sviluppo reso necessario dal cambiamento climatico, dalle nuove sfide poste dalla tecnologia, dai tanti buchi nella nostra infrastrutturazione sociale ed economica. “Piena e buona occupazione” e “nuovo modello di sviluppo” centrato sulla produzione di beni pubblici e sociali e su una tecnologia al servizio del buon lavoro sono, pertanto, profondamente legati. La prima è la via maestra per attivare il secondo (sul tema cfr. pure Perché rilanciare la piena e buona occupazione?
“Piena e buona occupazione” più precisamente significa adeguate retribuzioni; possibilità di voce entro un quadro di democrazia economica; possibilità di formazione nel ciclo di vita, e condizioni lavorative che assicurino un equilibrio tra vita privata e professionale, nel rispetto del principio di solidarietà e sostenibilità intergenerazionale. Importante, a quest’ultimo riguardo, è una condivisione della cura libera e paritaria, capace di superare le politiche di conciliazione dirette alle donne, come se solo le donne dovessero “conciliare” vita e lavoro.
Si noti il cambiamento radicale rispetto alle posizioni più diffuse. Non si tratta di alimentare la crescita, confidando che l’occupazione poi consegua, come ancora prospettano il Rapporto Draghi sul futuro della competitività e le diverse misure della bussola della competitività cui la Commissione sta lavorando e a quel Rapporto si ispirano. Tanto meno si tratta di seguire il nostro Governo quando chiede di non disturbare i datori di lavoro. Neppure, possiamo limitarci a incentivare indirettamente la generazione di lavoro. Occorre, al contrario, procedere alla creazione diretta di buona occupazione, grazie a adeguate politiche industriali e più complessive politiche economiche nei settori che oggi più concorrono allo sviluppo umano e alla cura dell’ambiente. Tutto ciò richiede a sua volta istituzioni pubbliche rinnovate, in grado attraverso la partecipazione dei tanti attori sociali, di ridisegnare “i mercati, l’innovazione, la produzione, le attività”.
La giustizia sociale e ambientale entrerebbe così nello spazio allocativo, guidando anche la scelta degli obiettivi e delle modalità di intervento (e non solo la redistribuzione di quanto “i mercati” decidono di produrre). Giovani e donne, le persone oggi più penalizzate nel mercato del lavoro, sarebbero tra i maggiori beneficiari.
Sono pienamente d’accordo con moltissime di queste osservazioni. Ho, però, tre domande, oltre a un piccolo dissenso sul reddito di base. Comincio da quest’ultimo, tralasciando la pure importante analisi del legame fra la svalutazione del lavoro e l’eredità di Hobbes e Macchiavelli, sulla quale non ho competenze, tranne il ricordo di un duplice Macchiavelli, il Macchiavelli de Il Principe e quello dei Discorsi sulla prima Deca di Tito Livio.
Pennacchi critica il reddito di base considerandolo un istituto assistenzialistico, insensibile ai doveri di contribuzione. Una posizione siffatta, secondo me, trascura la presenza di risorse comuni. La terra, ad esempio, è risorse comune, non essendo frutto del lavoro di alcun individuo. Se oggi, essa appare proprietà privata è perché alcuni se ne sono appropriati, ma in origine era di tutti. In questa prospettiva, il reddito di base o, in altri termini, il reddito di cittadinanza nella versione pura, rappresenterebbero la contropartita, la rendita (dominicale), derivante dalle risorse comuni (nel linguaggio spesso utilizzato, sarebbe una misura pre-distributiva, non una misura assistenzialistica). Emblematico, al riguardo, è il reddito di base alaskiano, derivante dalla vendita del petrolio presente in quella terra. Ciò riconosciuto, la rendita (dominicale) sarebbe poca cosa, il valore della terra (o di altre risorse naturali), derivando largamente dall’applicazione alla terra dell’attività lavorativa. Se così, il reddito di base darebbe a ciascuno/a ben poco, sebbene in aggregato possa costare molto alle finanze pubbliche.
Venendo alle domande, la prima domanda concerne la difesa che Pennacchi fa del lavoro come parte della buona vita. Certamente, il lavoro è un’attività umana molto importante. Ma, un po’ sulla falsariga della prospettiva seniana delle capacità e del più complessivo pensiero liberale, penso che si debba sempre lasciare alla libertà delle singole persone la valutazione di ciò che è bene per le loro vite (ovviamente, in assenza di costi su terzi). Ciò è tanto più vero nei mondi non ideali in cui viviamo, dove, pur ricercando la buona occupazione, molti lavori ne restano lontani. In tali contesti, invocare il valore del bene del lavoro non potrebbe comportare anche il rischio di una retorica paternalistica che, di fatto, legittima lo sfruttamento di chi sta peggio?
Il che non significa che la libertà giustifichi automaticamente il non lavoro. La società è uno schema cooperativo e tutti devono contribuire. Ma la richiesta di contribuzione, lungi dal motivarsi con la buona vita, poggerebbe sui soli doveri di giustizia. Potrei apprezzare ben poco il lavoro. Ciò nonostante, devo lavorare perché è ingiusto che qualcuno prenda senza dare… Come diceva Marx, “da ciascuno secondo le sue abilità… “. In termini rawlsiani, un conto è la concezione “sottile” del bene, che soggiace a qualsiasi concezione di giustizia e che richiede di guardare agli altri e alle altre come uguali. Un altro à la concezione “spessa”/sostanziale del bene, presente nella difesa del lavoro come bene per il singolo e elemento essenziale della buona vita, la quale va lasciata alle scelte individuali. Fra le difese del valore di lavoro presentate da Pennacchi cadrebbe pertanto quella in termini di buona vita, mentre resterebbe quella in termini di giustizia.
A margine, se il lavoro non fosse la prima scelta, non potrebbero/dovrebbero idearsi altre forme di contribuzione più aderenti alle propensioni individuali, circoscrivendo il peso del lavoro e rivalutando altre forme di partecipazione non mediata dal denaro come il lavoro?
La seconda domanda si applica anche alla difesa del lavoro in termini di giustizia. Si ritorni, di nuovo, a un mondo non ideale, dove l’’uguaglianza di opportunità non è soddisfatta e i lavori disponibili sono lontani dallo standard di buona qualità. In un contesto siffatto, dobbiamo chiedere a chi sta peggio di essere responsabile e lavorare, o l’irresponsabilità collettività nel non garantire condizioni di vita dignitose a tutti e tutti potrebbe giustificare una compensazione a favore di chi sta peggio? Il tema è al cuore del disegno del reddito minimo.
Più nello specifico, dobbiamo muovere verso un reddito condizionato alla disponibilità a lavorare, come negli ultimi decenni è sempre più avvenuto nell’Unione e, in Italia, da quando abbiamo qualche forma di reddito minimo? Oppure, dobbiamo muovere verso un reddito garantito, accoppiato all’offerta di opportunità di lavoro ma solo per chi lo desidera? E comunque, anche nella prospettiva della condizionalità, come distinguere le occupazioni che possono essere offerte, in quanto corredata da un minimo di livelli di qualità, da quelle non offribili?
Infine, l’ultima domanda concerne la creazione diretta di occupazione. Pennacchi prospetta due componenti: una strutturale (relativa al fabbisogno di personale necessario all’erogazione dei servizi pubblici) e l’altra ciclica (relativa al contrasto a fasi negative del ciclo), come nella prospettiva di un piano di occupazione di ultima istanza, un piano secondo cui la Pubblica Amministrazione offre a chiunque voglia lavorare un lavoro al salario minimo. Il mio timore concerne quest’ultima. Come coordinare lavoro ciclico e lavoro standard? Se i lavori ciclici fossero utili, allora sembrerebbe ragionevole attivarli strutturalmente. Vi è poi il rischio che, appena terminato il momento negativo, la domanda di lavoro nel mercato aumenti inducendo all’uscita dal lavoro di ultima istanza nonostante che questo contribuisca maggiormente allo star bene collettivo. E, ancora, nel periodo in cui sono assunti, gli occupati di ultima istanza (remunerati al salario minimo) non entrerebbero in concorrenza con lavoratori e lavoratrici standard, che già eseguono quei lavori, con effetti peggiorativi su questi ultimi, come sottolineato dal paradosso del duro lavoro formulato dall’economista, premio Nobel, Phelps?
Queste domande riguardano tutti noi. Anche per queste domande, oltre che per i tanti contributi propositivi offerti, dobbiamo essere grati al bel libro di Pennacchi.