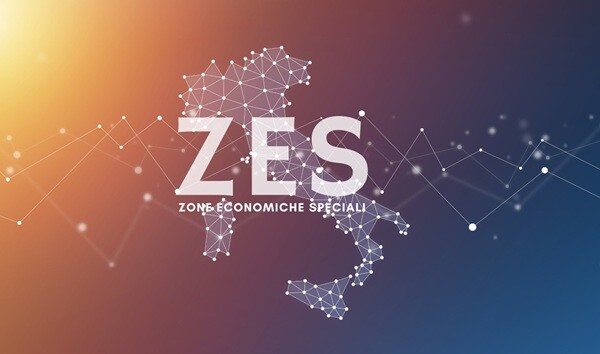Riarmo o Lavoro? Un’Analisi Critica degli Imperativi Europei. Prima parte: Radici storiche ed evoluzione delle teorie e della statistica
1. Spesa militare ed economia: una storia con radici lontane. L’apparente dicotomia tra produzione bellica e benessere sociale costituisce un tema ricorrente nella storia del capitalismo occidentale. La sua genealogia può essere fatta risalire alla transizione dal feudalesimo all’età mercantile, quando embrioni del complesso militare-industriale iniziarono a prendere forma nei cantieri navali della Serenissima Repubblica di Venezia e della Superba Genova a partire dal XV secolo. La commistione tra logica della potenza e calcolo commerciale divenne tangibile, gettando le basi per quella simbiosi tra capitale e potere coercitivo che avrebbe caratterizzato le epoche successive. Questo “paradigma” si implementa nel XVII secolo con le Compagnie delle Indie: l’accumulazione privata si serviva della forza militare per imporre monopoli, reprimere resistenze e conquistare nuovi mercati. Con la Rivoluzione Industriale la produzione di armamenti diventa un settore industriale a tutti gli effetti. Il paradosso tra riarmo e lavoro, dunque, non è un’eccezione patologica del capitalismo maturo, piuttosto una sua caratteristica costitutiva e intrinseca, un filo rosso che ne percorre l’intero sviluppo storico.
1.1 L’opera di Marx: spesa militare come consumo improduttivo. La letteratura economica ha fornito, nel tempo, chiavi di lettura profondamente diverse di questo fenomeno. La prospettiva che va da Marx ai teorici del capitale monopolistico del Novecento colloca la spesa militare nell’alveo della riproduzione del capitale e delle sue contraddizioni interne. Per Karl Marx (Teorie sul plusvalore, 1862-63, Volume I, Capitolo IV), il capitale destinato alla produzione bellica rientrava nella categoria del “consumo improduttivo”. Nella sua prospettiva, il lavoro produttivo è esclusivamente quello che produce plusvalore e si realizza direttamente nel processo di valorizzazione del capitale (D-M-D’). Il lavoro che, pur essendo utile (come quello di un soldato, di un magistrato o di un domestico), viene pagato con una parte del reddito (il plusvalore già realizzato) e non crea nuovo valore, è definito improduttivo.
A differenza del capitale variabile e costante impiegato nella produzione di merci, il valore incorporato in un fucile o in una cannoniera non viene trasferito in nuovi beni che possono essere reimmessi nel ciclo produttivo, cioè non concorre all’allargamento della base materiale della società. L’utilità della spesa militare, infatti, era essenzialmente politico-economica: assorbiva le eccedenze di capitale e di merci in periodi di crisi, ovvero era una spesa anticiclica via “distruzione creatrice” della guerra e la successiva ricostruzione. Questa intuizione fu ripresa e attualizzata nel secondo dopoguerra dai teorici del military keynesianism. Economisti come Paul Baran e Paul Sweezy, nella loro opera monumentale Il Capitale Monopolistico (1966), e in altro modo Ernest Mandel nel suo Trattato di Economia Marxista (1962), hanno analizzato come l’economia statunitense del dopoguerra avesse istituzionalizzato la spesa per la difesa quale strumento permanente per stabilizzare la domanda aggregata. In Europa, invece, le stesse tensioni furono gestite in modo diverso: la ricostruzione e il welfare divennero i cardini della crescita, e ancora oggi questa divergenza riemerge nelle scelte tra riarmo e investimenti civili. Inoltre, a differenza del keynesismo mainstream, questi autori non persero mai di vista il lato oscuro di questo meccanismo: il suo inscindibile legame con una politica estera imperialista e con la creazione di un “complesso militare-industriale” la cui influenza sulla politica interna divenne, come denunciato dallo stesso Presidente Eisenhower nel suo discorso d’addio del 1961, una minaccia per i processi democratici stessi. Il rischio è quello di una “Permanent War Economy” (T. N. Vance, The Permanent War Economy, Part I – Its Basic Characteristics, New International,1951; S. Melman, The Permanent War Economy: American Capitalism in Decline, Simon and Schuster, 1974), cioè di piegarel’economia europea, come quella statunitense, alla spesa militare anche in tempo di pace.
1.2 Economisti neoclassici e la spesa militare. In seguito, si è affermata l’ortodossia Neoclassica che sottolineava l’inefficienza della spesa pubblica, collocandosi all’estremo opposto della scuola keynesiana, il cui edificio concettuale poggiava sull’assioma dell’agente razionale e dell’equilibrio dei mercati, che ha tradizionalmente guardato con profondo scetticismo a qualsiasi forma di spesa pubblica. La sua inefficienza è intrinseca: sottrae risorse scarse al settore privato, dove sarebbero allocate in modo ottimale dal meccanismo dei prezzi, per destinarle a fini che non rispondono a una domanda di mercato ma a logiche politiche distorte. I teorici dello “Stato minimo”, come Friedrich von Hayek in La Società Libera (1960), Robert Nozick in Anarchia, Stato e Utopia (1974) e Milton Friedman in Capitalismo e Libertà (1962), invece, hanno argomentato che la legittimità dell’intervento pubblico si esaurisce nella protezione dei cittadini dalla violenza interna ed esterna (polizia ed esercito) e nella garanzia dell’adempimento dei contratti e del diritto di proprietà. Ogni deviazione da questo mandato essenziale è vista come un passo verso il dispotismo e l’inefficienza (non a caso, in Europa queste teorie hanno alimentato le politiche di contenimento della spesa pubblica e, più di recente, i vincoli di austerità che hanno frenato gli investimenti industriali e sociali.). La spesa militare per questi autori era contemplata e coerente con l’idea di stato minimo.
1.3 L’era della speranza e del dividendo della pace. La fine della Guerra Fredda ha permesso di riflettere sul così detto dividendo della pace. Numerosi studi dimostrarono come la smobilitazione di una parte significativa dell’apparato militare potesse liberare ingenti risorse da reindirizzare verso investimenti civili, ricerca e welfare, innescando periodi di prosperità e di consolidamento fiscale. Si pensi al World Development Report 1991: The Challenge of Development (World Bank, 1991), pubblicato in un momento di ottimismo, che sottolineava le opportunità offerte dalla fine della Guerra Fredda. Sosteneva esplicitamente che la riduzione delle spese militari globali avrebbe liberato risorse umane, finanziarie e tecnologiche per lo sviluppo economico dei paesi del Sud del mondo e per la riconversione industriale in quelli del Nord. Anche il Congressional Budget Office (CBO), in The Economic Effects of Reduced Defense Spending (1992), modellizzava gli impatti macroeconomici della riduzione del bilancio della difesa USA. Pur evidenziando i costi di transizione (disoccupazione settoriale, riconversione), le proiezioni erano generalmente positive per il medio-lungo periodo, prevedendo un potenziale aumento degli investimenti produttivi civili.
1.4 La statistica come continuazione della politica? Anche la statistica ufficiale ha concorso alla rappresentazione della spesa militare, modificando una parte della contabilità nazionale. In fondo, il modo in cui una spesa viene misurata non è mai neutro; al contrario ha rilevanti conseguenze politiche, contribuendo a plasmare la percezione della realtà. Con l’adozione del Sistema Europeo dei Conti Nazionali (SEC 2010), le spese per armamenti e ricerca e sviluppo sono passati da “consumi intermedi” o “spesa corrente” a “formazione lorda di capitale fisso” (ISTAT, Sistema europeo dei conti SEC 2010, 2014), quindi investimenti. Se per la R&S la computazione nella voce investimento intangibile – un bene che genera benefici futuri – è concettualmente solida e ampiamente condivisa, ben più problematica è l’assimilazione degli armamenti alla categoria dei “beni capitale”. Il criterio puramente contabile adottato è legato alla durata pluriennale del bene. In realtà, un tornio o un software produttivo sono beni capitali perché partecipano attivamente al processo di creazione di nuovo valore, generando un flusso futuro di beni e servizi, mentre un carro armato o un caccia bombardiere, per quanto durevoli, sono beni finali il cui scopo è la dissuasione o, nella peggiore delle ipotesi, la distruzione. Il loro “output” è, per sua natura, negativo o nullo in termini di ricchezza materiale.
In termini semplici, con il SEC 2010 l’acquisto di un carro armato viene trattato allo stesso modo di una macchina utensile: entrambi sono classificati come “investimento”, ma la differenza è sostanziale: una macchina utensile produce beni futuri, genera reddito e lavoro; un carro armato, per quanto durevole, non crea valore economico riutilizzabile. Il risultato è che le statistiche ufficiali danno l’impressione di un aumento della capacità produttiva del Paese, mentre in realtà si tratta di un consumo finale travestito da investimento. L’effetto è quello di aumentare il tasso di investimento di una nazione (il rapporto Investimenti/PIL) e, quindi, disegnare una economia più orientata al futuro. La statistica, in questo caso, non si limita a descrivere la realtà, piuttosto concorre a legittimare delle scelte che sono squisitamente politiche e strategiche.
2. Le reali prospettive dibattito pubblico europeo sul riarmo. L’attuale scenario internazionale, segnato dal ritorno della guerra in Europa e dal rischio crescente di nuovi conflitti, impone di riconsiderare il rapporto tra spesa militare, sicurezza e sviluppo. Tuttavia, il mutato contesto non modifica le basi economiche del problema: la spesa militare resta, nella sua natura, un consumo improduttivo. Essa non crea nuovo valore, ma redistribuisce risorse pubbliche verso settori a bassa capacità moltiplicativa, riducendo gli spazi fiscali destinabili a investimenti civili, ricerca e occupazione stabile. Inoltre, la storia economica insegna che i momenti di emergenza bellica tendono a consolidare meccanismi di spesa eccezionali, che nel tempo si trasformano in strutture permanenti. È questo il rischio della cosiddetta Permanent War Economy, già denunciato negli anni Settanta, che oggi si ripresenta in Europa con caratteristiche nuove: l’integrazione industriale transatlantica, la crescente dipendenza tecnologica e la normalizzazione della logica di riarmo come strumento ordinario di politica economica. Vale il monito di P. Balduzzi e A.Bignami (l prezzo della guerra. Le conseguenze economiche delle crisi internazionali, Paesi Edizioni, 2025, pag. 264): “Quando scoppia un conflitto, una società non mobilita soltanto uomini e mezzi militari; essa rialloca il capitale, ridefinisce le priorità tecnologiche, riconfigura le catene di approvvigionamento e i processi produttivi, accetta il razionamento dei consumi e l’imposizione di nuove tasse, e infine sconvolge gli equilibri del debito pubblico e della moneta. La guerra, in altre parole, non è un’interruzione dell’ordine economico, ma una sua violenta e radicale riorganizzazione”.
Gli stessi autori ricordano che “l’analisi storica permette di cogliere un duplice movimento che definisce la relazione tra conflitto e attività economica: da un lato, la guerra che agisce come un potente catalizzatore di trasformazione per l’economia; dall’altro, e in modo sempre più pervasivo, l’economia che modella la natura stessa della guerra”. La sicurezza reale è di conseguenza compromessa: la capacità di garantire benessere diffuso, autonomia produttiva, stabilità occupazionale e coesione sociale sono “contaminate” dall’economia di guerra, nel senso non solo della guerra guerreggiata, ma anche dalla trasposizione tra l’«economia della guerra», intesa come la mobilitazione di risorse per sostenere un conflitto armato, e la «guerra dell’economia», ovvero l’uso di strumenti economici come sanzioni e contro-sanzioni per condurre un confronto indiretto, capace di redistribuire valore e potere ben oltre il campo di battaglia. In un contesto di crisi multipla – energetica, climatica, tecnologica e geopolitica – un modello fondato sul riarmo rischia di ridurre ulteriormente proprio le risorse necessarie per affrontare le cause strutturali dell’insicurezza.
In questa prospettiva, riteniamo che il dibattito europeo debba tornare a interrogarsi su almeno quattro nodi centrali:
- La natura economica della spesa militare, che anche in tempi di conflitto rimane improduttiva e sottrae risorse a usi socialmente e ambientalmente più efficienti;
- l’effetto distorsivo della contabilità nazionale, che attraverso il SEC 2010 trasforma una decisione politica in un dato statistico apparentemente neutro, alterando la percezione della crescita;
- la dipendenza industriale e tecnologica europea dagli Stati Uniti e dai grandi conglomerati della difesa, che limita la sovranità economica e strategica dell’Unione;
- il rischio di una nuova economia di guerra permanente, in cui la logica dell’emergenza sostituisce quella della programmazione industriale e sociale.
Nella seconda parte di questo saggio proveremo ad argomentare con maggiore dettaglio alcune di queste prospettive, mostrando la contraddizione intrinseca ad alcune scelte che l’Unione Europea, così come i singoli stati membri, stanno privilegiando.
Per concludere, la domanda “riarmo o lavoro?” riemerge con forza rinnovata. Non è una questione contingente né un semplice dilemma di bilancio, ma una scelta di civiltà che riguarda la direzione stessa dello sviluppo europeo: un modello fondato sulla competizione armata contro un modello volto alla costruzione di un’economia della pace, capace di generare sicurezza attraverso giustizia sociale, autonomia produttiva e cooperazione.