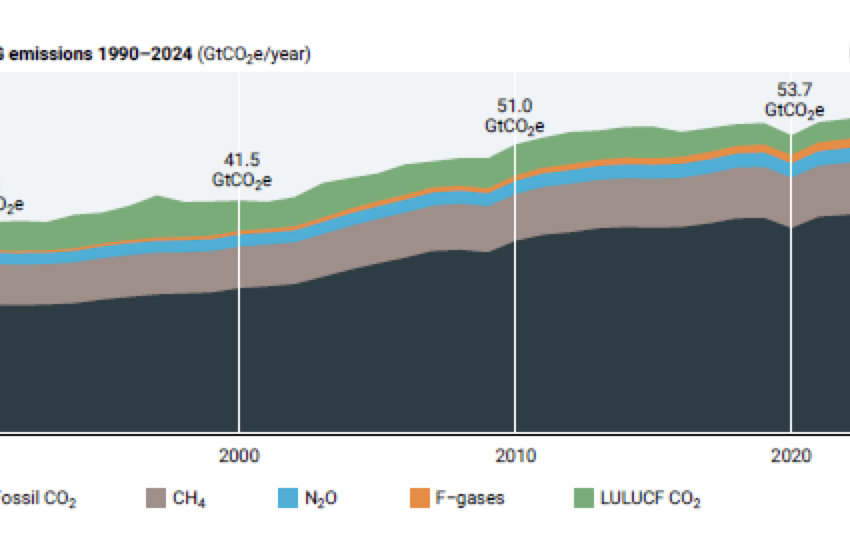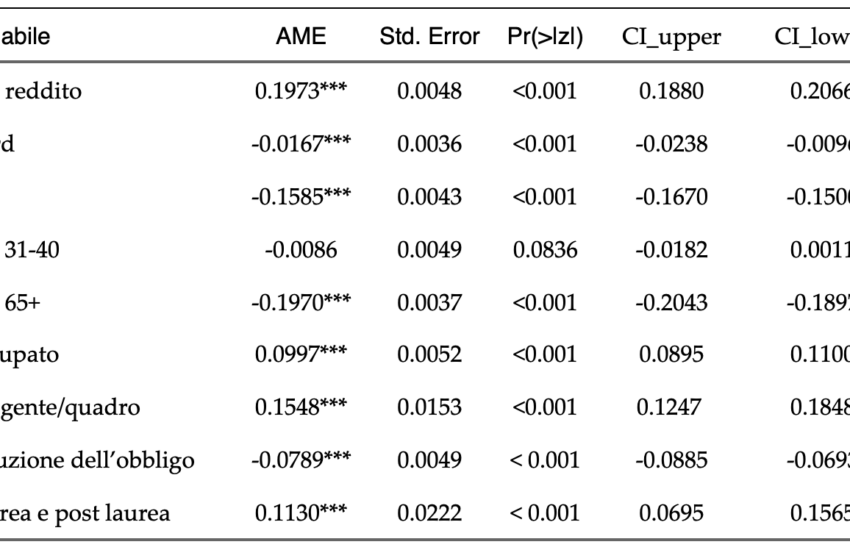LA CRISI DISTRUTTIVA DELL’ORDINE INTERNAZIONALE
Nonostante i richiami sempre più irrealistici alla sua resilienza, l’ordine internazionale liberale concepito alla fine della Seconda guerra mondiale e apparentemente “liberato” dalla scomparsa dell’Unione sovietica è ormai definitivamente crollato. E lo ha fatto, sarà bene ricordarlo, dopo una parabola sorprendentemente breve di ascesa e declino. La condizione di superiorità senza precedenti della quale avevano goduto gli Stati Uniti e i loro alleati all’indomani della scomparsa dell’Unione sovietica non aveva impedito infatti al Nuovo Ordine Mondiale di entrare in crisi già pochi anni più tardi, grossomodo alla metà del primo decennio del XXI secolo, sotto i colpi di due fallimenti maturati pienamente al proprio interno: la guerra in Iraq a partire dal 2003 e, ancora di più, la crisi economico-finanziaria del 2007-08. Nel decennio successivo, lo smottamento dell’edificio aveva aperto lo spazio al riemergere di competitori sia su scala regionale (come la Russia) sia, almeno potenzialmente, su scala globale (come la Cina), mentre ciò non aveva tardato a reinnescare proprio ciò che dieci anni prima era stato precipitosamente escluso, una nuova competizione tra grandi potenze. Quello che è subentrato negli sfortunatissimi anni Venti del nostro secolo, allora, è solo il crollo definitivo dell’ordine, sotto l’effetto della pandemia del Covid nel 2020-2021, della guerra in Ucraina a partire dal febbraio del 2022 e, per ultimo, dell’epidemia di conflitti armati susseguitisi in Medio Oriente dall’ottobre del 2023. Un crollo che ha esposto il clamoroso ritardo di molti dei principali attori, a cominciare dall’Unione Europea. E che costituirà, per tutti, la principale sfida del prossimo decennio.
La crisi dell’ordine internazionale. Che cosa può comportare, allora, il collasso di un ordine internazionale tanto ambizioso quanto era quello congegnato dopo il 1945 e trionfalmente rilanciato nel 1990? Vale a dire, rovesciando la prospettiva: che cosa ci possiamo aspettare dalla sua fine? Fine dell’ordine internazionale liberale significa, tanto per cominciare, fine di un ordine, cioè fine di ciò che l’ordine, di qualunque natura esso sia, può significare nelle relazioni internazionali: il soddisfacimento degli obiettivi elementari di qualunque convivenza sociale – la limitazione della violenza, il rispetto delle promesse e la stabilità del possesso; la capacità di nutrire almeno un piccolo ma fondamentale nucleo di aspettative sul futuro – su come sarà distribuito il potere, per esempio, su quale sarà la configurazione geopolitica del sistema internazionale, su quali saranno le sue regole e le sue istituzioni; la possibilità di basare le proprie scelte sul presupposto che su tutto ciò si possa, almeno in linea di massima, contare.
Da qui, allora, la sensazione sempre più diffusa di un “mondo fuori controllo”. Una sensazione che, per non risolversi in una vaga formula retorica, deve essere presa nel suo significato più letterale. Un mondo fuori controllo è un mondo nel quale non funzionano più, o funzionano sempre di meno le forme di controllo proprie del sistema internazionale: la distribuzione (ineguale) del potere che, dopo essere stata chiarissima all’indomani della fine della guerra fredda, lo è diventata sempre meno nei decenni successivi; e il tessuto istituzionale della convivenza internazionale, passato in meno di trent’anni dalla fase di effervescenza degli anni Novanta del Novecento al collasso quasi completo di oggi.
La manifestazione più superficiale di questa crisi di controllo è, come sempre nella politica internazionale, la proliferazione e la persistenza dei conflitti armati. Che significa non soltanto che continua a crescere il numero dei conflitti armati, internazionali e civili. Conflitti che, ancora fino a pochi anni fa, sembravano coinvolgere soltanto attori minori, ora coinvolgono sempre di più anche attori maggiori (la Russia, l’Ucraina e i paesi della Nato che la sostengono, Israele e l’Iran). Ma significa, per di più, che una volta scoppiati, i conflitti armati tendono a durare sempre di più nel tempo, come sta accadendo anche per i due politicamente più importanti degli ultimi tre anni, quello in Ucraina e quello in Medio Oriente.
Rieccoci allora al senso più profondo della crisi di controllo. La proliferazione e, ancora di più, la persistenza dei conflitti dimostrano che non c’è più quasi traccia della diplomazia preventiva celebrata nella fase di ascesa dell’ordine liberale; che è entrata clamorosamente in crisi la pratica del negoziato, non solo perché mancano quasi sempre negoziatori credibili ma perché manca sempre di più l’idea stessa della negoziabilità dei conflitti; mentre, alla base, se i conflitti sfuggono agli strumenti diplomatici è perché sfuggono prima di tutto alle nostre categorie cognitive, che sembrano rimaste ibernate al mondo della “fine della storia” degli anni Novanta del Novecento.
A questa proliferazione già in corso dei conflitti si accompagna, aggravandola, la radicale inversione delle nostre aspettative sul futuro. Ancora fino a una manciata di anni fa, le aree strategicamente ed economicamente centrali del sistema internazionale sembravano destinate a un futuro di pace. Mentre le guerre che continuavano a essere combattute altrove (periodicamente anche da noi europei, come in Iraq nel 1991, in Jugoslavia nel 1991, in Afghanistan dal 2001 e in Libia nel 2011) potevano essere guardate dall’Europa e dall’America come “fatti periferici”, se non come contrassegno per eccellenza della perifericità. Negli ultimi cinque anni, al contrario, l’eventualità di una guerra tra grandi potenze, non alla periferia ma al centro del sistema internazionale, è tornata al vertice delle preoccupazioni e della pianificazione strategica di tutti gli attori, Europa compresa. Detto in termini un po’ approssimativi: se il mondo di qualche anno fa si preparava, nonostante tutto, alla pace, il nostro sembra prepararsi sempre di più alla guerra.
Questo rovesciamento dei rapporti tra pace e guerra porta con sé il secondo e ancora più appariscente tratto della crisi dell’ordine: la crescente rimilitarizzazione delle relazioni internazionali. Che comporta, tanto per cominciare, una corsa generale al riarmo e all’innovazione delle tecnologie militari, che ha investito anche il continente, l’Europa, che ne era stato risparmiato per più di tre decenni. Fianco a fianco al riarmo, e in rapporto strettissimo con il primo, la rimilitarizzazione porta con sé il varo e il rilancio delle alleanze militari, a cominciare anche in questo caso dalla Nato. Infine, la militarizzazione non risparmia il terreno della comunicazione e dei linguaggi politici, alimentando da un lato l’inclinazione a rappresentare il mondo in termini rozzamente dualistici e, dall’altro, l’adozione stessa di linguaggi politicamente e diplomaticamente sempre più sguaiati, come quelli ai quali ci stanno abituando non soltanto Donald Trump o Dmitrij Medvedev, ma anche molti responsabili europei e atlantici (a cominciare dal Segretario generale della Nato Mark Rutte).
Infine, a rendere ancora più preoccupante questa deriva contribuisce il fatto che essa avviene nel pieno di una crisi spaventosa delle regole della convivenza internazionale. Una crisi che, ai cittadini europei e americani, si presenta oggi sotto la forma della guerra dei dazi e dei suoi contraccolpi sulla stabilità e l’apertura dell’economia internazionale. Ma, a tutti gli altri, si era già presentata nella forma ben più radicale di una vera e propria demolizione dei princìpi, delle norme e delle regole dirette e a limitare e arginare la violenza. Di questo tessuto di regole, che era il nucleo centrale della convivenza internazionale del dopo-Seconda guerra mondiale, non resta quasi più nulla nel contesto attuale. Perché i vincoli strettissimi all’uso della forza dettati dalla Carta delle Nazioni Unite hanno ceduto il passo a una progressiva riabilitazione politica, giuridica e persino etica della guerra, simboleggiata dall’adozione di una nozione distruttivamente estensiva del principio di prevenzione – quale quella impiegata anche nelle ultime settimane da Israele e Stati Uniti contro l’Iran. Il diritto internazionale umanitario è stato letteralmente fatto a pezzi dapprima nella guerra globale al terrore e poi, in forme inimmaginabili ancora fino a pochi anni fa, nel bombardamento a tappeto di Gaza – fatto a pezzi non perché, come si era già ripetuto negli ultimi anni, il diritto è stato violato ma perché, questa volta, ciò ha potuto avvenire nella totale impunità e con l’oscena indulgenza persino di tanti professionisti occidentali dell’umanitarismo. La distinzione stessa tra pace e guerra, infine, si è dissolta in quella che sempre più distrattamente viene rappresentata (e trattata) come una condizione di guerra ibrida permanente: una condizione nella quale tutti – politici, studiosi, giornalisti e semplici cittadini – sono chiamati a restare “sempre in vedetta”, contro i nemici esterni ma, ancora di più, contro lo spettro degli immancabili “nemici interni”.
La crisi della natura liberale dell’ordine internazionale. Fino a qui, dunque, la crisi dell’ordine in quanto ordine. Ma quello che sta venendo meno non è, genericamente, un ordine internazionale, bensì un ordine internazionale connotato e legittimato in senso liberale. Che è l’altro lato della condizione nella quale ci troviamo già e alla quale, presumibilmente, ci dobbiamo preparare anche per il prossimo futuro. Crisi dell’ordine liberale significa, intanto, che si è via via sgretolato l’edificio multilaterale della convivenza internazionale che era il fiore all’occhiello di quell’ordine. In parte, perché sono entrate in crisi tutte le maggiori istituzioni internazionali dell’epoca, dalle Nazioni Unite al G7 alla stessa Unione Europea. E, in parte ancora maggiore, perché al posto del multilateralismo universalistico e inclusivo del passato si è andato formando un multilateralismo più frammentato e competitivo, organizzato su scala regionale o subregionale attorno agli attori emergenti in ciascuna regione.
Sulla scia della crisi del multilateralismo, la competizione internazionale ha politicizzato e smontato la globalizzazione, rovesciando un’altra delle aspettative più caratteristiche della fase di ascesa dell’ordine liberale. Stando a queste aspettative, la globalizzazione economica avrebbe dovuto portarsi dietro presto o tardi qualche forma di globalizzazione politica e culturale – secondo il mantra politico e accademico della global governance. È avvenuto esattamente il contrario: è toccato alle riemergenti fratture politiche trascinarsi dietro la globalizzazione economica, fino a spaccarla lungo linee di frattura di natura non economica ma prettamente politica. Invece che la globalizzazione inclusiva degli anni Novanta del XX secolo, quella che si profila all’orizzonte allora è una globalizzazione più ristretta e aperta sempre di più solo attorno agli attori e ai progetti politicamente compatibili con i propri.
Ma l’effetto più pervasivo del collasso dell’ordine è quello di averci già consegnato una nuova immagine del mondo, perfettamente rovesciata rispetto a quella alla quale ci eravamo abituati nell’ultimo trentennio. Al posto del mondo post-statale, post-moderno e post-vestfaliano vantato alla fine del Novecento, una imponente ristatualizzazione delle relazioni internazionali; al posto del “mondo piatto” e “senza confini” della globalizzazione, una corrispondente riterritorializzazione incentrata sul rafforzamento e sulla difesa dei confini; al posto del “presentismo”, soprattutto, la consapevolezza sempre più diffusa che tutto il nostro presente sta sprofondando.