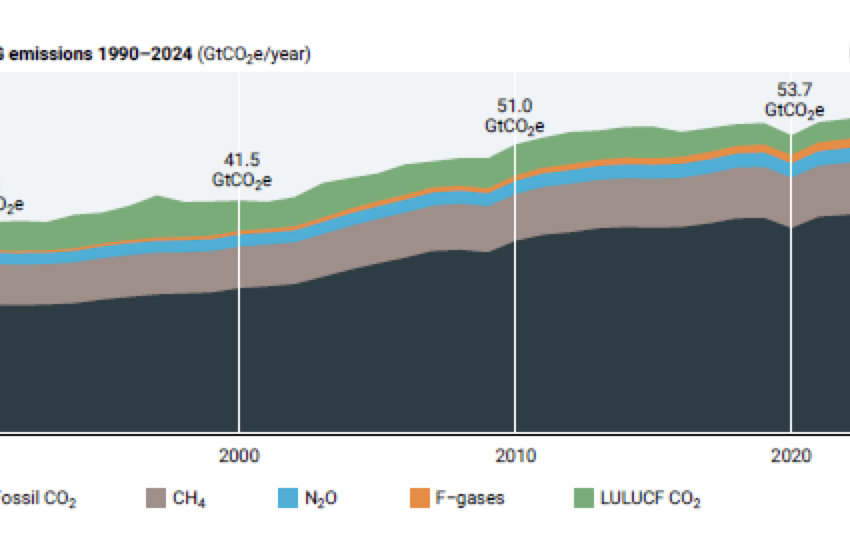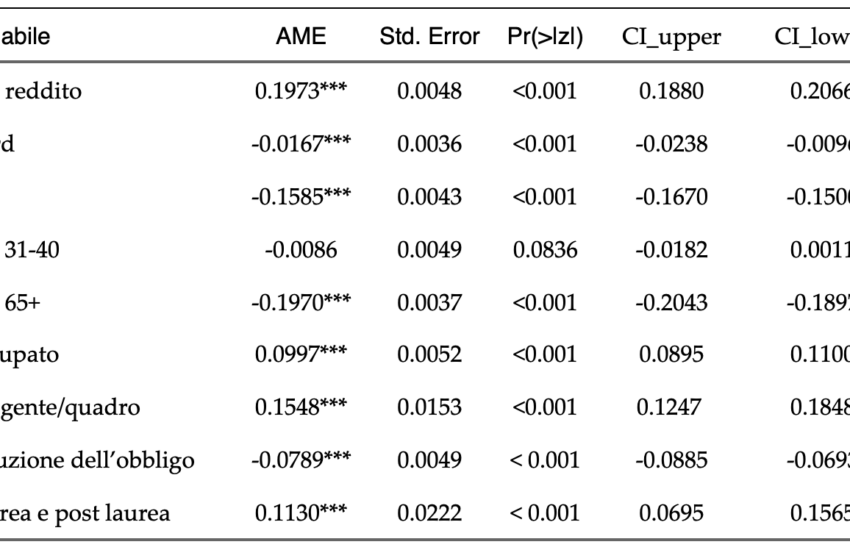Roma e le sue disuguaglianze: il ruolo emergente dei Poli civici di mutualismo solidale
A Roma l’attivismo post-pandemia ha portato alla nascita e al consolidamento dei Poli civici di mutualismo solidale, espressione di cittadinanza attiva e risposta collettiva alle disuguaglianze economiche, sociali e abitative (LabSU DICEA e Fairwatch, 2022; Romasette, 2023; Cellamare, 2024).
In un contesto urbano caratterizzato da marcati squilibri, con quartieri centrali come Parioli e Quirinale che superano i 70.000 euro di reddito medio annuo e godono di una dotazione infrastrutturale elevata, in netto contrasto con aree periferiche che spesso non raggiungono i 20.000 euro e presentano servizi carenti come Tor Cervara, Tor Bella Monaca, Borghesiana e Acilia (Lelo, Monni, Tomassi, 2019 e 2021), i Poli civici vanno oltre la funzione di centri di assistenza: si propongono come infrastrutture sociali di prossimità dove si aspira a sperimentare modelli di welfare comunitario, a ricostruire legami e alimentare la fiducia nel futuro.
Il Polo civico Esquilino e il Polo civico Quarticciolo sono stati gli apripista, due casi differenti per contesto, origine e traiettoria evolutiva accomunati dalla capacità di fare inclusione, mutualismo e cittadinanza attiva.
Il Polo civico Esquilino, attivo nel rione più multietnico della Capitale, si è strutturato come un ecosistema integrato, costituito da 42 tra realtà associative, collettivi, cooperative sociali, reti di mutuo soccorso e gruppi di supporto legale e abitativo. Al suo interno si distingue Spin Time Labs, centro socio-abitativo e culturale autogestito sorto in un edificio occupato in cui vivono 150 famiglie che, a sua volta, riunisce attivisti, educatori, mediatori culturali, studenti e artisti, promuovendo un modello di cittadinanza inclusiva e interculturale (Cacciotti, 2024). L’apertura e le numerose collaborazioni con scuole, università, start up, parrocchie, associazioni e comitati hanno rafforzato il senso di appartenenza e contribuito alla rigenerazione di una zona che, seppur centrale, viene frequentemente marchiata come area degradata. Il Polo civico Esquilino si configura come una piattaforma avanzata di innovazione, riconosciuta per la capacità di intrecciare accoglienza, produzione culturale, supporto educativo, percorsi formativi e economia sociale. Il sostegno istituzionale da parte del Municipio Roma I, che ha messo a disposizione una sede, ha prodotto un importante effetto moltiplicatore per quanto riguarda iniziative e protagonismo.
Il Polo civico del Quarticciolo, sorto in una delle periferie storicamente più complesse della Capitale, rappresenta un esempio virtuoso di rigenerazione urbana attraverso la leva culturale, sportiva e sociale (Pontiero, 2024). La Palestra Popolare Quarticciolo è tra i principali attori, offrendo attività di sport e benessere (boxe, danza, yoga) accessibili a prezzi calmierati e all’occorrenza in forma gratuita, integrandole con percorsi di orientamento, formazione, mutualismo sanitario ed empowerment. Frequentata da persone di ogni età, si configura come un presidio di cura e socialità, sostenuto da un’ampia rete di soggetti locali, comitati, associazioni e dall’occupazione abitativa dell’ex questura. L’interazione ha dato vita, in risposta ad alcuni dei più gravi bisogni inevasi, a doposcuola, ambulatorio popolare e microimprese impegnate in ambito artigianale, di ristorazione, catering e birrificio, con l’obiettivo di contrastare marginalità, criminalità e propensione all’abbandono del quartiere. Anche al Quarticciolo, insomma, il Polo civico non è contenitore ma soggetto che attiva processi trasformativi.
In ambedue i casi ci troviamo di fronte a esperienze autogestite che hanno preso forma senza aiuti esterni, rigettando la logica dell’assistenzialismo e puntando su un welfare dal basso caratterizzato dalla ‘cessione di sovranità’ alle comunità locali. Esse mostrano come, anche in contesti molto diversi, uno centrale e multietnico e l’altro periferico e popolare, sia possibile costruire infrastrutture del possibile in cui le disuguaglianze vengono contrastate con relazioni, diritti, cultura e solidarietà.
Altri Poli civici sono nati guardando ai modelli Esquilino e Quarticciolo e si stanno irrobustendo con il sostegno di Roma Capitale e dei municipi di riferimento. Dal 2022 hanno preso il via e strutturato nuclei di attività in 7 quartieri: Casale Caletto nel Municipio Roma V, Torre Maura nel VI, Quadraro/Don Bosco nel VII, San Paolo/Garbatella in VIII, Laurentino Fonte Ostiense nel IX, Casaletto/Pisana nel XII, Giustiniana/Bastogi a cavallo tra il XIII e il XV. Nel 2025 ne sono previsti 3 nei Municipi III, IV e X nella forma intermedia di reti e comunità territoriali, all’interno del programma Roma Unisce 2025 dell’Ufficio “Giubileo delle Persone e Partecipazione” di Roma Capitale, in cui sono comprese varie azioni di animazione e valorizzazione territoriale.
Pur nella varietà delle configurazioni e delle priorità, legate al contesto e alle caratteristiche delle realtà di base presenti, tutti presentano: banchi alimentari, sportelli per l’abitare e la salute, educazione alimentare, laboratori partecipativi, orientamento a formazione e lavoro, supporto alla progettazione, con attività svolte in sedi che sono già nelle disponibilità di associazioni e comitati come in piazze e strade, per creare senso di appartenenza e di comunità. Il lavoro in rete ha permesso l’adozione di modulistiche e strumenti condivisi per la presa in carico e il reinvio ai servizi istituzionali più vicini, migliorando l’accessibilità e i linguaggi. La disponibilità di una parte dei beneficiari ad assumere a loro volta un ruolo attivo ha consentito di allungare la lista di famiglie e persone da contattare, di accrescere il numero degli empori solidali e di migliorare il coordinamento dei centri di distribuzione dei beni di prima necessità.
Un importante riconoscimento istituzionale è giunto con l’approvazione, a fine 2024, del regolamento dei Poli civici integrati di mutualismo solidale da parte dell’Assemblea Capitolina, per volontà della maggioranza guidata dal Sindaco Gualtieri. Il provvedimento li ha formalmente individuati come istituti di partecipazione e ha previsto, tra l’altro, un coordinamento stabile e la possibilità di iscrizione in una specifica sezione dell’Albo della Cittadinanza attiva. Malgrado la rilevanza delle misure introdotte la loro storia è ancora tutta da scrivere. Alla complicata ricerca di empatia, linguaggi e contenuti in grado di contrastare la frammentazione, la diffidenza e la disperazione si aggiungono problematiche legate a debolezze strutturali, difficoltà a reperire finanziamenti continuativi, prevalenza di micro-realtà fragili. Nonostante ciò, i Poli civici si vanno affermando come soggettività dinamiche in cui il ruolo trainante continua a essere svolto dagli attori non istituzionali che li animano, in una tensione costruttiva tra conflitto e cooperazione, tra rivendicazione e corresponsabilità, tra partecipazione e innovazione.
Alcune sfide future. Di fronte all’acuirsi delle disuguaglianze e alla progressiva ritirata dello stato sociale le città divengono luoghi privilegiati di sperimentazione di modelli alternativi di welfare. I Poli civici di mutualismo solidale, nel contesto romano, rappresentano una risposta ai bisogni emergenti radicata nella prossimità e basata sulla ricostruzione di un sistema di relazioni significative e rassicuranti. Pur agendo in condizioni di fragilità strutturale mostrano la capacità di generare capitale sociale, attivare risorse latenti e promuovere processi di partecipazione e cittadinanza attiva.
Il riconoscimento delle istituzioni avvenuto attraverso l’approvazione da parte dell’Assemblea Capitolina di un regolamento cittadino, un albo e un coordinamento non rappresentano un punto di arrivo bensì l’apertura di una nuova fase in cui la cooperazione tra amministrazione e soggetti civici potrà contribuire a indicare la strada verso un diverso welfare con al centro diritti, partecipazione e giustizia sociale. In questo senso le pratiche dal basso colmano vuoti e sono motore di innovazione democratica, ridefinendo il rapporto tra cittadinanza, istituzioni e territori.
La tenuta, l’espansione e l’urto di tale infrastruttura sociale dipenderanno prevalentemente dalla capacità di consolidare gli interventi, espandere il raggio d’azione, raffinare strategie e coordinamento. In quest’ultima direzione occorre saper dialogare fattivamente con le comunità locali in costante mutazione e con altre progettualità avviate dall’amministrazione capitolina su terreni limitrofi, come: i 6 laboratori di quartiere di Corviale, Tor Bella Monaca, Santa Maria della Pietà, Centocelle-Mistica, Quarticciolo e Bastogi promossi dall’Assessorato all’Urbanistica e alla città dei 15 minuti; le 114 “Scuole aperte” al territorio realizzate in vari quartieri dall’Assessorato alla Scuola; i 9 nuovi Poli civici culturali polivalenti, che fin dal nome riportano a una dimensione affine, con cui l’Assessorato alla Cultura sta arricchendo gli snodi del Sistema Biblioteche.
Infine, per consolidare i Poli civici di mutualismo solidale, sarà essenziale che le istituzioni comunali e municipali individuino modalità continuative di collaborazione, pensiero, sostegno e messa a disposizione di risorse, senza tuttavia compromettere i principi di autonomia organizzativa e radicamento territoriale, che rappresentano conditio sine qua non per liberare appieno la forza generativa delle comunità locali.