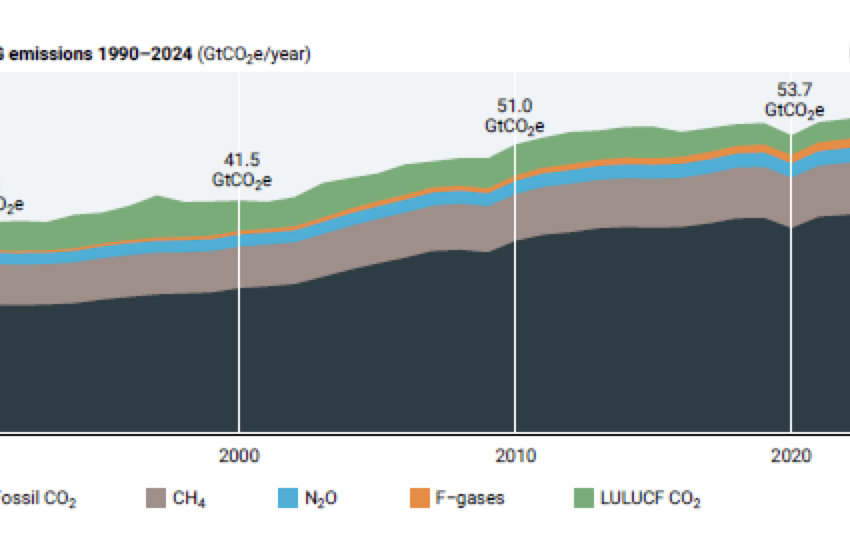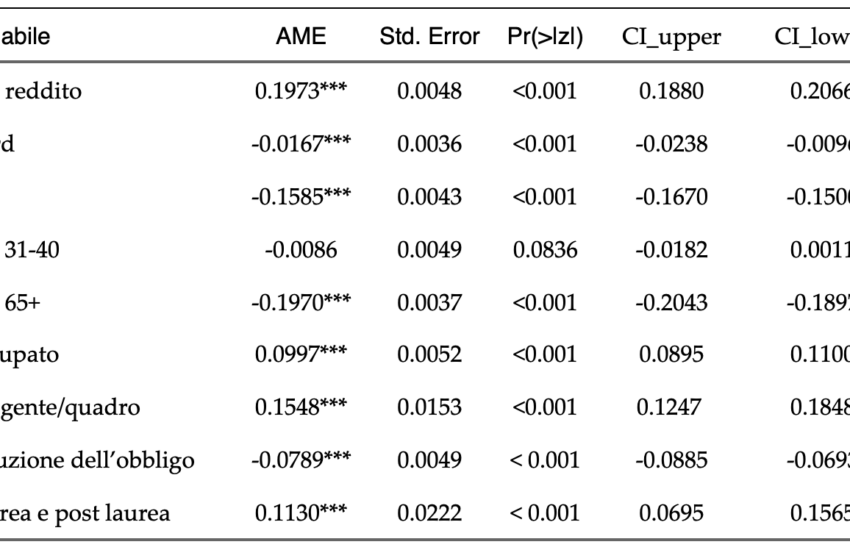Coronavirus e farmaci antivirali: il caso dei felini
Dall’incontro con un gatto alla scoperta della FIP (e di una possibilità di cura). I pranzi di Natale sono sempre difficili da digerire, specialmente se vengono celebrati nelle proprie mura. È per questo che, con la mia compagna Michela e suo figlio Giulio, salutati i commensali decidiamo di saltare la cena e fare rotta per l’Appennino. È una serata fredda e nevosa, e l’idea di infilarcisi piace a tutti i reduci del Natale romano. Arrivati ad Ovindoli, notiamo aggirarsi nella neve un gattino dall’aspetto molto socievole. Con noi viaggia anche Medea, la gatta velista dell’Egeo che circa quattro anni fa ha deciso di adottarmi. Da tempo avevo la tentazione di proporle una compagnia felina, sempre frenata dalla sua evidente preferenza per gli umani. La simpatia del gatto abruzzese, insieme alla spiccata predisposizione all’animale di Michela, fa presto vincere la tentazione: l’abruzzese si aggiunge alla strana famiglia, mostrando di preferire le minacce dell’altro felino a quelle del freddo. Il gattino ha presto un nome, Sebastiano, un po’ in omaggio al patrono di Ovindoli, un po’ al personaggio di Don Bastiano, interpretato da Flavio Bucci ne “il Marchese del Grillo”.
Il progetto di convivenza felina svanisce presto: la prima visita veterinaria stabilisce che Sebastiano ha contratto un virus ad alta trasmissibilità, il che sconsiglia la convivenza con altri gatti. Mia madre, non senza qualche lamentela iniziale, accetta la “proposta” di nuova compagnia.
Agli inizi dello scorso Aprile, mia madre mi comunica che Sebastiano ha di recente smesso di mangiare e tende ad isolarsi, il che non è in linea con il suo carattere, orientato all’”esplosivo”. Lo prelevo il giorno stesso per una visita veterinaria, che evidenzia un versamento pleurico bilaterale. Sebastiano respira con difficoltà e le immagini suggeriscono la presenza di una massa mediastinica. Il ricovero è obbligatorio, il gatto è a rischio di vita. Si sospetta un linfoma, compatibile in comorbidità con il suo problema rilevato, per la verifica del quale viene effettuata una indagine citologica. L’indagine non fornisce esiti rilevanti, il che – dicono i veterinari – può accadere e non necessariamente indica assenza della neoplasia. Sebastiano continua il ricovero per l’aspirazione periodica del versamento e le terapie di sostegno.
A versamento pleurico ridotto, anche per considerazioni di ordine economico, decido di continuare le cure a casa e di procedere a controlli periodici. In uno di questi, viene avanzata l’ipotesi di una infiammazione indotta daun coronavirus felino, il che – senza altre spiegazioni e per mia ignoranza – un po’ mi rincuora. Il contatto diretto con un essere sempre più sofferente, ridotto a scheletro, che sembrava comunicare – con dignità animale – una richiesta di aiuto, mi obbliga presto a mollare lo sconforto (di cui inizialmente mi vergognavo, date le vicende degli umani che ci propone il nostro mondo) ed assumere un approccio attivo, ricorrendo alla “rete” per trarre informazioni. Sfrutto la mia posizione accademica per accedere alle banche dati dell’informazione scientifica sul coronavirus enterico felino (FECV), che immediatamente mi rimanda a quella sulla peritonite infettiva (FIP).
Scopro che la FIP, di cui non sapevo nulla, deriva da una mutazione del FECV in FIPV, che il FECV ha una diffusione molto alta tra i gatti (80-100% per i randagi; 25-40% per i domestici), che una frazione prossima al 20% muta in FIPV e che solo una piccola frazione di gatti FIPV (2-6%) sviluppa la peritonite. Questi numeri “ballano” un po’ tra i diversi studi, ma questo non mi stupisce, dato “lo storico” della mia disciplina accademica. Imparo che lo sviluppo della patologia mostra relazioni con la struttura immunologica (il che spiega la maggiore incidenza nei gatti giovani), genetica (il che spiega la caratterizzazione per razza dell’incidenza) e demografica (maggiore incidenza in colonie feline e allevamenti).
La malattia si presenta in due versioni, “secca” e “umida”. La prima, meno comune, ha un decorso assimilabile a una patologia cronica ma letale, si sviluppa in masse localizzate, che spesso coinvolgono il sistema nervoso centrale, dando origine a sintomatologia neurologica. La seconda, più comune e a progressione letale veloce, si manifesta attraverso la produzione di liquido da infiammazione, comunemente nell’addome, più raramente nel torace, viscoso e di colore giallastro,. La trasmissibilità del FIPV sembra essere modesta, anche se la presenza di virus nelle secrezioni di gatti FIP-conclamati rende ammissibile lo sviluppo di eventi epidemici.
Scopro inoltre che, date le somiglianze con i coronavirus umani, la ricerca di un vaccino ha riguardato anche il FIPV, con esiti insoddisfacenti. L’insuccesso ha motivazioni collegate sia alla necessità (immunologica) di vaccinare ad età per cui l’animale è già venuto a contatto con il virus, sia all’effetto di potenziamento mediato dagli anticorpi (ADE) generati, che divengono loro stessi veicolo del virus. Qualche prospettiva sembra emergere sul fronte delle piattaforme vaccinali a mRNA, che alla produzione di anticorpi associano l’induzione di una forte risposta dei linfociti T. Nessuna evidenza di successo sul fronte della stimolazione immunitaria con interferoni.
Continuando nella ricerca della letteratura scientifica, noto i numerosi riferimenti agli studi coordinati da Niels Pedersen, oggi Emerito presso la School of Veterinary Medicine di UC-Davis. Da questi e molti altri lavori scientifici correlati deduco che la sperimentazione di farmaci antivirali fornisce una seria possibilità di cura per la FIP. In particolare, un articolo del 2018 del gruppo di UC-Davis sembra essere il “game-changer” della lotta alla FIP. Lo studio mostra una efficacia molto elevata e tempestiva del farmaco antivirale Gilead Science GS-441524, successore della molecola GS-5734, sintetizzata per tentare di inibire la replicazione di molti virus tra cui Ebola, Junin, Lassa, Nipah, Hendra, MERS e SARS.
Un segnale che gli antivirali potessero essere una strada percorribile era stato dato dalla sperimentazione veterinaria dell’inibitore di proteasi GC-376, i cui discreti effetti sono risultati significativamente migliorati dal nuovo farmaco. La logica di funzionamento del farmaco GS è alquanto chiara anche ad un economista: inibizione della replicazione virale attraverso l’incorporazione della molecola nel trascrittore virale. Lo studio del 2018 mostrava persistenza della remissione a 10 mesi dal trattamento, tossicità trascurabile e una discreta tolleranza all’inoculazione subcutanea da parte del gatto.
La lettura dell’articolo del 2018 e di altra letteratura correlata, nonché l’evidenza (non sperimentale) emersa dal trattamento di recenti episodi epidemici a Cipro e in Europa centrale con un derivato di GS-5734 (Remdesivir), mi convince che quella del GS può essere una strada percorribile. I dubbi sulla traducibilità della mia “etica della terapia” (se c’è una possibilità di cura, la si adotta) agli animali venivano meno, data l’alternativa rilevante (ossia la morte certa di Sebastiano), i parametri di tolleranza sperimentati e, non da ultimo, la circostanza che il peso economico, che sarebbe ricaduto esclusivamente su me e Michela, era alla nostra portata.
Il farmaco che non c’è: GS-441524 e mercati illegali. Una veloce ricerca, e alcuni articoli su quotidiani, chiariscono presto che questa possibilità terapeutica, mancando di approvazione da parte delle autorità sanitarie europee e nazionali, è illegale per l’uso veterinario, tanto in Italia quanto nell’Europa dell’Unione. Il farmaco, di produzione cinese, è reperibile solo attraverso piattaforme di vendita online, dalle quali è impossibile derivare una base minimamente oggettiva sul contenuto, la qualità e la sicurezza del prodotto. Scopro inoltre che è in atto proprio in quei giorni un dibattito sulla questione, a cui si associa una chiara pressione mediatica e politica per l’approvazione, in Italia soprattutto da parte delle associazioni dei medici veterinari, oasi feline, e di alcuni parlamentari M5S e PD.
Deduco che ho due possibilità: guadagnarmi il sostegno e l’indirizzo al mercato illegale da parte del veterinario che segue Sebastiano, o chiedere sostegno a mia cugina, che è immunologa ospedaliera e ha avuto a che vedere con il Remdesivir. Il farmaco di derivazione GS-5734 è stato utilizzato per trattare il Covid-19, quindi approvato negli Stati Uniti nell’Ottobre 2020 e adottato in sperimentazione congiunta con la Cina, che ne ha riprodotto la molecola. Il farmaco è stato adottato presso lo Spallanzani di Roma per il trattamento dei due “index patients” cinesi che hanno preceduto l’esperienza pandemica. Questo farmaco, ad uso umano e alto costo, costituirà la soluzione nazionale ai vincoli europei all’uso veterinario della sua forma attiva GS-441524.
Siamo al 12 di Aprile, e con la mia compagna sperimentiamo la prima possibilità. Per sostenerla, colleziono una selezione della letteratura scientifica esaminata, che Michela avrebbe portato al veterinario di Sebastiano durante una visita di controllo. L’idea era di sottolineare che le informazioni che producevo avevano basi scientifiche e che intendevamo procedere alla cura. In effetti mancava ancora un passaggio: nessuno ci aveva detto che si trattasse di FIP, e la diagnosi non è agevole. Le mie letture segnalavano che esisteva una tecnologia diagnostica di una certa affidabilità (RT-PCR – Real Time Polymerase Chain Reaction), che identifica, almeno statisticamente, la presenza di materiale genetico FIPV. Ma i dati sulla letalità della FIP, insieme a quelli di efficacia e tossicità del GS, consigliavano di procedere immediatamente alla somministrazione del farmaco anche in assenza di indicazione diagnostica. Sarebbero stati gli effetti osservabili, se verificati, a confermare o meno l’ipotesi di FIP. Il veterinario ha immediatamente sostenuto questa linea, ci ha suggerito una piattaforma di acquisto già verificata per altri due pazienti, ma ha comunque proceduto alla raccolta delle effusioni polmonari per l’analisi RT-PCR, riscontrandovi i caratteri FIP. Il liquido è stato inviato ad un laboratorio di Padova di elevata affidabilità ed esperienza. Il risultato del test, disponibile solo dopo l’inizio della terapia GS, darà esito positivo.
Il GS-441524 viene acquistato online in fiale iniettabili al prezzo di circa 70 euro. La strategia terapeutica che appare condivisa richiede 84 giorni di somministrazioni (12 settimane, corrispondenti in via approssimativa alla vita del virus non replicante nel gatto), che al dosaggio suggerito di 6-7mg/Kg e considerato il peso medio attuale e prospettico di Sebastiano, stimo ammontare a circa 1500 euro. L’eventuale passaggio ad una seconda fase di terapia orale, che sebbene meno sicura per effetto della variabilità individuale dell’assorbimento del farmaco è spesso preferibile per prevenire granulomi e piaghe nei siti di inoculazione, aggiunge alla stima ulteriori 200 euro. Ciò solleva evidenti questioni di sostenibilità economica per i possessori di animali, ed è immediato pensare che l’approvazione del farmaco sia solo un primo passo – certamente necessario – di una strategia di cura che risponda a criteri minimi di uguaglianza nelle possibilità terapeutiche.
Remdesivir e suo processo di approvazione. Che prospettive per il GS-441524? Le pressione esercitata dai proprietari di felini, dalle associazioni veterinarie e da alcuni parlamentari, hanno indotto alla recente adozione del Regolamento di esecuzione UE 1974/2024, approvato nel luglio 2024 per entrare in vigore solo l’8 agosto 2026. Il regolamento stabilisce la possibilità di fatto della prescrizione in deroga del Remdesivir ad uso veterinario a livello nazionale. Pur trattandosi di un farmaco per uso umano, Remdesivir non è infatti compreso nella lista degli antivirali ad uso esclusivo (Regolamento di Esecuzione UE 1255/2022), né sussistono ad oggi restrizioni per situazioni pandemiche in ambiente umano. Il regolamento chiarisce che “Il Remdesivir può essere impiegato ai sensi dell’articolo 112 del regolamento (UE) 2019/6 esclusivamente per il trattamento della peritonite infettiva felina”. Ciò apre la strada alle soluzioni nazionali in deroga, come avvenuto in Italia con la recente circolare esplicativa del Ministero della Salute, che di fatto anticipa di un anno la possibilità dell’uso veterinario del Remdesivir.
Sebbene la legalizzazione di prassi terapeutiche incontrollate in atto non possa che avere effetti positivi sulla sicurezza del farmaco, sulla tracciabilità delle malattie, sulla valutazione della loro prevalenza in popolazione e della loro efficacia, la recente approvazione per uso veterinario solleva alcuni altri dubbi.
Remdesivir e GS-441524 hanno efficacia paragonabile? La conversione in vivo del primo nel metabolita del secondo, l’esperienza di Cipro e i pochi studi comparativi sembrerebbero dare risposta affermativa, anche se la dimensione della popolazione randomizzata in tali studi può sollevare, dal punto di vista della validità interna ed esterna dell’esperimento, numerosi dubbi.
La legalizzazione del Remdesivir avrà effetti sul costo complessivo della terapia? Remdesivir viene venduto in EU al prezzo di 390 euro a fiala. Con un profilo terapeutico paragonabile al GS illegale per dosaggio e tempi, ed in assenza di modifiche per l’uso veterinario, la sostenibilità economica della terapia approvata potrebbe risultare impraticabile per molti (ho la sensazione che la popolazione animale domestica sia ugualmente distribuita su una popolazione molto diseguale).
Quali sono i motivi della mancata approvazione del GS-441524 per uso veterinario in EU? Su questo, anche alla luce delle evidenze scientifiche per l’uso veterinario del GS e delle vicende dell’approvazione del Remdesivir per l’uso umano, non c’è molta chiarezza. Si consideri che GS non ha ancora ricevuto l’approvazione per uso umano, il che spiega sia la scelta della regolamentazione UE e delle soluzioni nazionali, sia la riluttanza di Gilead a procedere per l’uso veterinario, che potrebbe influire in negativo sul prezzo praticabile per uso umano. Questo tuttavia non spiega l’approvazione e l’utilizzo del farmaco dal 2021 in Inghilterra e Australia.
Sebastiano. Sebastiano inizia la terapia GS per inoculazione il 16 Aprile, con un peso di soli 2,4 Kg (dai 3,4 pre-FIP). I primi effetti sull’appetito emergono dopo il primo giorno di somministrazione. La frequenza respiratoria si normalizza e la vitalità aumenta in modo sorprendente già dal secondo/terzo giorno. Il versamento pleurico, che con le terapie palliative richiedeva rimozioni a frequenze di tre/quattro giorni, risulta pressoché risolto ad una settimana dalla prima somministrazione. Il peso aumenta con l’aumento dell’appetito (il che aumenta anche il costo della terapia). A un controllo a due settimane non si riscontrano tracce di versamento, ed il peso è salito ad oltre 3 Kg. Dopo le prime sei settimane, la terapia sottocutanea viene sostituita da quella orale, il che mi rende la vita molto più facile, per ovvie ragioni.
Oggi siamo a 10 settimane, e Sebastiano sembra mantenere una buona forma. Non posso che condividere, sul piano emozionale, le indicazioni di molti professionisti che definiscono la cura “miracolosa”. Sul piano razionale, gli esiti sembrano piuttosto sottolineare la rilevanza della ricerca scientifica e del suo finanziamento. Le vicende di approvazione del GS, d’altra parte, costituiscono un ulteriore segnale di allarme sui potenziali conflitti che le soluzioni di mercato possono innescare, a danno degli interessi collettivi e delle possibilità effettive di accesso alle cure. Tali rischi si realizzano anche in presenza di agenzie di controllo pubblico, potenzialmente attraverso estesi e potenti meccanismi di “cattura”, che varrebbe la pena investigare.