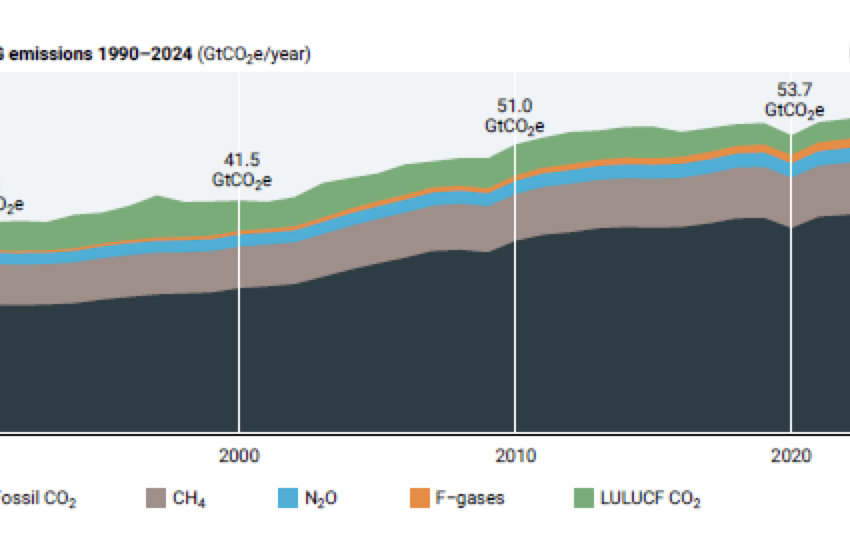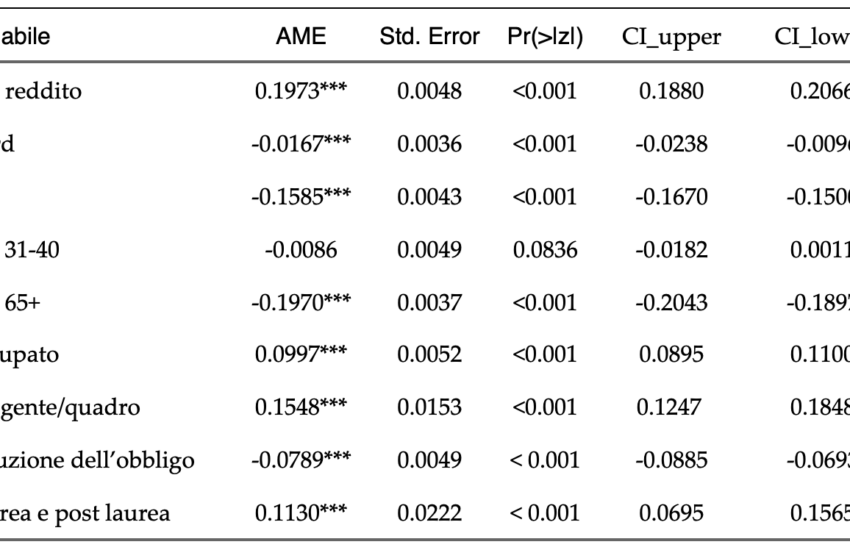Per una globalizzazione giusta: Piketty e Sandel a confronto
“[…] Quanti, come noi, criticano il flusso senza restrizioni e non regolamentato di capitali e merci attraverso i confini tendono però a prediligere politiche di immigrazione più generose, ovvero il flusso di persone attraverso i confini. E quanti si collocano a destra del centro tendono a criticare l’aumento dei livelli di immigrazione, pur sostenendo e promuovendo il libero flusso di capitali e merci. Quale delle posizioni è incoerente?”
Questa è una delle domande, certo non priva di interesse, che Michael Sandel rivolge a Thomas Piketty in occasione di una loro conversazione, tenutasi a Parigi il 20 maggio 2024, presso la Paris School of Economics (PSE), e pubblicata integralmente in Uguaglianza. Che cosa significa e perché è importante (Feltrinelli, 2025). La conversazione, e dunque il libro, si sviluppa in una serie di interrogativi relativi a nove temi che alternativamente i due intellettuali pongono l’uno a all’altro. In particolare, la domanda citata è racchiusa nel tema “4. Globalizzazione e Populismo”. Le altre otto questioni sono: “1. Perché dobbiamo preoccuparci della disuguaglianza?”, “2. Il denaro dovrebbe contare meno?”, “3. I limiti morali dei mercati”, “5. Meritocrazia”, “6. Lotterie: dovrebbero avere un ruolo nelle ammissioni alle università e nella selezione dei parlamentari?”, “7. Tassazione, solidarietà e comunità”, “8. Confini, migrazioni e cambiamenti climatici”, e “9. Il futuro della sinistra: economia e identità”.
Non è facile rintracciare, almeno per la mia lettura, risposte articolate alla domanda riportata poco sopra, neanche negli altri capitoli del libro. Ciò non vuol dire che non vengano affrontati argomenti di interesse sul tema della globalizzazione nelle sue tre dimensioni: capitali, merci e persone. Argomenti che possono aiutarci ad abbozzare una risposta.
Il primo è introdotto da Piketty nella sua immediata risposta (se così vogliamo chiamarla) alla domanda di Sandel. Si tratta del populismo. Parlando di reazioni agli eccessi della globalizzazione, egli rigetta l’idea che oltre a un populismo di destra, di cui la prima (e ancor di più la seconda) amministrazione Trump è un chiaro esempio, vi sia anche un populismo di sinistra. L’idea è di Michael Sandel che, forse inaspettatamente, ha incluso tra i populisti, Bernie Sanders. Infatti, Thomas Piketty sottolinea che “[…] dovremmo stare molto attenti a distinguere tra le diverse risposte agli eccessi della globalizzazione. C’è la risposta di tipo nazionalistico – che vediamo con Trump, con Le Pen nel mio paese e via dicendo. Ma c’è anche quella che negli Stati Uniti è stata la risposta di Sanders, che a me piace indicare come la risposta socialista democratica”.
Dopodiché chiede a Sandel di spiegare in che modo egli intende il termine “populista”, un termine che a Piketty non piace. Preferisce parlare di ideologie: nazionalista, liberale o socialista, nei vari casi. Questa è la risposta di Sandel: “[…] l’origine del termine “populista” nel diciannovesimo secolo ha a che vedere con gli operai delle industrie e i contadini quando si unirono nel tentativo di togliere potere alle élite economiche, tipicamente le élite economiche del Nord-Est (degli Stati Uniti, NdA) che controllavano le ferrovie e poi le compagnie petrolifere. Era un movimento progressista, sebbene già allora avesse in sé elementi nativisti, antisemiti e razzisti. Quindi questi due filoni – la rappresentanza del popolo contro i potenti e il filone nativista – erano presenti sin dagli esordi […]”.
Piketty dissente ed emerge con chiarezza il suo principale timore: il possibile uso strumentale dell’accusa di populismo a chi avanza proposte socialdemocratiche – non solo di carattere redistributivo, come fa Sanders – con lo scopo di indebolirle ed escluderle dal dibattito politico. Ad avere questa tentazione sarebbero soprattutto i politici mainstream del centro-sinistra coloro che, negli Stati Uniti, hanno manovrato le leve del potere dopo la rivoluzione liberista di Reagan (e Thatcher), rafforzando il libero mercato e la finanza, contribuendo ad affossare le politiche redistributive e la tassazione progressiva che sta massimamente a cuore a Piketty.
Sandel sostanzialmente concorda sulle critiche, motivate come si è appena detto, a Clinton e Obama, e aggiunge l’interessante opinione che, a suo avviso, la difesa del mercato da parte dei politici non di destra, al contrario di questi ultimi, non si basa sull’argomento che il libero mercato realizza il bene comune; piuttosto egli ritiene che il mercato permette di prendere – a modo suo – decisioni che sarebbero assai problematiche da prendere, a causa dei conflitti, in altro, più democratico, modo.
Per quanto intrigante, questa discussione aiuta poco nel tentativo di formulare una risposta alla domanda in apertura. Qualche elemento più pertinente lo offre un’affermazione di Piketty, secondo cui occorre controllare i flussi di capitale e di merci perché se non lo si fa si rafforzerà la posizione di coloro che vogliono controllare i flussi di lavoro.
Fondata o meno che sia, una possibile chiave di lettura di questa tesi è che la posizione liberista nei confronti dei flussi di capitali e merci, ma protezionistica nei confronti dei flussi di persone, fa riferimento a una posizione ascrivibile a un segmento della società e motivata da ben individuabili interessi materiali.
Questo rende allora evidente che a dare coerenza alle due affermazioni di cui alla domanda in apertura è la posizione in cui ciascuno si trova, o in cui prevede di trovarsi, dopo l’adozione di politiche favorevoli o sfavorevoli all’una o all’altra dimensione della globalizzazione. Si tratta di un punto tutt’altro che irrilevante che spinge a chiedersi se non occorre valutare, più che la coerenza delle due affermazioni, eventualmente la loro diversa rilevanza sotto il profilo valoriale.
Qui dovrebbero entrare in campo le modalità per assumere decisioni sociali in modo equo. Una di esse, decisamente importante, è quella suggerita da John Rawls che, per diversi motivi, viene citato dai due intellettuali nella loro conversazione, anche con toni critici, peraltro già usati da Sandel in alcuni suoi precedenti lavori.
Piketty fa riferimento a Rawls perché il filosofo non avrebbe preso posizione a favore della tassazione progressiva proprio negli anni in cui stava per essere smantellata. E, non sorprendentemente, date le sue convinzioni, la stessa critica muove a Sandel, al quale dice: “tu non prendi posizione sulla tassazione progressiva o su altre questioni politiche concrete, come vorrei che facesse un filosofo. Quindi, voglio lanciarti una sfida: se vogliamo dare più dignità al lavoro, non dobbiamo forse comprimere seriamente la scala dei redditi, la scala dei salari? Non dobbiamo forse vincere questa battaglia intellettuale con l’aiuto di filosofi come te?”
Alla sfida di Piketty, Sandel risponde: “D’accordo, è una grande sfida, ma lo è nella misura in cui posso rispondere a nome dei filosofi, non meno che a nome mio. Innanzitutto, a nome dei filosofi, lasciami spendere una parola – circostanziata, intendo – in difesa di John Rawls, nei cui confronti, hai ragione, io sono critico. Penso che sia possibile giustificare un sistema fiscale più incisivamente progressivo ricorrendo all’idea di Rawls del principio di differenza, dell’aiutare i membri meno avvantaggiati della società, e sostenendo che a richiederlo è la sua stessa concezione di giustizia. È in questi termini che è possibile condurre la difesa di Rawls e intendo farlo, per quanto possibile”.
E prosegue sostenendo che, a suo avviso, la principale debolezza di Rawls è stata quella di voler “definire e difendere i principi di giustizia indipendentemente dall’affermazione di una qualsiasi particolare concezione del bene o della vita buona. La mia argomentazione principale era che non è possibile, e non è auspicabile, separare le questioni della giustizia o della distribuzione dalle questioni della vita buona o della valutazione […]”.
Sandel si riferisce all’idea di giustizia di Rawls basata sulla situazione ipotetica chiamata “posizione originaria”, in cui i partecipanti alla definizione delle regole della comunità agiscono sotto un velo d’ignoranza. Questo significa che non sanno nulla della propria situazione personale: non conoscono la loro età, il loro genere, la loro etnia, la loro classe sociale, le loro abilità fisiche o mentali, o qualunque altra caratteristica che potrebbe influenzare i loro risultati socioeconomici e, dunque, i loro interessi. Essendo ignari di queste informazioni, i partecipanti adotteranno principi di giustizia equi per tutti. In altre parole, decisioni prese sotto il velo d’ignoranza porterebbero verso una società che è giusta in ogni possibile scenario.
Applicato al nostro problema, questo approccio darebbe il seguente esito: se ai possibili scenari aggiungiamo anche il Paese di nascita, il velo d’ignoranza porterebbe a preferire politiche migratorie accoglienti. Mentre non sarebbe necessariamente così per le politiche commerciali o di regolamentazione dei flussi di capitali.
Tuttavia, le decisioni nel mondo reale non vengono prese ispirandosi a ciò che si sceglierebbe sotto il velo di ignoranza. Torna, così, la questione degli interessi e ad attenuare questi ultimi può essere, nelle parole di Sandel, “la capacità di fare appello a un forte senso di comunità e di coltivarlo, e in ciò intendo quel senso forte che, in quanto concittadini, sentiamo nell’impegnarci in un progetto comune che ci rende responsabili e debitori verso gli altri”.
Questo, però, potrebbe portarci in un vicolo cieco. Infatti, lo stesso Sandel non sa come coniugare il senso di solidarietà e di comunità enunciati con la dimensione internazionale. Nel capitolo 8 “Confini, migrazioni e cambiamenti climatici” ammette: “Tutto ciò suscita però un interrogativo ancora più complicato, che ha a che vedere con la dimensione transnazionale dell’uguaglianza e della disuguaglianza, di cui hai scritto (si riferisce a Piketty, NdA). Si tratta di una sfida particolare, se concordiamo sul fatto che una società più equa dipende da legami più forti tra i cittadini. Hai ragione nel dire che qualsiasi progetto di uguaglianza debba avere una dimensione transnazionale, su questo punto sono d’accordo, ma pensi che sarà davvero possibile? A cosa assomiglierebbe? È possibile creare forme di lealtà e appartenenza al di là dello Stato nazione?”.
Se un mondo più equo è un mondo in cui prevale maggiore apertura nei flussi di persone e maggiore cautela rispetto ai flussi di merci e di capitali, quanto afferma Sandel equivale a collocare a grande distanza da noi quel mondo. Ma è quello il mondo che Piketty predilige e con ragionevoli argomenti, ai quali aggiunge la considerazione che la comunanza può essere anche la conseguenza di una minor disuguaglianza e non solo la sua causa.
In conclusione, alla domanda se vi sia coerenza nell’avere atteggiamenti diversi rispetto ai flussi di persone, da un lato, e di merci e capitali, dall’altro, la risposta è che può esservi piena coerenza con i propri interessi, ma che non è indifferente dal punto di vista della giustizia sociale quale delle due posizioni prevalga. Averlo suggerito, anche se non sempre in modo chiaro e lineare, è certamente un merito di questo capitolo del libro di Piketty e Sandel.