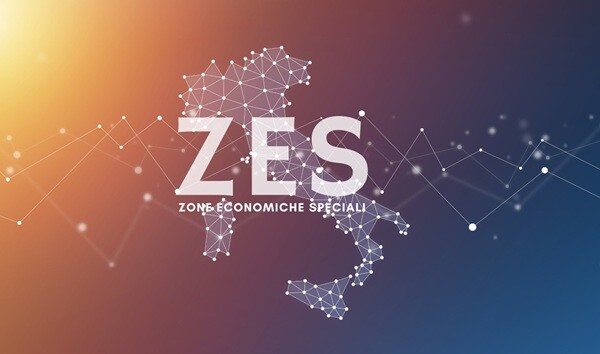Disuguaglianze e welfare di prossimità: la sfida dei Poli civici
Le città come specchio e laboratorio delle disuguaglianze. Le disuguaglianze rappresentano uno degli aspetti più evidenti e drammatici dell’attuale fase di sviluppo del capitalismo. Esse si manifestano in forme molteplici: tra gli Stati, dove le differenze di ricchezza e accesso alle risorse sono spesso abissali, nonché all’interno dei singoli Stati. Le grandi aree metropolitane costituiscono in tal senso un osservatorio privilegiato, i laboratori in cui si manifestano con maggior evidenza i divari, in particolare in tema di reddito, sanità, istruzione, lavoro, trasporto pubblico: da un lato quartieri benestanti con servizi efficienti, dall’altro aree marginalizzate che soffrono di carenze infrastrutturali ed esclusione sociale; da una parte i ricchi, dall’altra i poveri. Sono proprio i segmenti marginali, contraddittori e poveri, neanche a dirlo, quelli più esposti dal punto di vista ambientale a inquinamento ed eventi climatici estremi (S. Sassen, La città globale. New York, Londra, Tokyo. Einaudi, 2001).
Del resto, le città contemporanee svolgono oggi il ruolo che nel XIX e XX secolo era appannaggio di Stati e Imperi: sono il cuore pulsante delle dinamiche economiche, sociali e ambientali. In esse vive la maggior parte della popolazione mondiale, circa 4,5 miliardi di persone, attratta da opportunità di lavoro, reddito, casa e vita dignitosa. Ma in esse si concentrano anche le contraddizioni più gravi: lavori precari e sottopagati, redditi insufficienti, povertà di ogni genere, abitazioni inadeguate, crescenti sofferenze sociali, gentrificazione, overtourism.
La crisi del welfare e l’emergere di risposte autorganizzate. Le persone collocate ai margini della società sperimentano una forma ulteriore di esclusione, tutt’altro che simbolica: la perdita di voce pubblica, di rappresentanza politica e di senso di appartenenza. Le disuguaglianze contemporanee, in sintesi, associano l’isolamento, l’erosione dei legami comunitari e la disillusione nei confronti del cambiamento alla povertà economica e alla difficoltà di accesso ai servizi essenziali.
Con la progressiva ritirata dello stato sociale le disparità si sono inasprite ulteriormente e hanno reso urgente la necessità di ripensare i luoghi della comunità e della solidarietà. In numerosi contesti territoriali, soprattutto laddove più marcate sono le conseguenze in termini di esclusione e marginalità, si sono diffuse esperienze autogestite di diversa natura promosse da soggetti civicie attori extra-istituzionali, quali associazioni, comitati, cooperative, movimenti, reti informali. Il riferimento storico più significativo di questo modello è rappresentato dalle Case del Popolo, sorte agli inizi del Novecento come centri di aggregazione e socializzazione del movimento operaio (A. Cori, F. Linguiti, S. Monni, “The Experience of Cooperative Clubs and Houses of the People in Italy as Places for Developing Social Human Rights“, in Economic Systems and Human Rights, a cura di F. Vigliarolo, Palgrave MacMillan, 2024).
Un’esperienza che, sebbene in forme differenti, ha conosciuto una riattualizzazione in tempi recenti. Basti pensare alla diffusione dei centri sociali nei quartieri popolari delle grandi città italiane a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso, all’espansione del volontariato e del terzo settore dagli anni Novanta, nonché al ruolo costante svolto da parrocchie e comunità religiose, talvolta ultimi presìdi contro la desertificazione e l’isolamento. Operando in condizioni di informalità e a volte varcando la soglia della legalità, all’interno di spazi recuperati come ex scuole, fabbriche, uffici, caserme, cinema o ospedali dismessi, hanno rigenerato il tessuto urbano, prodotto valore per i destinatari diretti e per l’intera comunità, promosso aggregazione, fiducia, partecipazione, sport, cultura e pratiche collettive al di fuori di ambiti familiari e lavorativi.
In certi momenti queste esperienze sono state oggetto di stigmatizzazione, etichettate come “ghetti-rifugio” per soggetti considerati marginali, migranti, sottoproletariato urbano, donne, giovani disoccupati, come se l’operare sul confine tra insider e outsider costituisse un demerito piuttosto che un merito. In altri frangenti, invece, se ne è riconosciuto il valore come risposte concrete e strutturate alla crisi del welfare tradizionale e si sono affermate, in assenza di interventi pubblici adeguati, come modelli dal basso o ibridi (tra pubblico, privato e cittadinanza attiva) portatori di soluzioni flessibili, contestualizzate e immediatamente operative.
Dopo un periodo in cui l’impegno e la cittadinanza attiva avevano subito una flessione, durante la pandemia le realtà civiche e solidali hanno trovato la forza di reinventarsi in logica di rete e di escogitare inediti meccanismi di coordinamento e azione tra realtà piccole, medie e grandi, fino a diventare l’unico soggetto in campo a fronteggiare l’azzeramento di relazioni e socialità, svariando dalla distribuzione alimentare alla sensibilizzazione sui comportamenti fino a iniziative per tenere in piedi i capisaldi del vivere in comune. Da esse sono maturati nuovi profili di responsabilità sociale e partecipazione civica che hanno generato consenso, attivato le amministrazioni locali e inaugurato una stagione di politiche orientate alla riformulazione del welfare intorno al “paradigma della cura” (L. Turco, Costruire un nuovo umanesimo, Fondazione Nilde Iotti, 2020).
Torino, Milano, Napoli, Bologna: quattro città, molte risposte. Negli anni successivi in varie città si sono sviluppate reti di diversa tipologia che però hanno raccolto l’eredità di quelle sorte in reazione all’emergenza sanitaria che, pur radicate in specifici contesti, hanno assunto rilevanza oltre i confini locali, nonostante l’assenza di un quadro normativo favorevole e il limitato sostegno da parte del governo centrale.
A Torino si è consolidato il modello delle case di quartiere, avviate nel 2012 a partire dalle pratiche autogestite preesistenti e successivamente evolutosi in una forma organizzativa più strutturata, grazie al coinvolgimento sinergico di cittadinanza, associazioni, organizzazioni del terzo settore, Città di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo e altri enti filantropici (E. D’Alessandro, R. Rizza, “Le case del quartiere: nuove forme di welfare comunitario a Torino” in Innovazione e ricerca sociale 2015; F. Benini, Politiche del quotidiano: il modello delle Case di Quartiere a Torino, 2025). Esse fungono da presidi civici multifunzionali, offrono una vasta gamma di servizi e includono attività culturali, iniziative di welfare, percorsi formativi, orientamento al lavoro, supporto alle fasce sociali più fragili e promozione della partecipazione artistica e sportiva. Sono distribuite capillarmente nelle 8 circoscrizioni della città e il loro impatto sul tessuto urbano è rilevante: contribuiscono a rafforzare il senso di comunità, attivano opportunità occupazionali e promuovono il riuso e la valorizzazione del patrimonio pubblico (Benini, cit.).
A Milano si è sviluppata una rete articolata di spazi ibridi e di mutualismo, orientata all’inclusione, alla solidarietà e alla promozione culturale. Attivati su spinta delle realtà di base, con il sostegno di fondazioni e amministrazione comunale, si configurano come imprese sociali per l’inserimento lavorativo di persone con svantaggio e, contemporaneamente, come laboratori di welfare di prossimità, in cui particolare attenzione riveste la dimensione dell’accoglienza e dell’aggregazione. Tra le più significative e compiute si segnalano Rob de matt e Olinda, quest’ultimo emblematicamente collocato nell’ex ospedale psichiatrico Paolo Pini. Accanto a tale novità, a indicare l’effervescenza che caratterizza il capoluogo lombardo vi è una diffusa presenza di spazi di welfare territoriale: case di quartiere, centri sociali storici come il Leoncavallo, laboratori di quartiere, case delle associazioni.
A Napoli la Rete dei Beni comuni e degli Usi civici ha dato vita a un processo di riappropriazione e riattivazione di patrimonio pubblico inutilizzato, secondo i principi della governance partecipativa. Collettivi, associazioni e cittadinanza promuovono modelli di gestione inclusiva, fondati sull’accessibilità universale e sull’autogoverno dei Beni comuni. Esempi emblematici sono rappresentati dall’Ex OPG Je so’ pazzo, dall’Ex Asilo Filangieri e dallo Scugnizzo Liberato, che si configurano come presìdi socioculturali e di mutualismo in quartieri caratterizzati da elevata vulnerabilità socioeconomica (G. Micciarelli, L’uso civico e la rete dei beni comuni emergenti. Comune-info, 2018). L’impulso al cambio di passo è stato raccolto dal Comune di Napoli che ha introdotto il dispositivo dell’uso civico, trasferendo nella normativa le pratiche dal basso per sostenerne gli sforzi.
A Bologna il modello dell’amministrazione condivisa fin dal 2014 ha dato ulteriore vitalità a pratiche già esistenti di collaborazione tra cittadinanza attiva e istituzioni, attraverso lo strumento dei patti di collaborazione. A 10 anni dal regolamento in materia si è rilanciato, puntando su un uso integrato di patti, co-programmazione, co-progettazione, utilizzo e valorizzazione, pensati sinergicamente per intensificarne l’efficacia.
Pur nella diversità di assetti giuridici, condizioni politiche e forme di interazione queste reti condividono un tratto essenziale: la capacità di generare valore d’uso e capitale sociale (D.Warr, T. Tacticos, M. Kelaher, “Neighbourhood Houses: Building Social Capital through Neighbourhood Renewal” In Health Promotion Journal of Australia, 2007) tramite pratiche radicate nella prossimità, per ricostruire senso di appartenenza, rafforzare legami comunitari, contrastare frammentazione, isolamento e sfiducia. Inoltre, esse agiscono da incubatori di competenze, creatività e produzione immateriale, sperimentando modelli alternativi di lavoro, economie solidali, pratiche ecologiste e femministe, scavalcando in vari aspetti le logiche dominanti del mercato e della governance tradizionale.
Nella seconda parte di questo articolo che verrà pubblicata sul prossimo numero del Menabò, ci occuperemo della città di Roma.