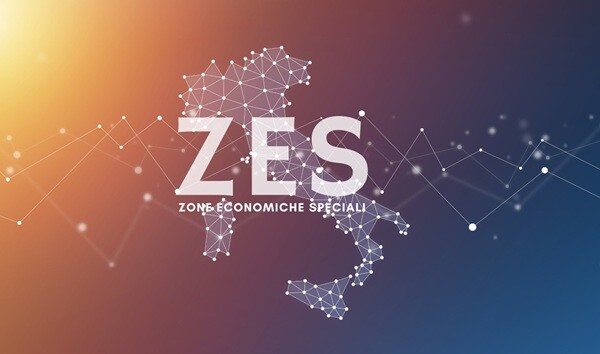Schengen e la crisi europea delle migrazioni. Nuti/3
Nel maggio del 2016 il Menabò ha pubblicato due articoli di Mario Nuti, intitolati rispettivamente “Schengen e la crisi europea delle migrazioni/1” e “Schengen e la crisi europea delle migrazioni/2”.
Gli articoli sintetizzavano i temi trattati in un seminario sulle migrazioni internazionali che lo stesso Nuti aveva organizzato alla Sapienza. A quel seminario partecipammo anche noi e in realtà fu l’occasione, graditissima, per incontrarlo nuovamente molti anni dopo la frequentazione che avemmo con lui, come giovane collega e come sua studentessa, nel Dipartimento di Economia Pubblica (oggi di Economia e Diritto) della Sapienza.
Il convegno dello scorso 7 aprile, organizzato dal Dipartimento della Sapienza per ricordarlo, ci offre l’occasione per tornare su quei due articoli e per riflettere sulle cose di cui ci piacerebbe parlare oggi con Mario in vista di un terzo articolo su ‘Schengen e la crisi europea delle migrazioni’.
È bene partire dall’ idea che Nuti aveva del fenomeno migratorio e dal perché avesse deciso di trattare l’argomento, lui che era uno dei massimi studiosi dei sistemi socialisti.
Rispolverando i suoi vecchi appunti sull’ascesa e la caduta del socialismo, pubblicati postumi in “Collected Works of Domenico Mario Nuti: Socialist Economic Systems and Transition” (a cura di Estrin e Uvalic), ci è sembrato di poter rintracciare nella critica senza mezzi termini della direzione di marcia imboccata dalla socialdemocrazia l’origine dell’interesse di Nuti per le migrazioni. Nel paragrafo, “La debacle della socialdemocrazia pervertita: globalista, austeritaria, ineguale” in un lungo passaggio che vale la pena riportare estesamente si legge:
[…] Tony Blair e Gerhard Schroeder riaffermavano il proprio impegno a sostenere i valori socialisti tradizionali: “Equità e giustizia sociale; la libertà e l’uguaglianza di opportunità; la solidarietà e la responsabilità verso gli altri: questi valori sono permanenti. La socialdemocrazia non li sacrificherà mai” (Blair e Schroeder, 1999). Tuttavia, il loro progetto socialdemocratico differiva drasticamente dalla socialdemocrazia tradizionale in tre aspetti principali: 1) L’accettazione del primato e della desiderabilità dei mercati, interni e internazionali, riconoscendo pienamente la loro natura globale nel mondo moderno. […] La convinzione che la globalizzazione comporta benefici per tutti, che sia una marea che solleva tutte le barche, che in ogni caso i benefici di chi li riceve per primo colano (trickle down) sul resto della popolazione, è molto diffusa (e.g. Yergin and Stanislav 1998). In realtà la liberalizzazione del commercio internazionale comporta indubbiamente dei benefici netti, ma al tempo stesso infligge perdite nette ad alcuni dei soggetti nazionali che vi partecipano. La semplice possibilità teorica di una sovra-compensazione dei perdenti da parte dei vincenti non è sufficiente a dichiarare un miglioramento del benessere generale, per il quale è fondamentale che la sovra-compensazione sia effettiva. E proprio a livello internazionale le possibilità pratiche di sovra-compensazione sono limitate dalla mancanza di organi sovranazionali di ridistribuzione […]. Infine, i vantaggi della liberalizzazione del commercio non si estendono necessariamente alla liberalizzazione degli investimenti, dei movimenti di capitale finanziario e delle migrazioni di lavoratori, né alla regolamentazione di standards, concorrenza e giurisdizione (Rodrik 2018a). […] L’attuale debacle della socialdemocrazia non è dovuta al rifiuto del modello socialdemocratico originale ma alla perversione del modello trasformatosi seguendo tendenze iperliberali, austeritarie e globaliste, non solo nel commercio ma negli investimenti, nella delocalizzazione della produzione in paesi emergenti, nei movimenti di capitali finanziari e nelle migrazioni di lavoro; tendenze che favoriscono le grandi imprese multinazionali, prosciugano ricavi fiscali incoraggiando la concorrenza fiscale fra stati, facilitano l’elusione e l’evasione fiscale con la proliferazione di paradisi fiscali, e così limitano le possibilità di intervento dei governi. Questa è la socialdemocrazia pervertita che oggi ha perso il consenso elettorale nella maggior parte dell’intero mondo sviluppato […].
È la “perversione globalista” della socialdemocrazia che ha portato Nuti a interessarsi di migrazioni internazionali e la visione assai critica di Nuti del fenomeno emerge chiaramente nel suo secondo articolo sul Menabò che ha il seguente incipit.
[…] L’eliminazione dei confini interni all’area di Schengen e l’introduzione dell’Euro hanno molto in comune. Ambedue erano ottime iniziative, ma premature e incomplete, con conseguenze negative aggravate dalla divergenza fra i paesi membri e dalle politiche di austerità imposte dall’UE. […] Sia Schengen, sia l’Euro, sono forme di accelerazione forzata dell’integrazione europea, secondo un metodo che possiamo chiamare Mission Creep: l’espansione surrettizia, senza un mandato democratico, di un progetto oltre i suoi obiettivi originari, nel tempo o nello spazio o in altri aspetti, con il rischio che i possibili successi iniziali spingano ad adottare obiettivi sempre più ambiziosi fino a un inevitabile fallimento finale. […]
L’articolo continua poicon un’analisi limpida circa i limiti di una gestione liberista delle migrazioni.
[…] Migrazioni Senza Frontiere? Economisti neoliberisti e dell’ONU/UNESCO raccomandano una politica di Migrazioni Senza Frontiere […]. Ma a parte la probabile sovrastima dell’effetto propulsivo di questa politica, rimangono tre obiezioni importanti:
1) l’appropriazione gratuita da parte degli immigrati di una quota del capitale sociale del paese di arrivo – comunque definito, come “trust”, solidarietà e stato di diritto, come infrastrutture (strade, trasporti, edilizia popolare) o come istituzioni (sanità, istruzione) – in un mondo dominato dalla proprietà privata del capitale, ossia una situazione altamente contraddittoria;
2) la mancanza di un governo globale che, anche se le Migrazioni Senza Frontiere producessero benefici netti positivi, sarebbe necessario a sovra-compensare chi soffre questa diluizione del capitale sociale e altre perdite dirette;
3) la conseguente segmentazione territoriale della sovranità, che necessariamente assoggetta l’entrata degli immigrati al previo consenso delle popolazioni ospiti. […]
Detto ciò, resta comunque il fatto che, come scrive lo stesso Nuti nel suo primo articolo sul Menabò, le migrazioni sono il risultato di spinte inarrestabili e come tali devono essere trattate, ricorrendo agli strumenti di politica economica a disposizione.
Quell’articolo è puramente descrittivo e offre una fenomenologia dei flussi migratori verso l’Unione Europea in chiave storica e statistica. In particolare, si legge:
[…] Questa intensificazione delle pressioni migratorie in Europa alla metà del decennio in corso ha una pluralità di cause. I rifugiati richiedenti asilo sono aumentati a causa dell’avvio e continuazione di conflitti e persecuzioni […]. I migranti economici, a loro volta, sono andati aumentando per la maggiore possibilità di emigrare, prima impedita da regimi autoritari nel blocco sovietico e da dittature nord-africane ed asiatiche; il divario elevato e crescente fra il reddito nei paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo, soprattutto se ponderato per la probabilità di occupazione (approssimata da 1 meno il tasso di disoccupazione), che nella teoria tradizionale delle migrazioni (esemplificata dal modello di Harris-Todaro) è il movente principale delle migrazioni. Inoltre c’è stata una crescente e sempre più rapida diffusione di informazioni circa la misura di tale divario elevato e crescente, o addirittura la percezione esagerata di tale divario di reddito da parte di migranti potenziali che hanno una visione troppo ottimistica delle opportunità di occupazione e di reddito che si aprono per loro e i loro figli nel paese di immigrazione. […]
Dunque, nel primo articolo, Nuti offre un’analisi delle cause della migrazione e, nel secondo, delle sue conseguenze. In questa terza occasione di confronto intellettuale (purtroppo solo immaginario) con Mario, proveremo ad aggiungere qualcosa a entrambi i temi, partendo dalle cause.
Mario Nuti evidenzia, tra le cause, una visione troppo ottimistica delle opportunità di occupazione che si presentano nel paese di immigrazione. Gli immigrati ‘economici’ arrivano nei paesi di destinazione convinti di trovare buone opportunità di lavoro. Purtroppo, invece, come frequentemente documentato, i lavoratori stranieri sono spesso segregati nei cosiddetti ‘three Ds jobs: Dirty, Dangerous and Demeaning’. Inoltre, anche nel caso in cui abbiano un regolare contratto di lavoro, il salario che ricevono è generalmente più basso di quello di un lavoratore locale. Un recente studio di M. Giannetti, E. Ghignoni e V. Salvucci (“The double “discrimination” of foreign women: A matching comparisons approach”, Economia Pubblica working paper n. 225, 2022) sintetizzato in un articolo pubblicato sul Menabò del 18 dicembre 2022 affronta il tema del divario salariale tra lavoratori nativi e immigrati sul mercato del lavoro italiano, ponendo particolare attenzione anche sulla questione del divario salariale di genere. In tale studio si mostra, per esempio, come l’essere donna e contemporaneamente straniera generi una forte penalizzazione in termini salariali. Infatti, i risultati dello studio mostrano che la quota del divario salariale tra uomini italiani e donne straniere, non attribuibile a differenze nelle caratteristiche demografiche o rilevanti per il mercato del lavoro, tra il 2009 e il 2020, è stato in media del 44,3%, ma ha raggiunto il 46,5% alla fine del periodo. Questa situazione richiede azioni urgenti per migliorare la dinamica dell’integrazione e attenuare il rischio che cresca il consenso verso politiche anti-immigratorie già intravisto e denunciato da Nuti.
Per quanto riguarda le conseguenze, ci concentreremo ora sul punto 1) sopra riportato, ossia l’appropriazione gratuita da parte degli immigrati del capitale sociale del paese ospitante. Parlando di “appropriazione gratuita”, Nuti fa riferimento al fatto che l’arrivo di immigrati con un reddito inferiore alla media dei lavoratori del paese di arrivo comporti la fruizione di beni e servizi pubblici senza contribuzione; o meglio, che la contribuzione netta sia negativa. Infatti, scrive esplicitamente di temere per la sostenibilità dello stato del benessere a fronte di migrazioni di massa.
Per comprendere come i sistemi di Welfare rispondono ai flussi migratori, è necessario esaminare ciascun paese singolarmente. Il quadro normativo, infatti, gioca un ruolo fondamentale nel determinare l’entità o addirittura la direzione del contributo degli immigrati alla finanza pubblica. Questo emerge con chiarezza dallo studio di Mariani et al. (“How do immigants affect local public finances? Evidence from Italy”, CEPR Discussion Paper n. 19596, 2024), sintetizzato sul Menabò del 14 gennaio 2025.
Secondo i risultati dell’analisi, tra il 2008 e il 2015, l’immigrazione ha portato a un aumento dell’avanzo di bilancio dei Comuni italiani (in termini pro capite): le entrate totali sono aumentate a causa della crescita dei flussi stranieri netti e le spese totali non hanno subito una variazione significativa. Questo è dovuto principalmente a un aumento del gettito pro capite derivante dalle proprietà immobiliari, in particolare da quelle non adibite a residenza principale dal proprietario o dai familiari. Dal 2007, le cc.dd. prime case sono, infatti, esenti dall’imposta. L’aumento dei flussi migratori durante il periodo d’analisi ha comportato un aumento della domanda di affitti (regolari) e, di conseguenza, un minor numero di immobili esenti dall’imposta.
In sintesi, ci sarebbe stato spazio per un aumento delle spese comunali, a vantaggio delle comunità locali e dei programmi di integrazione, senza gravare sulla situazione debitoria dei Comuni italiani. Ma ciò non è avvenuto a causa dell’eccessiva austerità delle regole fiscali di quegli anni, le quali imponevano ai Comuni di realizzare almeno un pareggio di bilancio e, in alcuni casi, imponevano direttamente un tetto alle spese totali.
Nuti aveva scritto che le politiche di austerità imposte dall’UE avevano aggravato le conseguenze negative della cancellazione dei confini interni all’area Schengen. Il caso di studio suggerisce una conclusione più forte. Infatti, l’impatto fiscale della migrazione a livello locale non è stato negativo, ma positivo, e questo avrebbe reso sostenibile un sistema fiscale maggiormente redistributivo anche in presenza di flussi migratori crescenti. In generale, e astraendo dal periodo di analisi, ciò risulterebbe più efficace ed etico rispetto a politiche di mero contrasto di un fenomeno che, come lo stesso Nuti sosteneva, è inarrestabile. Sarebbe stato entusiasmante confrontarci a riguardo direttamente con Mario.