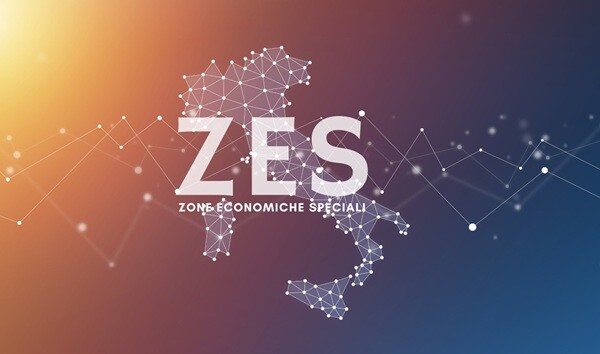Da che pulpito…Il riarmo, il rapporto draghi e la nuova governance dell’industria per la difesa europea
Il 24 maggio 2012 Mario Draghi – allora Presidente della Banca centrale europea – tenne una memorabile lecture nella Facoltà di Economia della Sapienza nell’aula Tarantelli gremita di studenti e docenti, in una giornata in ricordo di Federico Caffè. Fuori dall’aula e dalla Facoltà gli studenti manifestavano contro gli interventi “anticrisi” della Troika, e non molto più lontano – nelle sedi del Governo e dei Ministeri – tali misure assumevano la forma degli indirizzi di politiche economiche determinate da vincoli esterni non pienamente formalizzati (lettera Trichet-Draghi), mentre ancora un po’ più in là, alcuni Stati membri – Irlanda, Portogallo, Grecia – venivano sottoposti ad una rigida condizionalità negoziata nei Memorandum of Understanding, mentre tutti gli altri Stati dell’Eurozona pativano l’ulteriore irrigidimento, introdotto con il Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance (c.d. Fiscal Compact), delle misure del rigore finanziario e dell’obiettivo del pareggio – o “equilibro” ex art. 81.1, Cost. – del bilancio.
Ciò che preme oggi ricordare è un preciso passaggio di quella lezione di Draghi o, per meglio dire, un appello, che dal suo “pulpito” istituzionale il Presidente della Bce ripresentava spesso in quei difficili mesi e anni:nella complessa gestione della crisi del debito nell’Eurozona, l’istituzione monetaria sovranazionale europea soffriva di profonda solitudine, il massimo responsabile del governo europeo della moneta, metteva a nudo la difficoltà di trovarsi privo di un contraltare politico: “La crisi economica e finanziaria ha messo in discussione la convinzione miope che un’unione monetaria potesse rimanere solo tale, senza evolversi verso qualcosa di più stretto, più vincolante dove la sovranità nazionale sulla politica economica fa posto alla decisione comunitaria. Occorre che i governi dei paesi membri dell’euro definiscano in modo congiunto e irreversibile la loro visione di quale sarà la costruzione politica ed economica che sorregge la moneta unica”, (M. Draghi, Facoltà di Economia Sapienza, 24/5/2012). La solitudine del banchiere centrale europeo – di natura ben diversa dalla «solitudine del riformista» che fu del suo maestro Federico Caffè – richiedeva che l’unità monetaria europea potesse essere combinata con una politica economica europea altrettanto unitaria (F. Panunzi, “La solitudine di Draghi e il destino dell’Europa”, in LavoceInfo, 7/3/2014), e i suoi appelli segnalavano che le mirabili acrobazie monetarie del “whatever it takes” (M. Draghi, Global Investment Conference, Londra, 27/7/2012)erano arrivate al massimo della loro estensione e richiedevano, a fronte di esse, un assetto sovranazionale di unità politica.
Nella primavera di crisi del 2012 appariva chiaro che l’integrazione europea nel segno del funzionalismo aveva toccato il limite minimo della sua efficacia, e a renderlo evidente era proprio la massima carica dell’istituzione che più di tutte rappresenta le incongruenze dell’architettura istituzionale dell’Unione europea: una Banca centrale ad impianto federale senza Stato federale, e imbrigliata nelle maglie di un modello funzionalista che, tuttavia, nonostante le contraddizioni, ha favorito l’evoluzione del progetto comunitario in Europa, diversamente destinato a fallire nei suoi tentativi di federalizzazione (agli albori dell’elaborazione del gradualismo funzionalista, cfr. D. Mitrany, A working space system: an argument of the functional development of international organization, 1943).
In quel momento ci si chiedeva cosa sarebbe stato dell’euro da lì a dieci anni, ed era impossibile immaginare che nello stesso arco di tempo il tema dominante sarebbe stato quello del ritorno della guerra sul suolo dell’Europa, che avremmo dovuto fronteggiare urgenze come la difesa comune e il riarmo, e che ci saremmo ritrovati a farlo, ancora una volta, nel quadro di un’immutata griglia funzionalista, ideata proprio da chi allora esternava la necessità di un modello differente: il Rapporto presentato dallo stesso Mario Draghi – ma da un altro “pulpito” – e pubblicato nel settembre del 2024, infatti ripropone un modello di governance tipicamente funzionalista, con l’istituzione di un’autorità sovranazionale per l’industria della difesa comune europea, (The Future of European competitiveness, Part B, In–depth analysis and reccomendations, September 2024, 170), che si collega all’approvazione in itinere del nuovo Regolamento sull’industria europea per la difesa (Propostadi Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per l’industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l’approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa (EDIP), (COM(2024) 150 final, 5/3/2024).
L’istituzione di un’agenzia europea preposta alla promozione e alla regolazione della produzione e del commercio delle armi, in conformità alle recenti politiche europee di riarmo (sul RearmEu si vedano i recenti articoli sul Menabò di E. Paparella e G. Viesti) desta molte perplessità (su questi temi, a favore, cfr. R. Caruso sul Menabò).
Ancorauna volta si applicail metodo funzionalista del trasferimento di specifiche funzioni regolative a livello sovranazionale, benché in questo caso si tratti di una materia, come quella della politica industriale per la difesa, strettamente connessa all’esercizio della funzione di governo. La “difesa” è, infatti, diretta alla “permanenza” di un’organizzazione politica, nonché espressione di un momento c.d. “conservativo”, collegato all’essenza stessa dello Stato per la protezione delle sue istituzioni (G. de Vergottini, 2016; U. Gori, 2016, e Corte cost., 256/1989, che in riferimento alla “difesa” sancisce una nozione di “conservazione della Comunità nazionale”). Appare quindi problematico, in mancanza di una dimensione europea del potere politico, l’innesto di una funzione propria dello Stato come la “difesa”, nel persistente impianto funzionalista europeo.
Peraltro, se già la scelta del supporto bellico all’Ucraina, nell’ordinamento interno ha generato non pochi dubbi di compatibilità costituzionale, riguardo la distonia con il principio costituzionale del ripudio della guerra nella sua natura di “contro-limite” (A. Ciervo, 2022; C. De Fiores, 2022), la marginalizzazione del Parlamento (M. Benvenuti, 2022), la ri-militarizzazione del discorso pubblico (A. Algostino, 2022), anche l’istituzione di una nuova Autorità per l’industria europea della difesa, potrebbe avere un impatto non meno rilevante nei termini di un pregiudizio arrecato al principio pacifista contenuto nella nostra Costituzione (“l’art. 11 non può essere equivocato”, cfr. G. Azzariti, 2022) che, sui principi dell’astensione dall’uso della forza e dell’autotutela degli Stati, dovrebbe realizzare la coincidenza tra fonte costituzionale e fonte internazionale (artt. 11, 52, 78, 87.9, 60.2 Cost., e artt. 2.4 e 51, Carta Nazioni Unite, e G. de Vergottini, 2022), combinandole con le disposizioni rivolte agli Stati non belligeranti e non direttamente coinvolti nel conflitto, per il perseguimento di soluzioni mediante negoziati (art. 33 ss. Carta Nazioni Unite; E. Cannizzaro, 2022)
Per quanto concerne l’ordinamento sovranazionale, si deve inoltre notare che la scelta della nuova regolazione europea dell’industria della difesa (cfr. Proposta di Regolamento EDIP, cit., 5) trova la sua base giuridica nelle disposizioni inerenti la competitività nell’industria (art. 173, TFUE), il ravvicinamento delle legislazioni in relazione al mercato dei materiali della difesa (art.114, TFUE), la cooperazione con paesi terzi (art. 212, TFUE), ma non negli obiettivi del mantenimento della pace, della prevenzione dei conflitti, del rafforzamento della sicurezza internazionale (di cui all’art. 42.1, TUE). Tale impianto normativo sembrerebbe quindi conforme ad un indirizzo di crescita del mercato dei prodotti per la difesa, più che agli obiettivi della sicurezza e della pace per i cittadini europei ad essi garantito dal Trattato (art. 3.1, TUE, artt. 42 ss. TFUE).
Alla luce di tutto questo, si può concludere che perseverare nel modello funzionalista appare anche indicativo di una scarsa capacità (o volontà) di guardare alla storia recente dell’integrazione europea: le “sofferenze” del governo della moneta unica europea privato del contraltare del governo europeo dell’economia, potrebbero riproporsi, e anche in forma peggiore, con l’attuale proposta sull’Autorità europea per l’industria della difesa, deficitaria di una controparte politica a livello europeo, in un settore ad altissimo rischio. In altre parole, se si intende, intraprendere nell’Unione europea una politica industriale rivolta alla difesa comune e quindi al riarmo, è auspicabile che questo avvenga potenziando le sedi di decisione politica sovranazionale, e non soltanto mettendo a punto una nuova regolazione del mercato europeo delle armi.
A tale riguardo, se in questo momento storico qualsiasi riforma istituzionale per l’unità politica europea appare, se non utopica, almeno molto remota, sembra ipotizzabile la soluzione di un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo, analogamente a quanto avviene – o dovrebbe avvenire – per i Parlamenti nazionali, per quello che concerne l’approvazione delle misure in tema di guerra. Tuttavia, dovrebbe trattarsi di un Parlamento europeo diverso da quello attuale –la Commissione Difesa e Industria del Parlamento europeo ha infatti espresso il primo voto a favore del Regolamento EDIP, il 24 aprile 2025 – legittimato attraverso una diversa partecipazione politica transnazionale e quindi il più possibile rappresentativo della volontà dei cittadini europei (art. 10.2, TUE), che potrebbe dirigersi verso istanze di pace, anziché di riarmo e di guerra.