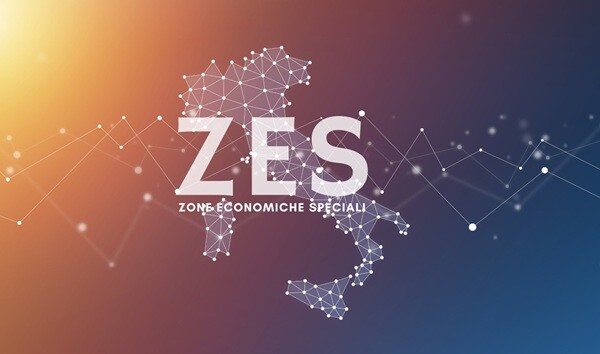Robin Hood non abita a Palazzo Chigi
L’Italia è uno dei paesi europei con la più alta disuguaglianza di reddito familiare. Il picco territoriale delle disparità si registra nel Mezzogiorno, a testimonianza del fatto che lo scarto tra ricchi e poveri è tanto più alto nelle aree dove più estesa e intensa è la fragilità economica e sociale. La Calabria, anche sotto questo aspetto, rappresenta l’estremo tra le regioni europee: il reddito percepito dal quinto dei calabresi più ricchi è 8,5 volte superiore a quello del quinto dei più poveri. A seguire, le regioni Sud-Vest Oltenia in Romania (7,4) e Yugozapaden in Bulgaria (7) (dati Eurostat riferiti al 2023).
Alle disuguaglianze interne a ristrette aree territoriali, si sovrappongono, nel nostro paese, gli storici e acuti divari Nord-Sud in termini sia di reddito sia di povertà e esclusione sociale. Nel 2023, il reddito netto medio familiare nel Mezzogiorno è inferiore a più di un quarto di quello percepito dalle famiglie nel Nord-ovest (30.667 contro 41.811 euro), distanza che diventa ancor più marcata se si considerano le famiglie con figli: in media 34.913 euro al Sud e 52.589 nel Nord-ovest, una differenza di circa 18 mila euro (-33,6%). Tanto più scandaloso è il divario sociale. Il 40% dei meridionali risulta, nel 2024, a rischio di povertà o esclusione sociale, un’incidenza più di tre volte superiore a quella registrata nel Nord, mentre ben 10 su 100 di essi sono afflitti da una severa deprivazione materiale e sociale (meno di 2 su 100 nel resto del paese), cioè non possono, ad esempio, affrontare spese impreviste, permettersi almeno un pasto al giorno adeguato, riscaldare la casa, avere due paia di scarpe decenti (dati Istat).
Il mercato è l’arena in cui si formano le disuguaglianze di reddito, a ragione delle asimmetrie di dotazioni individuali e familiari di risorse reali e finanziarie, di opportunità occupazionali e impiego dei capitali, di rendimenti delle risorse. L’indice di Gini (che come è noto assume un valore compreso tra 0 e 1, ed è tanto maggiore quanto maggiore è la disuguaglianza) riferito ai redditi primari secondo le stime dell’Istat nel 2024 è pari a 0,46 nella media italiana, con un valore superiore (0,48) nel Mezzogiorno e inferiore (0,43) nel Nord. I redditi primari sono quelli conseguiti nel mercato da parte di tutti i membri del nucleo familiare, quindi non tengono conto degli interventi redistributivi dello Stato, attuati, da un lato, attraverso il prelievo delle imposte dirette e dei contributi sociali e, dall’altro, con l’erogazione di trasferimenti monetari alle famiglie (pensioni, sussidi, ecc.).
Grazie a queste politiche pubbliche redistributive, che trasformano il reddito primario in reddito disponibile, la disuguaglianza si riduce a 0,30 in Italia (16,1 punti percentuali in meno), a 0,27 nel Nord (15,8 punti percentuali in meno) e a 0,31 nel Sud (circa 17 punti percentuali in meno). Anche se in forma più attenuata, il gradiente della disparità Nord-Sud ricalca, in sostanza, quello del reddito primario: un chiaro indicatore della maggiore importanza che rivestono le politiche di riequilibrio nel Mezzogiorno, dove nella composizione dei redditi disponibili delle famiglie incidono in misura più rilevante, rispetto al Nord, i trasferimenti verso pensionati, disoccupati, minori, disabili, mentre pesano comparativamente meno i redditi primari.
Le politiche sono dunque determinanti, perché possono accrescere direttamente i redditi delle famiglie più povere, consentendo loro una vita meno deprivata, e determinare così una maggiore equità sociale e una riduzione delle disuguaglianze. Tuttavia, le politiche redistributive, di per sé, non necessariamente consentono di conseguire meno povertà e maggiore equità: l’esito delle misure di intervento dipende dall’entità delle risorse finanziarie mobilitate e, ancor più, dalla loro destinazione. Laddove, infatti, le politiche siano indirizzate a ridurre contributi, oneri sociali e pressione fiscale ai ceti più ricchi in misura relativamente superiore ai trasferimenti ai ceti più poveri, finiscono, paradossalmente, per determinare un aumento delle iniquità piuttosto che una loro riduzione.
Per cogliere l’impatto redistributivo delle politiche per le famiglie realizzate nel 2024 sono utilissime le simulazioni Istat contenute nel rapporto “La distribuzione del reddito in Italia”, pubblicato lo scorso 17 marzo. Nello specifico, le politiche redistributive sottoposte a simulazione sono cinque: (i) la riforma Irpef, che ha modificato aliquote e scaglioni e incrementato le detrazioni da lavoro dipendente; (ii) la decontribuzione parziale per i lavoratori dipendenti; (iii) l’esonero contributivo totale per le lavoratrici madri di due o più figli; (iv) l’Assegno di inclusione (ADI) che sostituisce il Reddito e la Pensione di cittadinanza; (v) l’indennità una tantum pari a 100 euro per i lavoratori dipendenti con un reddito lordo inferiore a 28 mila euro (cosiddetto Bonus Natale). Le simulazioni valutano le differenze tra i redditi delle famiglie a legislazione vigente nel 2024 e i redditi che le famiglie avrebbero percepito nel 2023 non considerando le politiche redistributive del 2024.
Per ciò che riguarda la riforma Irpef e le decontribuzioni, la quasi totalità delle famiglie beneficiare (circa 12 milioni) vede migliorare, in media, il proprio reddito disponibile di 586 euro annui. Tuttavia, gli impatti redistributivi sono alquanto differenziati: per le famiglie appartenenti al quinto più ricco il guadagno è di 866 euro all’anno, cioè un quarto del guadagno totale, mentre il quinto più povero deve accontentarsi di un incremento medio di soli 284 euro (pari ad appena l’8,4% del guadagno totale), con la conseguenza di un ampliamento della forbice tra i redditi dei beneficiari più ricchi e quelli dei più poveri. Le famiglie interessate ad entrambe le misure e che invece subiscono una perdita rispetto a quanto avrebbero percepito se le regole fossero rimaste quelle del 2023, sono relativamente poche (circa 300 mila), ma anche in questo caso il peggioramento, pari in media a 426 euro, interessa in modo più marcato le famiglie relativamente più povere: -496 euro contro -392 euro per le più ricche. Stesso discorso per le famiglie senza lavoratori dipendenti (circa 10 milioni), e pertanto non interessate alla decontribuzione: il guadagno è pari in media a 251 euro all’anno, ma le famiglie del quinto più ricco si giovano di un aumento di 355 euro annui (pari al 44% del guadagno totale); di contro il guadagno di quelle collocate nel quinto più povero è di appena 88 euro (pari a soltanto il 2% del guadagno totale). Anche in questo caso dunque la redistribuzione avvantaggia decisamente le famiglie più facoltose, finendo per accrescere il gap tra queste e le famiglie economicamente più deboli.
Ancora più emblematico è il caso dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione-lavoro (SFL), due misure rivolte intenzionalmente ad integrare il reddito di singoli e famiglie particolarmente povere di reddito disponibile. Sono stimate in poco più di 100 mila le famiglie che traggono beneficio dal passaggio dal Reddito di cittadinanza (RDC) depotenziato, ma ancora vigente nel 2023, all’ADI entrato in vigore il 1° gennaio 2024. Si tratta di famiglie tutte collocate nel quintile più povero e che usufruiscono di un aumento medio del loro reddito disponibile di 1.216 euro annui. Sono invece ben 850 mila le famiglie che peggiorano drasticamente il loro reddito nel passaggio dal RDC all’ADI: oltre 2.600 euro in meno all’anno per le famiglie del quinto più povero. Delle 850 mila famiglie “svantaggiate” dalla riforma, 620 mila sono quelle che hanno perso il diritto al beneficio e le restanti 230 mila peggiorano il proprio reddito in quanto ricevono con l’ADI un beneficio minore di quello che avrebbero percepito con il RDC Per altre 400 mila famiglie il passaggio dal RDC all’ADI non ha comportato alcun mutamento del reddito percepito (sulla penalizzazione delle famiglie povere del passaggio dal RDC all’ADI, il Menabò ha pubblicato numerosi contributi, tra quelli più recenti cfr. Aprea, Gallo e Raitano; Proto; Gallo) .
L’impatto redistributivo dell’insieme delle politiche introdotte nel 2024, in confronto a ciò che si sarebbe osservato se i parametri fossero rimasti quelli del 2023, è stimato dall’Istat in un aumento medio di 458 euro annui dei redditi disponibili delle famiglie, con differenze sensibili però tra i quinti di appartenenza. In particolare, per le famiglie più povere (primo quinto) il guadagno medio (339 euro) è molto più basso che per quelle del quinto più ricco (560 euro). Nel complesso, le prime beneficiano appena dell’8,3% del guadagno totale mentre le seconde ne assorbono ben il 30% circa; allo stesso tempo, il vantaggio di reddito riguarda meno della metà delle famiglie più povere (46,7%), mentre interessa pressoché l’intera platea delle famiglie più ricche (93,4%).
Con riferimento, invece, alle famiglie che peggiorano il loro reddito tra il 2023 e il 2024 (intorno a un milione e 200 mila), il decremento medio è pari a quasi 2.000 euro, con differenze estreme tra i quintili: le famiglie più povere del primo quinto perdono 2.500 euro, quelle del quinto più ricco soltanto 339 euro. Le prime costituiscono il 95% delle famiglie che perdono; le seconde appena lo 0,8%.
In sintesi, i guadagni di reddito sono appannaggio pressoché esclusivo delle famiglie relativamente più ricche mentre le perdite sono riconducibili quasi interamente alle famiglie più povere. Una paradossale redistribuzione a favore di chi sta meglio, che non a caso implica una crescita, seppur leggera, della disuguaglianza in termini di reddito disponibile, puntualmente segnalata dall’aumento dell’indice di Gini.
In contrasto con narratori interessati che cercano di convincerci del contrario, l’Istat certifica che Robin Hood non è al governo.