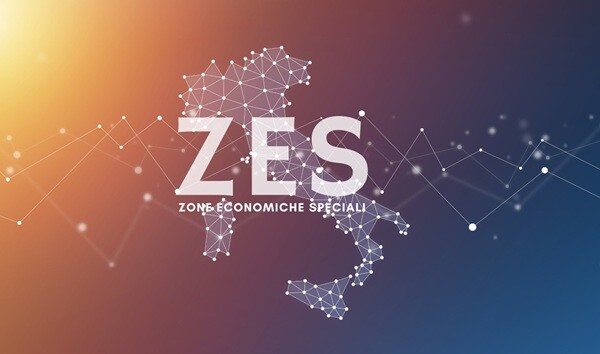Uno stato sociale forte serve anche per scoraggiare le aggressioni
Il riposizionamento degli Stati Uniti nel mondo voluto dal Presidente Trump ha dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio che le società europee dovranno potenziare le proprie difese collettive per scoraggiare potenziali aggressori. Pochi europei gradiscono l’idea di un aumento delle spese militari, ma la maggior parte le considera inevitabili, anzi necessarie per preservare ciò che apprezziamo di più: la nostra democrazia, le nostre libertà e lo Stato di diritto.
Meno chiare sono le implicazioni per quell’altra cosa che noi europei apprezziamo molto: lo Stato sociale. Un’opinione emergente, popolare in alcuni ambienti, è che l’aumento della spesa per la difesa debba necessariamente andare a scapito della spesa pubblica per scuole, ospedali e pensioni.
Rispetto alla linea d’azione che segue questa opinione i suoi sostenitori si collocano in due campi opposti. Da una parte ci sono coloro che optano per la protezione sociale e contro le spese militari. Alcuni di loro assumono una posizione pacifista, preoccupati che l’escalation militare possa portare a un conflitto armato, ma purtroppo incapaci di fornire una risposta convincente alla domanda su come proteggerci, nel caso in cui i nemici dell’Europa si dimostrassero meno amanti della pace di quanto si vuol credere. Altri non nascondono la loro ammirazione per il Presidente Putin, facendo opportunisticamente causa comune con i veri pacifisti professando un sostegno finora insospettato allo Stato sociale e alla “pace”.
Sul fronte opposto si collocano coloro che ritengono che la spesa per la difesa debba aumentare e che per finanziarla bisogna ridurre la spesa per la protezione sociale. La maggior parte dipinge i tagli al bilancio del welfare come una spiacevole conseguenza della ricerca angosciata di spazio fiscale. Una minoranza sembra considerare questi tagli come fine a sé stessi, un correttivo a lungo atteso a uno stato sociale troppo generoso che ha indebolito, e persino evirato, le società europee, e quindi accoglie con favore la prospettiva di un suo ridimensionamento che porrebbe fine all’eccezionalismo europeo e renderebbe l’Europa più simile agli Stati Uniti.
Ad esempio, un recente articolo di Bronwen Maddox, direttore di Chatham House, ha sostenuto che “alla fine, i politici dovranno convincere gli elettori a rinunciare ad alcuni dei loro benefici [sociali] per pagare la difesa”, mentre un paio di settimane dopo, in un articolo dal titolo eloquente “L’Europa deve tagliare il suo stato sociale per costruire uno stato di guerra”, l’editorialista del Financial Times Janan Ganesh ha spiegato “cosa evocherebbe un continente più militarizzato e meno assistenzialista: la superpotenza che si sta allontanando da esso”, cioè gli Stati Uniti”.
Nonostante le conclusioni diametralmente opposte, nessuna delle due parti sembra mettere in discussione il dilemma benessere/difesa: entrambe danno per scontato che la scelta dell’uno o dell’altro sia ineluttabile.
Ci permettiamo di dissentire. Contrapporre il welfare alla difesa è cattiva politica. È facile immaginare come questo possa fare il gioco dei populisti anti-UE e dei nemici dell’Europa. Il Presidente Putin si starà sfregando le mani. Ma l’intera narrazione secondo la quale l’Europa si troverebbe di fronte a una scelta apparentemente inevitabile, tra proteggere il suo modello sociale e rafforzare le sue difese, non è solo infelice dal punto di vista politico; è anche infondata dal punto di vista empirico.
Nel nostro libro (Who’s afraid of the welfare state now?, 2024) sosteniamo che lo Stato sociale è parte integrante di ciò che rende l’Europa un luogo così attraente per lavorare, vivere, crescere una famiglia, godere delle libertà, e perseguire la felicità. Sono tutti beni per i quali vale la pena lottare. Ecco perché, anche se nel breve periodo la necessità di scoraggiare le aggressioni e di proteggere le nostre libertà limiterà lo spazio fiscale disponibile per ambiziose riforme degli investimenti sociali di cui l’Europa ha bisogno, nel medio e lungo periodo il trade-off tra difesa e welfare non si applica più: lungi dal consumare risorse scarse che potrebbero essere meglio impiegate per soddisfare esigenze più pressanti, uno Stato sociale ben finanziato contribuisce in modo cruciale alla resilienza delle democrazie liberali.
L’Europa ha avuto un decennio e mezzo a dir poco difficile. L’ossessivo perseguimento dell’austerità ha fatto sì che la ripresa dalla crisi finanziaria globale sia stata meno rapida e meno decisivo di quella degli Stati Uniti sotto il presidente Obama. E poi, naturalmente, è arrivato il Covid. Eppure, per quanto si parli di stagnazione europea in netto contrasto con il dinamismo americano, il tasso di occupazione nell’UE (70,8% nella fascia di età da 16 a 65 anni) è inferiore solo di un punto percentuale rispetto a quello degli Stati Uniti (71,9%). Nel Nord Europa, dove lo stato sociale è più solido – e sì, più costoso – il tasso di occupazione è molto più alto della media statunitense. Ad esempio, nei Paesi Bassi è 82,3%, in Danimarca è 77,2%, in Norvegia è 77,1% e in Svezia è 76,7%, mentre nella stessa Germania è 77,4%. Alla faccia dell’alta spesa sociale come ostacolo alla crescita.
Ciò che gli ammiratori della società di mercato oltreoceano dimenticano opportunamente di menzionare è il terribile spreco di potenziale umano derivante dall’incapacità di proteggere e nutrire i gruppi vulnerabili. I non occupati in Europa tendono a essere lavoratori in cerca di un lavoro, pensionati precoci, o madri (e, sempre più spesso, padri) in congedo parentale. Un numero sproporzionato di non occupati negli Stati Uniti sta scontando una pena detentiva, oppure è malato cronico, o è dipendente da oppioidi e altre sostanze nocive. In Europa, gli operai che perdono il lavoro a causa dell’automazione o perché la loro azienda non è riuscita a competere con quelle cinesi, ricevono non solo un indennizzo ma anche una riqualificazione, che offre loro la possibilità di passare a un lavoro migliore. Negli Stati Uniti, si riterranno fortunati se troveranno un lavoro in un magazzino di Amazon o in un negozio di alimentari: la maggior parte getta la spugna, abbandonando la forza lavoro e cadendo nell’inattività (si vedano Dorn e Hanson, 2015 e Nedelkoska, 2013).
Lo spreco di capitale umano, che nei momenti migliori è un enorme fallimento, rischia di risultare fatale in un’epoca caratterizzata da sfide immense: dall’invecchiamento della popolazione alla lotta ai cambiamenti climatici, dalla gestione dell’automazione e dell’IA alla riduzione del rischio di aggressioni. In questo contesto, l’inserimento nel mondo del lavoro del maggior numero di cittadini e la possibilità di rendere ciascuno di loro il più produttivo possibile diventano un imperativo. E come possiamo ottenere tutto questo se non con un’efficace formazione permanente, un’assistenza sanitaria universale e solide reti di sicurezza sociale – quello che chiamiamo “investimento sociale”?
I critici non riescono a capire è che la spesa sociale non riguarda solo la redistribuzione: mira anche a prevenire lo spreco di capitale umano, investendo nella salute e nelle competenze dei lavoratori, attuali e futuri; così come mira a eliminare la “penalizzazione della maternità”, facendo sì che tutte le madri che desiderano lavorare possano farlo (si vedano, ad esempio, Goldin, Kerr e Olivetti, 2022 e Kleven, Landais e Leite-Mariante, 2023).
Ma anche la redistribuzione, se fatta bene, può migliorare i risultati economici: garantendo che il potenziale di ciascuno sia valorizzato, impedendo la trasmissione intergenerazionale di povertà e privazioni paralizzanti, alleggerendo lo stress mentale che costringe i poveri a prendere decisioni sbagliate. La riduzione della povertà non è solo il segno di una società attenta, di cui gli europei sono giustamente orgogliosi: promette anche un buon ritorno economico.
Sono tempi eccezionali, ed è proprio per questo che dovremmo mantenere i nervi saldi. L’Europa ha dei punti di forza; uno stato sociale solido e apprezzato che investe nel capitale umano è uno di essi. Farle mancare le entrate fiscali sarebbe un regalo ai nemici dell’Europa. Dovremmo invece mantenere (e modernizzare) l’assistenza sociale e le prestazioni pensionistiche, e investire generosamente nella salute, nell’assistenza all’infanzia, nel congedo parentale, nell’apprendimento permanente, e nell’assistenza a lungo termine.
Chi è propenso a pensare che questo non sia un buon momento per parlare di investimenti sociali, dovrebbe ripensarci. Dopotutto, neanche l’inverno del 1942, quando il destino della Seconda guerra mondiale era ancora in bilico, sembrava un buon momento per discutere della costruzione di un sistema di protezione sociale. Eppure, è proprio quello che fecero le truppe britanniche impegnati nella guerra, in molti convegni improvvisati a pochi chilometri dal fronte. Il Rapporto Beveridge, fresco di stampa ad opera del Ministero dell’Informazione, fu meticolosamente presentato dagli ufficiali e letto avidamente dai soldati. Come ricorda Mackay (2002), Brendan Bracken, Ministro dell’Informazione, “autorizzò la massima pubblicità, compresa una conferenza stampa e una trasmissione radiofonica, e chiese all’Ufficio dell’Esercito per gli affari correnti di rendere il Rapporto una lettura obbligatoria per i gruppi di discussione organizzati dei militari. Il motivo era che ci si rese conto che ‘il Rapporto sarebbe servito come una brillante arma di propaganda contro il suo omologo, Goebbels’”. Gli scettici al War Office e altrove dovettero ammettere che coltivare l’aspettativa realistica di un ordine sociale postbellico più equo diede effettivamente impulso allo sforzo bellico, anziché distrarlo.
Gli scettici dovrebbero prenderne atto.